i fatti risalgono al 2005
1. L’Africa chiama
Mi chiamo Davide, ho 27 anni, sono originario di Reggio Emilia, terra di delizie culinarie e buon basket. A chi mi chiede come mai ho scelto di venire in questo continente tanto misterioso rispondo sempre allo stesso modo: “È stata l’Africa a scegliermi, e non viceversa”.
Lavorando in pubblicità già da qualche anno, la mia testa è ormai impregnata di slogan, frasi celebri, rime baciate. Prometto di non abusarne. In realtà il vero motivo che mi ha spinto fino al lontano Mozambico è uno e uno soltanto: il lavoro, appunto. Mi considero uno dei tanti giovani (e nel mio caso non certo geniali) cervelli in fuga dall’Italia. Dopo quasi quattro anni di tanta gavetta, discrete soddisfazioni e magri stipendi presso una brillante agenzia della mia città, e al termine di una mediocre stagione sportiva in C1, decido di fuggire dalla monotonia e dagli stili di vita che l’Italia mi stava imponendo. In sella alla mia vecchia BMW raggiungo Lisbona, capitale portoghese, dove Cecilia si trovava per motivi di studio grazie al programma Erasmus. Grazie ad una serie di circostanze fortunate vengo assunto dalla sede locale di una delle principali agenzie del settore pubblicitario. Non passa nemmeno un anno che un’agenzia africana, la prima del continente nero ad aggiudicarsi il prestigioso Leone d’Oro a Cannes (una sorta di Oscar della pubblicità) mi offre un ottimo contratto. Due settimane dopo il primo contatto telefonico con il mio nuovo capo sono in volo alla volta di Maputo, capitale del Mozambico.
Mi vedo come in un film, inquadrato mentre osservo fuori dall’oblò del boeing che mi ha sbalzato qui in poche ore. L’immensità e il mistero dell’Africa lo si percepisce sorvolandola in aereo. Noi, abituati a volare tra miriadi di cittadine che sembrano infinite ragnatele illuminate sotto i cieli europei, osserviamo increduli e spaventati l’oscurità sottostante. Osservo ciò che non è altro che uno sconfinato mare nero, fatto di deserti e giungla. Il ventilatore gira sul soffitto e cerca di alleviare la mia solitudine, rinfrescandomi il corpo e ipnotizzando la vista. Vorrei dormire per poi svegliarmi in una città amica, che mi conosce e mi saluta quando esco per strada, una città che ospita persone che mi vogliono bene. Purtroppo so che non accadrà. Sono arrivato da soli due giorni, mi hanno consegnato chiavi, telefonino, una busta con alcune banconote in valuta locale e mi hanno salutato sotto casa. In quel momento la domanda sorge spontanea: “E adesso?”. Poi però, un rigurgito di orgoglio e spirito di autoconservazione: “Però, guarda qua dove sono finito, ho un nuovo universo da scoprire!”
Dopodichè il buio cala. Manca l’acqua, le zanzare infestano la camera da letto, il frigo è vuoto, non c’è nessuno da invitare a bere una birra. E allora ci si butta sul letto con un buon libro e si aspetta il sonno. Speriamo arrivi presto. Un attimo prima di assopirmi penso: “Magari domani cerco un campetto e forse faccio amicizia…”.
2. O mulungu joga maningue!
La Escola Tecnica Comercial nasconde un vecchio campetto con tabelloni di legno, retine squarciate da schiacciate furiose, un fondo di cemento scivoloso, reso spesso incandescente dai raggi del sole che si riflettono tra le linee consumate. Nulla di speciale all’apparenza, nulla di speciale per sei giorni su sette, durante i quali riceve poche visite, perlopiù studenti e balordi al tramonto. Ogni sabato questo squallido campetto vede affluire diversi giocatori della capitale e l’atmosfera prende vita ricreando l’atmosfera del playground a stelle e strisce, magari solo un po’ più sgangherato. Le radio ammaccate e gracchianti che a tutto volume trasmettono solo ed esclusivamente pezzi rap ed hip-hop, accecanti collane d’oro sfacciatamente finto brillano al sole. Chiunque arrivi si presenta con una nuova coreografia per “dare un cinque”, mentre commenti roventi accompagnano il passaggio di qualche studentessa.
È in questo simpatico quadretto abbrustolito dal sole che il sottoscritto si presenta da perfetto sconosciuto, forte di un pallore che solo l’inverno europeo sa creare, con una tenuta che ricorda più un arbitro di calcio che un cestista. Il look è molto importante anche a queste latitudini, la gente di città è molto stilosa, o almeno cerca di esserlo. Magari le scarpe ai piedi avranno i buchi, ma sono scarpe da basket, non da tennis. Le maglie che indossano non saranno originali e non sono certo le ultime sul mercato, ma sono quelle di LeBron e Kobe. Mi siedo a bordo campo e cerco di capire come funziona, chi comanda, chi è meglio non far arrabbiare, chi è disposto a corrispondere un sorrriso. In campo un mulatto molto magro che ricorda vagamente Penny Hardaway detta legge unendo spettacolarità, cattiveria e incisività. Applaudo i suoi assist, la mia grande passione! Scopro il suo nome: Serginho. Sarà lui, dopo aver vinto l’ennesima partita, a invitarmi con un cenno a mostrare le mie capacità con la palla a spicchi. Quindi come in ogni playground che si rispetti, dopo aver atteso almeno due ore prima di mettere piede in campo, ecco finalmente arrivare il mio turno. Peccato che nessuno voglia giocare in squadra con me. Chi conosce le leggi dei campetti sa come funziona. Le squadre si formano a bordo campo, la regola è “chi vince regna”, per cui i migliori tendono a formare squadre che garantiscano loro di giocare più partite. Di conseguenza nessuno vuole giocare con uno sconosciuto, per di più bianco.
Passano alcuni istanti imbarazzanti. Ma ecco che timidamente, dalle retrovie, compaiono questi due buffi soggetti, disposti a tutto pur di mettere piede in campo, persino a giocare nella stessa squadra del “mulungu”. Questa parola di origine Bantu indica l’uomo bianco, la si sente pronunciare spesso, il più delle volte viene usata in tono dispregiativo. I miei due compagni occasionali sono senza dubbio i “paria” del campetto, quelli che nessuno sceglie e tutti deridono. Sono piccoletti, grassottelli e malvestiti. La partita ha inizio, si vince a 12. Serginho mi guarda subito in cagnesco: è da un po’ che non prendo in mano un pallone, il palleggio è incerto, i passaggi poco calibrati, i tiri fuori bersaglio. Allora, da buon playmaker, cerco di mettere i miei due compagni in condizione di tirare da liberi. Niente da fare. Mentre in difesa ce la caviamo, in attacco non si segna.
Passano i minuti, la partita si incattivisce, io mi scaldo bene e cerco di recuperare feel-ing con il mio sport. Palleggi rapidi e finte per disorientare l’avversario, penetrazione per attirare su di me due difensori e assist per due punti facili da sotto canestro di un compagno. Serginho è stanco, ha già vinto diverse partite e il sole picchia forte, si innervosisce con i propri compagni, non riesce a penetrare, gli lascio lo spazio per tirare, nei campetti all’aperto è sempre difficile segnare da lontano, specie se le gambe iniziano a fare male. Fortuna vuole che mi entrano due “bombe”, e così ci troviamo con la palla in mano per vincere. Lo schema è il solito: tutti aperti per lasciarmi spazio per l’uno contro uno, se mi chiudono scaricherò per un tiro dalla media distanza.
Inizio il mio tanto amato ball-handling (da piccolo il mio idolo in NBA era Isiah Thomas, un vero maestro di questo fondamentale), cambio velocità, batto Serginho e punto dritto al canestro. Il lungo della squadra avversaria si interpone tra me e il ferro. Il mio compagno ha l’intuizione di tagliarmi alle spalle seguendo la mia penetrazione. Io stacco da terra, con il lungo che si prepara per stopparmi, ma la palla sparisce. Con un passaggio no-look servo il mio compagno che insacca facilmente. Abbiamo vinto!
I miei compagni increduli corrono verso di me per darmi un cinque di gratitudine, per la prima volta giocheranno due partite di seguito! Serginho mi guarda, sorride e rivolgendosi al gruppo esclama: “O mulungu joga maningue!” Chiedo il significato della parola “maningue”, vuol dire “molto”. “Il bianco gioca molto bene!”. Questo complimento è il lasciapassare per la comunità del playground.
Scrutando gli sguardi di approvazione dei presenti mi si apre il cuore: da oggi, almeno al sabato, mi sentirò un po’ meno solo.
3. Provino
Dopo la prima settimana di ambientamento sul posto di lavoro, arriva finalmente il weekend successivo, così mi ripresento al campetto della Escola Tecnica Comercial, dove vengo accolto come un habitué. C’è anche Serginho, che mi prende da parte e inzia a farmi domande sul perchè mi trovo a Maputo, quanto tempo penso di fermarmi, se faccio già parte di una squadra. Con un mix di sorpresa e gratitudine accetto di fare un allenamento con la Conseng, la squadra capitanata proprio da Serginho. Ci accordiamo per martedì sera.
Nel frattempo fortunatamente il nuovo lavoro mi appassiona e mi impegna molto, così la solitudine mi attanaglia solo quando scende la sera, nonostante abbia diversi piccoli coinquilini, perlopiù zanzare e baratte. Finalmente arriva il grande giorno: fortunatamente ho messo in valigia un paio di Nike reduci dai playground portoghesi, che abbinate a pantaloncini e tshirt, mi rendono cestisticamente presentabile. Il campo di gioco della Conseng è quasi peggio del playground descritto fin qui: circondato da palazzi squallidi, prima di tutto non è coperto, inoltre ha molto spazio intorno, per cui i punti di riferimento si limitano ai pericolosissimi sostegni dei canestri, due pali di ghisa piantati a 15 cm dalla linea di fondo, ovviamente senza la minima protezione; il fondo è costituito da un asfalto irregolare, mi ricorda una di quelle strade secondarie dimenticate dalle amministrazioni provinciali; l’impianto d’illuminazione è costituita da due fari piazzati esattamente dietro a ciascun canestro, così quando si tira frontalmente si ha l’impressione di vivere un’esperienza mistica e intravedere il Nirvana; i palloni sono talmente consumati che se fossero ricoperti di sapone liquido scivolerebbero meno. Ma tutto ciò non conta, quando varco la linea bianca mi sento a casa: la forza dello sport è anche questa.
Vengo presentato al coach, che mi ricorda tanto Lou Grosset jr. in “Ufficiale e gentiluomo” con l’unica differenza che invece dello slang americano, per esprimere ciò che pensa usa lo “changana”, il dialetto parlato nel Mozambico meridionale. Per fortuna Serginho mi traduce in portoghese quegli strani suoni! Vengo presentato agli altri giocatori, che mi osservano manco fossi un elefante fucsia.
L’allenamento inizia: treccia a 5, tiro a coppie, 3 contro 3 a onde, le solite cose. Il coach mi mangia con gli occhi, finalmente un base (playmaker in portoghese) che a volte rallenta e fa giocare la squadra, parla, porta blocchi, aiuta in difesa scalando e recuperando. Per chi viene da una buona scuola di basket tutto ciò può sembrare scontato ma mi accorgerò presto che in Mozambico rappresenta una vera rarità. E in più posso dare sfogo agli istinti da Harlem Globetrotter mettendo in mostra il mio piccolo repertorio di passaggi strambi! Sarà che dopo quasi venti anni di rimproveri, flessioni e docce anticipate ho trovato chi mi apprezza?
Dopo un’ora di allenamento la serietà e l’impegno della squadra diminuiscono bruscamente. Nello spazio adiacente al campo ha fatto la sua comparsa un folto gruppo di ragazze che iniziano a riscaldarsi prima di iniziare il proprio allenamento di pallavolo. I miei compagni non resistono e, nonostante le urla del coach, un paio di miei passaggi centrano in pieno il naso del pivot, particolarmente rapito dalla palleggiatrice. Da queste parti gli istinti sembrano davvero incontrollabili e la sessualità è vissuta con maggior leggerezza, sia dagli uomini che dalle donne. La poligamia non è riconosciuta dalla legge ma, di fatto, esiste. Ho assistito a “ganci” imbastiti per strada, conclusi con la neonata coppia andarsene felicemente mano nella mano verso una pensione a ore!
La prima volta che sentirò parlare delle finali nazionali non sarà per l’emozione di vincere il titolo, bensì per trovarsi per un’intera settimana al centro dell’attenzione di centinaia di “gajas”! Il coach ferma l’allenamento: è furioso, sembra davvero un ufficiale dei marines che richiama il proprio plotone. Si scaglia contro un paio di giovani (tutto il mondo è paese), li spintona, li colpisce con un pallone, sospetto voglia far colpo sul sottoscritto e mostrare tutta la propria leadership. Alcuni compagni se la ridono di nascosto ma l’ordine viene ristabilito e si può concludere l’allenamento. Un dirigente della squadra mi chiama da parte chiedendomi se voglio firmare il tesseramento per il campionato. Preso di sorpresa, non so cosa rispondere ma l’istinto mi dice di aspettare qualche giorno, per capire meglio come funzionano le cose. Il dirigente, che ha l’aria di chi se la passa piuttosto bene, confessa di non poter offrirmi molto, al massimo alcuni mobili per arredare la casa. Resto a dir poco spiazzato dalla possibilità di ricevere un rimborso anche in questo contesto, in ogni caso prendo tempo e mi congedo ringraziando.
L’aria della sera è calda e secca, il vento asciuga in fretta il sudore, poco male perchè il campo della Conseng non è fornito di docce, per cui m’incammino sulla via del ritorno assieme a un gruppo di compagni che ascoltano rapiti e increduli i racconti sui due anni in cui da bambino ho giocato con Kobe Bryant…
4. Desportivo arrivo!
Nei giorni successivi continuo ad allenarmi con la Conseng resistendo agli assalti del dirigente che a ogni seduta mi si materializza davanti sventolandomi in faccia il cartellino da firmare. Parlando con alcuni colleghi che seguono il basket scopro che in città vi sono diverse squadre più competitive: Academica, Costa do Sol, Desportivo, Ferroviario e Maxaquene sono le società più blasonate, e anche se non ne conosco il livello, vorrei togliermi la curiosità di confrontarmi con i migliori giocatori di Maputo. Una sera, dopo aver raccolto l’invito del mio capo, grande appassionato di basket, gioco un 5 contro 5 a tutto campo con ex-giocatori sulla cinquantina. Scoprirò che tra i giocatori di questa partita vi sono diversi dirigenti del Desportivo, gloriosa società polisportiva fondata dai portoghesi ai tempi della colonia. La mano di alcuni di loro è davvero “educata”, ma le mie gambe corrono il doppio e naturalmente faccio un figurone. Proprio uno di questi ex-giocatori mi contatta il giorno seguente proponendomi di fare un allenamento di prova con la prima squadra, a cui manco a dirlo serve un play. Ci accordiamo per la sera stessa: non aspettavo altro!
Dalla qualità dell’impianto di gioco mi accorgo subito di essere in una società di prestigio: campo coperto (anche se aperto ai lati), tribune sui quattro lati, fondo in parquet, palloni seminuovi, illuminazione più che discreta. Quando entro in campo ci sono già diversi giocatori in fase di riscaldamento. Uno di loro, con treccine rasta e bicipiti alla Van Damme, si avvicina sorridendomi e si presenta. È Siade, il capitano della squadra che mi dà il benvenuto. Nonostante lui faccia di tutto per farmi sentire il benvenuto, ancora una volta vengo squadrato con diffidenza e una punta di disprezzo. In fondo la cacciata dei bianchi è avvenuta appena trent’anni fa e, sebbene qui in Mozambico non sia stata particolarmente violenta, gli europei non hanno certo lasciato un buon ricordo. Ed ecco il coach, che mi stringe calorosamente la mano: si fa chiamare “Pitcho” e, a differenza del tecnico della Conseng non sembra un “marine”, piuttosto un trombettista jazz sovrappeso dell’America anni ‘30.
L’allenamento ha inizio. Dopo un anno sabbatico in Portogallo in cui ho giocato solo al playground, lontano da palestre e palazzetti, gioco con molta più disinvoltura rispetto all’Italia, dove la passione per il basket si era indebolita per vari motivi, soprattutto perchè la “routine” mi stava schiacciando e il basket ne era parte integrante, senza darmi in cambio soddisfazioni degne di tale nome. Con la testa sgombra, quasi per magia i passaggi dietro la schiena vanno a buon fine e le finte di palleggio lasciano sul posto i difensori. Mi trovo particolarmente bene con due o tre compagni che si fanno trovare liberi sugli scarichi. Dopo le giovanili, il mio gioco è sempre stato più orientato a servire al meglio i compagni piuttosto che cercare la soluzione personale e qui decido di continuare su questa linea, dato che il mio primo obiettivo, che è anche quello più arduo, è di essere accettato dai compagni. Nonostante qualche contatto duro, dai “cinque” che mi arrivano pare proprio che ci stia riuscendo: la sensazione è bellissima e, udite udite, da oggi si ripeterà tre giorni alla settimana visto che… ho passato il provino!
5. Spogliatoio
Avendo una concezione piuttosto romantica del basket, ho sempre cercato qualche motivo in più del semplice giocare che mi spingesse ad andare in palestra tutti i santi giorni. In cima a questi motivi si trova senza dubbio il convivio dello spogliatoio, un luogo che per quanto squallido, sporco e maleodorante, racchiude in sé qualcosa di sacro.
Tanti anni fa Dino Meneghin, intervistato proprio all’interno dello spogliatoio dell’Olimpia Milano in occasione del suo 40° compleanno, dichiarò che ciò che lo spingeva a continuare nonostante i tanti successi ottenuti e la veneranda età, era proprio il fatto di trovare tra quelle quattro mura piastrellate di bianco un luogo rassicurante dove dimenticare i problemi e ricaricare le batterie. Quale altro luogo angusto riunisce dieci personalità, dieci vite, facendole incontrare, e scontrare, in maniera tanto assidua? E più si scende di categoria, più questo luogo diventa angusto e allo stesso tempo disomogeneo. In Serie A i giocatori conducono una vita in fondo abbastanza simile, i caratteri possono essere molto diversi, ma il tempo libero a disposizione è poco e spesso lo si passa insieme ai propri compagni. Nelle cosiddette “minors” invece si trova di tutto: avvocati in carriera con la seconda casa in collina e operai del turno di notte; exprofessionisti pluriscudettati e presuntuosi sedicenni con il volto ancora ricoperto di brufoli; padri di famiglia esemplari e gigolò; maniaci delle diete e fumatori incalliti; tutti stipati in una stanza, fianco a fianco, a condividere gioie e dolori, voli pindarici e cadute rovinose, vittorie memorabili e cocenti sconfitte.
Anche qui in Mozambico ho ritrovato tutto questo. Ogni giocatore che entra in spogliatoio porta con sè il proprio umore e i propri problemi, che qui sono spesso di carattere economico. Jordão sembra il gemello di Mutombo, ha tre mogli, otto figli, fa il portavalori e arriva sempre distrutto (e in ritardo) ad allenamento per un semplice motivo, vive lontano da Maputo e per mantenere fede all’impegno preso e guadagnare una discreta somma extra è disposto a prendere due “chapas”, i minibus locali, e camminare per una decina di chilometri (avete letto bene: 10 km!). Silvio “Paito” Neves, ex-stella del basket mozambicano sulla via del tramonto, è disoccupato e le uniche entrate per sé, per la moglie e i tre figli sono i 40 dollari mensili che riceve dal Desportivo (un sacco di riso da 50 Kg ne costa circa 25 ed è la base alimentare della maggioranza delle famiglie). Bruno è un tiratore micidiale che lavora in un negozio di sport, alle spalle ha una famiglia tanto facoltosa quanto rigida, che lo ostacola a realizzare il suo sogno: aprire un negozio tutto suo. Samora ha molto talento in campo ma purtroppo non ha passato il test d’ingresso all’università (in tutto il paese vi sono appena due atenei, a fronte di una popolazione che sfiora i 18 milioni di abitanti) e non se ne riparlerà fino all’anno prossimo. Il pivot titolare, Sergio, lavora in un supermercato di proprietà sudafricana, ha un ottimo stipendio da 500 Dollari mensili, con il quale però deve contribuire al sostentamento dei genitori, ormai troppo anziani per lavorare, e dei fratelli che studiano. Nel nostro paese questi problemi comporterebbero come minimo un’insonnia cronica, mentre gli africani hanno una capacità incredibile (e ammirevole) di sopportare situazioni insostenibili e fatiche disumane: una lezione di vita impossibile da dimenticare.
(qui la seconda e ultima parte: https://lagiornatatipo.it/mozambasket-piccolo-racconto-di-una-grande-avventura-sportiva-ii-parte/
















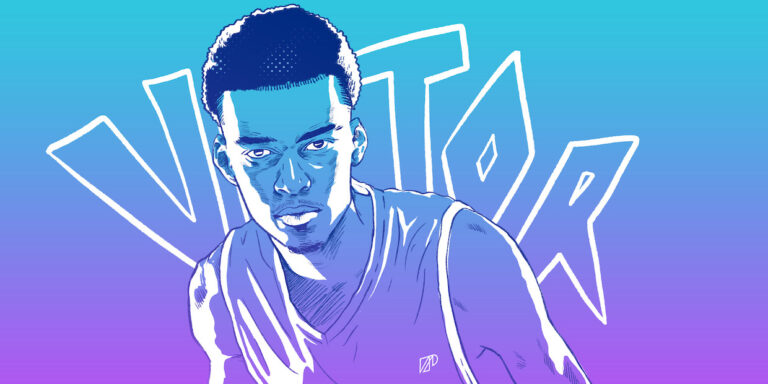








Complimenti per l'avventura e anche per il modo di raccontarla. 🙂
Bellissimo Dave!