di Marcello Natalini
foto di Matteo Marchi
Quello che leggerete non vuole essere un articolo, ma un racconto; come il video che spero abbiate appena visto (e se lo avete fatto vi ringrazio), non voleva essere un insieme di interviste, ma una raccolta di punti di vista e background diversi.
Io sono uno studente di Ingegneria Edile – Architettura a Bologna. Vi chiederete: e che diavolo ci facevi a quasi 10 mila chilometri di distanza da casa, con un microfono in mano, a lavorare come International Correspondent per la NBA Summer League a Las Vegas in Nevada?
I was Commissioner for a day – questa è la risposta.
Ed ero lì a vivere l’ambita esperienza, non troppo lontano dall’Oklahoma, da dove tutto era partito.
Tailgating
“La partita di football inizia alle 18, ci vediamo alle 12 fuori dallo stadio”. Il Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium della OU ha una capienza di 90 mila posti: immaginatevi uno stadio San Siro che si erge al centro di un campus universitario, per 6 partite all’anno.
Io capisco la puntualità, ma presentarsi 6 ore in anticipo, per una partita che dura in media 4 ore e mezza, mi sembrava un po’ esagerato. “Ci deve essere molta fila per andare così presto, vero?!”, chiedo a Mitch e Gloria, i miei host parents, abituato alle tempistiche italiane. “Ma quale fila, andiamo al tailgating” rispondono loro.
Nonostante piovesse, Oklahoma – Ohio State e’ sold out (fila alle 6 di mattina il giorno prima per trovare un biglietto, il “big deal”). Immaginatevi una distesa di tende rosse e bianche, nelle orecchie l’inno dell’università in loop. Per la quantità di carne grigliata, da lontano sembrava ci fosse un incendio che la pioggia non poteva spegnere: solo i litri di birra, usati per giocare a beer pong, avevano una chance. Il tailgating è un pre partita, una festa o semplicemente un momento creato dai tifosi per i tifosi, perché 4 ore e mezza di partita non bastano per divertirsi. Gli studenti, le famiglie e ogni tipo di tifoso si radunano nei pressi dello stadio per allestire i propri tailgate (gazebo) e grigliare, bere e divertirsi con attività inerenti lo sport, appositamente organizzate dal team. Il sindaco di Norman cambia la viabilità del traffico e i poliziotti sistemano tutti i truck pronti a posizionare l’attrezzatura, compresi i divani portati da casa. Finisce 45 – 26 per la squadra ospite, fradicio (e la pioggia c’entra poco) torno a casa in bici con 2 free t shirt usate come cappuccio.
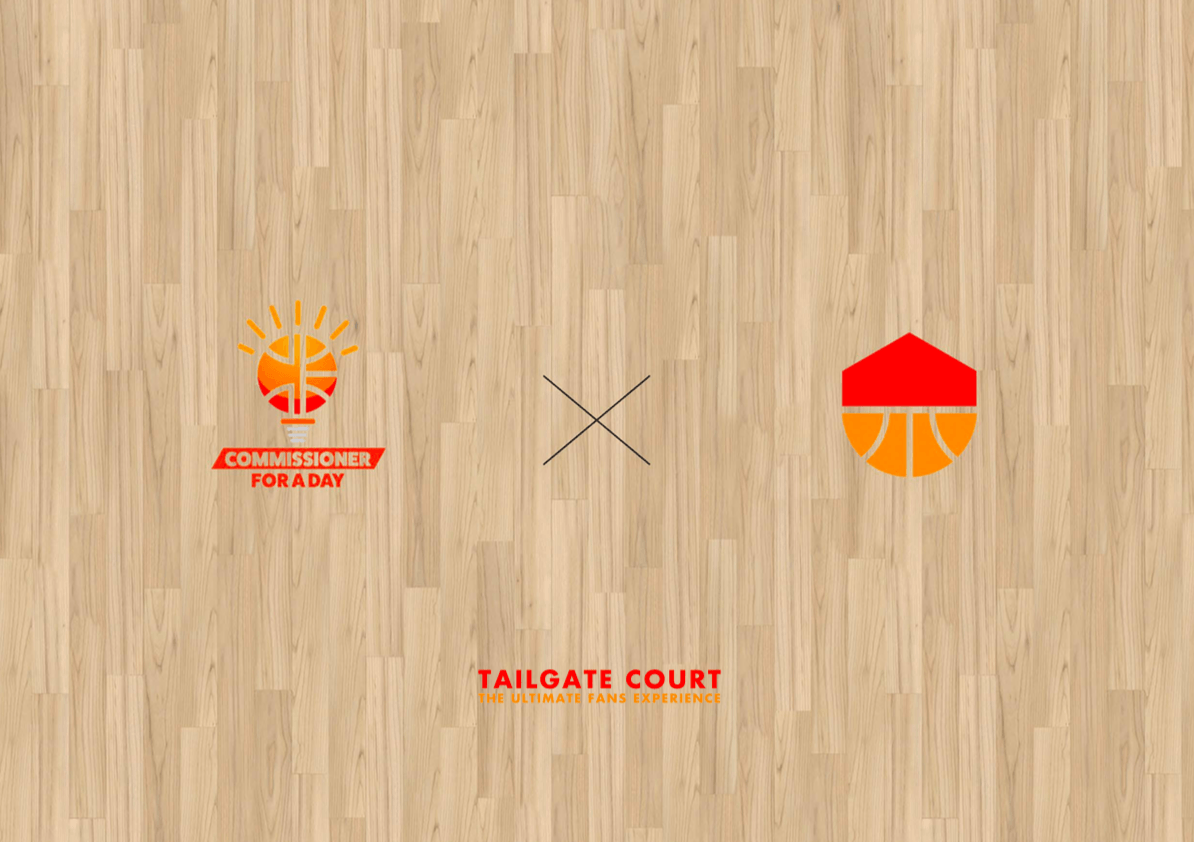
Contest
Passati 2 anni da quella partita, si propone la possibilità di trovare un’idea per il basket italiano grazie a “Commissioner for a day” il contest di Matteo Zuretti e Manuel Riccio. 8 pagine in PDF e un video di 2 min dove mi presento e parlo della mia idea.
Mi prendo 3 settimane durante il mio tirocinio all’università per mettere in piedi un modo per applicare il concetto del tailgating al basket italiano. Dopo qualche notte su Photoshop finisco la presentazione, manca solo il video ma soprattutto mancano solo due giorni. Chiamo Luca, compagno di sconfitte ai concorsi di architettura per allestire un set cinematografico da far invidia a tutta Hollywood: troviamo stranamente il cancello della parrocchia aperto, canestro sullo sfondo, gobbo col discorso scritto 30 min prima, camera accesa e si parte.
3 ore (sì, 3 ore…) per girare un video di 2 minuti, non perché il mio inglese fosse così male, ma perché i giardinieri avevano deciso di accendere le motoseghe a 30 secondi dalla fine di ogni prova. Editing sulla panca del parco con mietitrebbia in sottofondo, video in chiavetta e upload. Speriamo vada bene.
Una decina di giorni dopo arriva la mail di comunicazione che ero tra i 10 finalisti, faccio una Skype call con Manuel e attendo il responso finale della giuria, e che giuria: Flavio Tranquillo, Ettore Messina e Maurizio Gherardini.
“Ti prego di contenere la gioia, ma con 2 voti su 3 la giuria ha scelto te come vincitore di commissioner for a day”.
Urlo impetuoso nei corridoi della facoltà di ingegneria. Contenere la gioia: da rivedere.

“Brooklyn we go hard”
Giusto il tempo di festeggiare 32 volte (una cosa contenuta come l’urlo ad ingegneria) con tutti i miei amici, parenti ecc e si vola a NY. Atterro alle 18 ore locali. Dopo 15 ore di viaggio mi accoglie Manuel: “tra 2 ore abbiamo la cena con Gianluca”. Che poi di Gianluca ce ne sono tanti, ma di Gianluca Pascucci, Director of Global Scouting per i Brooklyn Nets, ce n’è uno solo. Doccia, mezz’ora per decidere quale camicia mettere, altra mezz’ora in metro per pensare a qualche domanda e arriviamo nel quartiere di Dumbo, ad un ristorante di pesce sotto il ponte di Brooklyn. Poteva andare peggio.
Due ore di chiacchiere sull’aspetto internazionale del gioco, sulla notte del Draft vista da dietro le quinte, sull’importanza di creare un “brand” ed una famiglia. Ci salutiamo dandoci appuntamento al giorno dopo, per la visita della facility dei Nets. Uscendo dalla metro a Brooklyn, nella zona delle factories, e passato il trauma del caldo misto all’umidità newyorkese di inizio luglio, la prima domanda che sorge spontanea è: una franchigia NBA qui? Perché? Perché in effetti le factories americane multipiano non hanno un grande valore architettonico, ma se i Nets avevano scelto quella come casa (a parte il Barclays Center) un motivo ci doveva essere.

Building grigio scuro con banner nero al piano alto “HSS Training Center – Brooklyn Nets”: entriamo. Ci accoglie Gianluca, saliamo all’ottavo e ultimo piano dove si trovano alcuni uffici, la media zone, 2 campi regolari, palestra, mensa, zona relax con ping pong e consolle, con ovviamente un rooftop come ciliegina sulla torta. Una delle peculiarità dei Brooklyn Nets sta proprio nel fatto che la franchigia è stata spostata dal New Jersey alla periferia della grande mela ed era di importanza capitale costruire un brand oltre che una squadra. Si è deciso così di recuperare l’ultimo piano di un vecchia factory, preservando l’aspetto tradizionale dell’esterno e riempirla di tutti i comfort all’interno. Parlando con Gianluca poi è emersa l’importanza di tenere i giocatori il più possibile insieme, per creare una famiglia ed un team anche fuori dal campo: per questo gli svariati spazi comuni interni sono forniti di tutti i comfort, con il rooftop e i campi che guardano entrambi sullo skyline di Manhattan.
“In inverno si costruiscono le squadre, in estate i giocatori” ci dice Gianluca. Più chiaro di così non si poteva. Brand love e community queste le parole che rimangono impresse nelle varie chiacchierate con altri membri della franchigia. Aspettando Gianluca, vediamo Jeremy Lin che si allena vicino a noi con altri 3 ragazzi dell’est. Torna con una “bambolina” di Petrovic limited edition in regalo per noi.

Il tempo per le ultime foto insieme, ringraziamenti infiniti, e si torna tutti e quattro a sudare all’aperto col sorriso sulle labbra: io, Manuel e i due piccoli Drazen.
Summer Matters
“E mo’ so ca**i” come direbbe il Libanese, anche se in circostanze molto più “criminali”.
Passato il 4 Luglio nel pieno relax, misto ad un pizzico di delirio che caratterizza Coney Island in quel giorno, vivevo la più chiara e cristallina “quiete prima della tempesta”, perché era venuto il momento di salutare Manuel alle 5 di mattina e dirigersi verso il JFK. Ho vissuto con molta meno ansia il parcheggio per la patente che il volo prima della Summer League.
Senza troppi giri di parole: ero terrorizzato. Non tanto dalla paura del posto nuovo, persone nuove ecc, l’esperienza in Oklahoma aveva aiutato. Ma perché era uno dei più classici appuntamenti al buio, al quale mi ero preparato un po’ così, se vogliamo a sentimento. Settimane prima avevo scaricato e stampato i prospetti del Draft, tutte le bio su draftexpress, e avevo una buona trentina di pagine date da Mitch e Sarah, media seniors per i Nets, con qualche dritta di come si lavora durante la summer league; passano 4 ore e spiccioli, arrivo nella città del peccato. “Un van bianco ti aspetterà al tuo arrivo” ultime parole famose di Rhoda, il capo degli interns. Passa quasi un’oretta buona in compagnia di 42 gradi celsius con 4 ore di sonno, poi in lontananza il candido miraggio nel deserto del Nevada. Mi apre il portellone di un 12 posti Rick, afroamericano di San Francisco. Il tempo di sedermi e prendermi un accidente per i 19 gradi interni al van che salgono in ordine: Jourdan, fanatico di Go Kart e di Twitter; Doug di nome Compton Jr di cognome, ex cestista negli Wildcats del Kentucky e per ultimo Devin, 120 chili from The Bay, uno dei producers per i Golden State Warriors (esatto, ha 3 anelli anche lui).
Con Meek Mill in sottofondo, che a tratti fa esplodere il van, ci dirigiamo subito alla Thomas and Mack Arena, casa dei Runnin’ Rebels della UNLV: Anthony Bennett (ahia) e Larry Johnson (direi un pelo meglio) per citare qualche prodotto di quell’università. Lascio in un angolo la valigia con la bambolina di Petrovic, che da quel momento in poi sarà il mio porta fortuna, per ascoltare chi di Drazen sapeva certamente molto più di me. Perchè 14 anni fa a Warren LaGarie, l’ex agente di Petrovic, e Albert Hall, il suo fidato braccio destro, viene in mente di bussare alle porte della vicina NBA per proporre, diciamo così, un torneo estivo tra le franchigie a “libera iscrizione”. Il primo anno sono 6 le squadre che aderiscono (Boston, Cleveland, Denver, Orlando, Phoenix e Washington) per un totale di 13 partite, fino ad arrivare all’edizione appena passata con 30 team e 82 partite.
Prima riunione con i capi e gli altri ragazzi, giro dell’Arena e distribuzione dei vestiti: 1 paio di scarpe, 8 magliette, 1 sacca, 2 pantaloncini e 12 calze, tutto griffato Nike. Tra i 113 ragazzi che lavorano per la Summer league, dai 18 ai 35 anni, era “abbastanza” riconoscibile il mio compagno di stanza Murat. 33 anni, turco, barbuto, tatuato, responsabile marketing per il Fenerbahce: una di quelle persone che dopo soli dieci giorni insieme ti sembra di conoscere da una vita.

Ci dirigiamo al vicino Palms, hotel dove risiedevamo tutti noi interns, pronti per sistemare le nostre cose, capire quale delle 8 magliette mettere il giorno dopo e dormire, perché il giorno dopo sarebbe iniziato il vero delirio (di paura ce n’era già a palate). Tutte e 30 le franchigie NBA per la prima volta a Las Vegas, 82 partite in 12 giorni, 113 intern, 1 dei quali non ha idea di cosa andrà a fare.
Riunione mattutina, ad ognuno viene assegnato il suo compito. Pochi giorni prima dell’inizio della Summer League ero entrato in contatto con Sergio Milles, il direttore operativo e capo del gruppo social media, al quale avevo espresso il mio interesse di essere parte di quel gruppo. Non avevo però alcuna idea a quale delle mille mansioni che competono a quel gruppo sarei stato assegnato. Sergio e Tracy (secondo boss del gruppo), mi chiedono se volessi occuparmi di Twitter, ma educatamente rifiuto l’offerta. “Camera? Interviste?” chiede Sergio. “Dovresti curare una rubrica sui giocatori internazionali della summer league intervistandone alcuni”. Ci penso ben 2 secondi e accetto. Passano i 2 secondi di carica e penso a tutte le interviste e rubriche che contavo in carriera: zero. E vabbè, un modo lo troverò.
Apro il pc, ricerca frenetica di quanti e quali giocatori internazionali fossero alla summer league, con nazione e squadra di ognuno. Trovo che sono 77 da 40 diversi Stati. Il passo successivo era campionare 5 di questi, i futuri protagonisti della mia feature. In ordine: contattare Dennis, il PR dei Clippers, ragazzo nello staff della summer league, chiedere a lui i contatti ufficiali degli altri PR per organizzare l’intervista, chiamare il cameraman (Ryan Gentry, figlio di Alvin Gentry coach dei Pelicans e ragazzo adorabile) per coordinarsi su orario e luogo. Una volta imparato il processo “bastava” ripeterlo. Così per tutti e 5, anzi tutti tranne Shawn Dawson, il primo.
“La prima volta non si scorda mai” dicono, ed è verissimo. Pochi giorni prima conosco Liron Fanan, riferimento per svariati giocatori in NBA ed Europa tra i quali Dawson. Mi interesso a lui, anche perché giocava per i Nets con i quali avevo già fatto due chiacchiere a Brooklyn e rispolverando le business card di Mitch e Sarah più un colpo di telefono in israeliano di Liron, mi ritrovo con un microfono in mano, davanti a Ryan e di fianco a Shawn. Ripetevo le domande in testa da qualche ora, ma il microfono tremava no stop. Finisco l’intervista, con qualche indecisione, ma contento, tanto al massimo l’avrebbero tagliata, ma ovviamente, come avete potuto vedere, l’hanno messa proprio tutta…
Rotto il ghiaccio, era il momento di proseguire in ordine:
- Elie Okobo, francese dei Suns, 31esima scelta del Draft;
- Mitch Creek, australiano dei Mavs, tatuato e fisico da far impazzire anche i canguri;
- Augusto Lima, brasiliano dei Raptors, un Cristo di Rio di 216 centimetri.

Prima di introdurre il quinto e ultimo giocatore è utile spiegare una cosa, che forse traspare poco dalle televisione: Las Vegas durante la Summer League è una succursale di Los Angeles, sponda Lakers, ancora di più dopo la vittoria dell’anno passato col tormentone Lonzo Ball e Kyle Kuzma. L’idea era quella di pescare un pesce internazionale giallo viola un po’ più grossino, e un tedesco dal passato a Michigan faceva a caso mio: Moritz “Mo” Wagner. C’era solo un problema: lo stesso giorno sarebbe arrivato nell’arena non un pesce più grosso, ma tutto il mare praticamente, alla sua prima apparizione in purple and gold. Il PR dei Lakers cerca di farmi capire in tutti i modi che era, diciamo, un “pochino” impegnato in altro per quel giorno, ma che forse qualcosa si poteva fare.
LeBron James arriva poco prima della partita delle 13. Si ferma il palazzetto ad osservarlo: pantaloni gialli con marchio “LAKERS” in viola e t-shirt bianca, LeBron XV Purple ai piedi. Volano i numeri di Twitter e Jourdan, quello del van, sogna un nuovo go kart. Mi apposto nel tunnel per aspettare Wagner nel post partita. Passa il Re e per un attimo si ferma anche la donna delle pulizie, per poi riprendere ognuno con i suoi compiti ed io ricordo di avere un’intervista.
Dopo 4 giocatori e grazie all’aiuto di un Mo Wagner simpaticissimo e disponibile come pochi, finisco la mia feature, pronto a festeggiare la sera. Tempo di proseguire nel solito giro di routine attorno al concorse per aiutare i ragazzi e incontro Ettore Messina e Maurizio Gherardini, entrambi giudici del contest, quest’ultimo conosciuto pochi giorni prima all’international coaching clinic. Il coach mi chiede anche se avessi un piatto di tortellini, ma di bolognese a Las Vegas c’ero, purtroppo o per fortuna, solo io. Dopo 12 giorni ho conosciuto ogni singolo ragazzo dei 113 dello staff, 6 PR di squadre NBA, svariati allenatori ed agenti, fans da tutto il mondo e costruito la mia feature sull’aspetto internazionale del gioco ed avevo capito perché dal primo giorno mi dicevano che l’estate conta (Summer Matters). Tempo di salutare tutti, bere qualche birra per festeggiare ed è già tempo di tornare a NY dove Manuel e Matteo mi stavano aspettando.
NBPA
Quando un giocatore NBA firma il contratto con la sua squadra automaticamente entra anche a far parte di un’altra associazione, la National Basketball Player Association, per farla breve, il sindacato dei giocatori. Il giorno dopo l’avventura a Las Vegas, mi incontro con Manuel e insieme ci dirigiamo nel cuore della grande mela, dove hanno sede gli uffici dell’NBPA. Lì ci aspetta Matteo, per il giro della facility e breve storia dell’associazione. Fantastica cura degli spazi interni con alternanza di ambienti collettivi di socializzazione, con altri più intimi e di relax per il singolo giocatore: l’ottica di utilizzare uno stesso spazio per diversi usi, come ci illustra Dan Gladstone, 15 anni nei NY Knicks, dal campo da basket che può diventare un piccolo centro congressi o uno spazio multiuso per i bambini durante i camp estivi. Rimango impressionato, anche dopo aver chiacchierato con Oliver Costamagna, di Think 450, nuovo braccio for-profit creato da qualche tempo per la tutela dell’immagine dei giocatori: sul come bisogna sempre lavorare con e per il giocatore, ma anche relazionarsi con grandi enti e società, per garantire il massimo risultato.

Dopo 4 ore in NBPA era giunto il momento di salutare Matteo e tutti i ragazzi che avevo conosciuto per dirigermi a Bryant Park ed incontrare un altro Matteo, che non conoscevo ancora, ma al qualche dovevo già qualcosa. Si, perché è grazie ad una storia di Matteo Marchi, il fotografo sportivo mio vicino di casa, che avevo scoperto il concorso e poi quello che è successo lo sapete già. Ma anche le cose belle hanno una fine e bisognava tornare a casa: ultimo pranzo con i ragazzi italiani su Park Ave, salutando di corsa, in ritardo per il volo, mi lancio su un taxi, sapendo e volendo che quella non fosse la fine, ma solo un inizio.

Keep Moving Forward
Mi porto nel cuore forse l’esperienza più intensa della mia vita, per come è iniziata e per come non voglio che finisca. In un momento come quello che sta passando negli ultimi anni la pallacanestro italiana, la possibilità data a giovani ragazzi da questo contest, anche solo per il fatto di poter esprimere un’idea, instaurerà, certamente con i dovuti tempi, un discorso attorno al mondo della palla a spicchi tra le nuove generazioni, vogliose di dire, vogliose di fare. Reputo l’esperienza e il lavoro sul campo il migliore dei premi, per provare le cose sulla pelle e capire le dinamiche dall’interno. Quando sei catapultato in un mondo nuovo, senza nessuno che ti può aiutare, (come dicono gli americani, quando esci dalla tua “comfort zone”), la tua voglia di fare è l’unica cosa che ti porta a imparare, conoscere e crescere come professionista e come persona.
Ho imparato e mi sono divertito molto, e tutto partendo da un video fatto in parrocchia con i falegnami in sottofondo: così sono diventato the commish, ovvero il 2018 NBA Summer League International Correspondent.







Bravissimo, tanti complimenti per l’esperienza e in bocca al lupo per le prossime!
Pazzesco
Complimenti per il lavoro e per avere condiviso la tua bellissima esperienza!
Sei grandeeeee