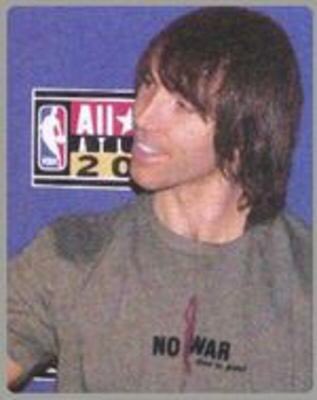illustrazioni grafica di Paolo Mainini
articolo di Valerio D’Angelo e Marco Munno
Era il 1991.
In Sudafrica, con l’abolizione delle ultime leggi razziali, terminò l’Apartheid.
Arrivò la mazzata decisiva per la carriera di Diego Armando Maradona, uno dei più geniali calciatori mai esistiti.
Iniziò la Guerra del Golfo, la prima, con Bush padre protagonista (mentre nella seconda lo sarà il figlio).
Tim Berners-Lee lanciò il primo sito internet della storia, dando il via alla rivoluzione del World Wide Web.
I Guns’n’Roses rilasciarono il doppio album Use Your Illusion, il cui tour promozionale divenne il più lungo nella storia della musica rock.
Una serie di eventi importanti, perlomeno nei rispettivi campi, ma che sembrano disgiunti l’uno dall’altro. E invece, un qualcosa che nella loro varietà in qualche modo li unisce, c’è: si tratta di uno dei migliori playmaker ma visti su un parquet, all’anagrafe Stephen John Nash, ma per tutti semplicemente Steve.
Questo successo, che si sommava alla medaglia d’argento ottenuta nello stesso anno nelle Universiadi con la maglia del Canada, tuttavia non solleticò eccessivamente le fantasie dei vari college; per Steve le offerte non arrivavano. D’altronde, un mezzo come internet per far circolare rapidamente le informazioni su quelli che non erano i prospetti principali non era ancora a disposizione, essendo appunto appena nato; per far conoscere le qualità di Steve, il suo coach alla St.Michaels University School, il signor Ian Hyde-Lay, fece girare delle videocassette con le gesta del canadese. L’unico a prestargli attenzione fu coach Dick Davey di Santa Clara, che rapito da quanto visto, volle subito constatare che anche in carne ed ossa Nash fosse in grado di realizzare le stesse giocate. Risposta affermativa, e col timore che qualcun altro lo notasse, se lo accaparró il prima possibile: aveva capito di avere di fronte un fenomeno. Sebbene di fianco avesse un piccolo asterisco: “Eh, quella difesa non è un granchè…”

Una sottostima delle sue qualità a cui, tutto sommato, Nash era già abituato. D’altro canto, nella nazionale juniores del Canada, era stato tagliato nel 1990 da coach Ken Olynyk, il padre dell’attuale giocatore degli Heat, Kelly, dall’acconciatura coi capelli lunghi ispirata proprio dal taglio di Nash durante i suoi anni migliori. Manco a dirlo, anche Kelly è nato nel 1991. A proposito, dicevamo delle sue connessioni con alcuni degli eventi peculiari di quell’anno, partendo dal collegamento con il Sudafrica e l’Apartheid. Infatti, la nazione di nascita di Steve non è quella canadese, ma quella sudafricana, prima dell’allontanamento da Johannesburg deciso dalla famiglia per il rifiuto delle leggi razziali in vigore. Famiglia composta da madre gallese e padre inglese; fu quest’ultimo, nato nel distretto londinese di Tottenham, a trasmettergli la passione viscerale per gli Hotspur.
Una passione che, al gol di Lucas Moura nel sesto minuto di recupero a chiudere la rimonta contro l’Ajax nella semifinale di Champions League di due anni fa, lo spinse alle lacrime in diretta tv
Il calcio è stato ed è tuttora parte importante della vita di Steve. Proprietario di minoranza dei Vancouver Whitecaps della MLS (dalla loro nascita del 2011), nella sua “battaglia” per rendere più famoso il calcio negli USA, e del Maiorca della Liga (dal 2015, insieme al proprietario ai tempi dei suoi Suns, Robert Sarver), ha ereditato l’amore per il calcio dal padre, ex giocatore, così come accaduto al fratello Martin, arrivato fino alla Nazionale canadese dove ha collezionato 30 presenze. E anche Steve, se ci si fosse dedicato, sarebbe con buone probabilità diventato un professionista; dopo l’inizio tardivo però scelse il basket, dove con la sua genialità e le sue intuizioni divenne un’icona per il gioco del suo periodo storico e di un’intera nazione (nella quale fu, tra le altre cose, tedoforo alle Olimpiadi Invernali del 2010 di Vancouver, primo giocatore NBA di sempre insignito di tale onore). Da qui, il parallelo con Diego Maradona, in una sorta di raccolta di ideale testimone quale simbolo non proprio “stereotipato” ma sospinto dal talento cristallino, in grado di ispirare una generazione, diventando una delle personalità più influenti del mondo (non a caso, inserito tra i migliori 100 dal Time nel 2006).
A differenza di Diego però, lo stile di vita non fu così pieno di eccessi. Non inganni la foto:
Quella immagine che ispirò al nostro Valerio la domanda su Reddit a cui lo stesso Steve, qualche anno fa, rispose in prima persona.
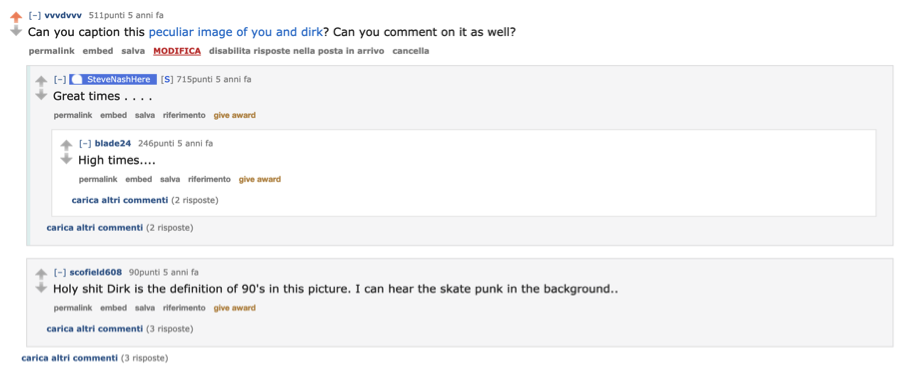
Riguardo a questo scambio poi ci fu anche un’altra domanda, che legava Steve a Dirk:

Già, il rapporto con Nowitzki. Colui che a Dallas gli divenne complementare, lo Yang per lui che era diventato lo Yin, uscito finalmente dall’anonimato delle prime stagioni NBA. Nella Lega, difatti, nonostante il periodo molto positivo coi Broncos al college (dove, oltre ad essere diventato leader di tutti i tempi per assist, triple segnate e percentuali ai liberi, si fece notare per i 6 liberi consecutivi negli ultimi 31 secondi coi quali, da testa di serie numero 15, eliminò nella March Madness del 1993 i Wildcats numero 2), non ebbe da subito fortuna. Selezionato con la quindicesima scelta, provocò malumore tra i fan delusi dalla scommessa fatta dai Suns su un giocatore senza esperienza in una Conference di livello al college. Nello stesso ruolo la concorrenza poi era folta, con Kevin Johnson, Sam Cassell e Jason Kidd ad occupare lo spot di playmaker, con un curriculum ben più valido di quello del canadese. L’assistente Donnie Nelson però credeva ciecamente nel suo talento, e dopo averne caldeggiato la scelta da parte di Phoenix, una volta passato ai Maverick, da vice general manager, si fiondò nell’ufficio del suo superiore per suggerire la trade: il general manager e coach di Dallas, Don Nelson, da buon padre considerò la proposta del figlio, prima di innamorarsi lui stesso dei colpi di genio di Nash, perfetto nell’interpretare in campo i suoi dettami in combinazione con Nowitzki.

Dirk & Steve furono ambasciatori di una pallacanestro piena di energia ed entusiasmo come il nuovo proprietario della franchigia, Mark Cuban; di fianco al veterano Michael Finlay, il tedesco faceva da braccio armato con il suo fisico e il suo fade-away e il canadese da mente dalle folgoranti illuminazioni. Il loro pick-and-roll diventava un’arma sempre più efficiente, con la loro abilità individuale a crescere tanto quanto la loro amicizia fuori dal campo.
A proposito di “fuori dal campo”, non si può non citare come Steve, molto impegnato nel sociale, non sia mai stato timoroso nell’esprimere i propri punti di vista e le proprie opinioni. Come nel 2003, quando a scoppiare fu la seconda guerra del Golfo, dopo quella del 1991: all’All-Star Game dello stesso 2003, il secondo nella sua continua ascesa nelle gerarchie della Lega, si presentò con una maglietta dal motto “No war – Shoot for peace” che gli valse il rimbrotto “Just shut up and play” da Skip Bayless, antesignano dello “Shut up and dribble” rivolto quasi tre anni da Laura Ingraham a LeBron James.
Tornando alle gesta in campo, ciò che le difese non furono in grado di fare nei confronti dei di Nash e Nowitzki, riuscì al salary cap. Fu quello infatti a fermare la coppia di Dirk e Steve, quando quest’ultimo andò in scadenza di contratto e non si vide offrire da un Cuban dubbioso sulla sua longevità ad alto livello (viste le 30 primavere raggiunte) un accordo della stessa lunghezza di quello proposto dai Suns.
Si concretizzò quindi il ritorno in Arizona: stavolta, però, a Phoenix l’astro al centro del sistema solare era lui. Se il compare tedesco in Texas rivoluzionò il ruolo del lungo, il canadese scosse le fondamenta dell’intero gioco, sovvertendo alcuni dei precetti ritenuti basilari nel basket. Con le sue magie, Steve mutava ciò che aveva intorno, segnandone l’evoluzione. Con lui, la frenesia offensiva divenne flusso; la soluzione estrema del tiro da lontano divenne un’arma fondamentale per scardinare le difese; la mancata specializzazione di un giocatore in un certo ruolo divenne versatilità; la formula per superare l’avversario non recitò di subire un punto in meno ma di segnarne uno in più. Il contesto che coach D’Antoni gli aveva creato intorno lo vedeva capopopolo di una rivoluzione nell’interpretazione della pallacanestro, direttore di un’orchestra che suonava una musica mai ascoltata prima, ma che non poteva non coinvolgere chi la sentiva.

Per due volte consecutive si fregiò del titolo di miglior giocatore della Lega, diventando il primo non statunitense (escluso il naturalizzato Hakeem Olajuwon) ad essere eletto MVP. Scrisse a lettere cubitali il proprio nome nell’elenco delle migliori point guard di sempre, settandone nuovi standard; lo fece proprio nel posto dove originariamente non trovava spazio, con un altro playmaker parallelamente a iscriversi alla stessa lista.
Fra le tante gare eccezionali giocate da Steve Nash, forse proprio quella in cui era contrapposto al Jason Kidd leader dei Nets è diventata quella più rappresentativa, per il modo diverso ma ugualmente eccellente di interpretare il medesimo ruolo.
In comune c’era la visione di gioco, che riusciva a individuare linee di passaggio non colte da nessun altro; se Jason però, fisicamente più massiccio, riusciva ad essere presente in difesa e a rimbalzo, preferendo sempre prima la soluzione di un compagno a quella personale in attacco, Steve riusciva a rendersi pericoloso nella conclusione (soprattutto fuori dalla linea dei tre punti) tanto quanto nell’assistenza, profilandosi come arma offensiva totale.
Quel memorabile duello si conclude dopo due supplementari, in una delle partite dal maggior score complessivo di sempre: i tabellini personali recitarono 42 punti + 13 assist per Nash, 38 punti + 14 assist + 14 rimbalzi per Kidd in un confronto in cui per primi, a vincere, furono coloro che assistettero allo spettacolo.
Non sempre coloro che inaugurano un percorso nuovo sono i migliori nel percorrerlo. Se però non arrivarono i titoli sul campo per Phoenix, quello di pioniere per una concezione alternativa di pallacanestro non può essere tolto a Steve. Ciò che successivamente è accaduto ai Warriors di Curry, versioni “migliorate” rispettivamente di quei Suns e di quel Nash, ovvero mettere titoli in bacheca, non riuscì alla franchigia dell’Arizona. Fiera avversaria di Spurs e Lakers nell’agguerrita Western Conference dell’epoca, si avvicinò alla gloria senza mai riuscire ad afferrarla; e proprio con la squadra gialloviola Nash ebbe l’ultima occasione per mettere l’anello di campione al dito. Kobe, che nei Suns di Nash aveva indicato i veri rivali dei losangelini nel corso degli anni, ebbe in squadra il deus ex machina di quel sistema; tuttavia, il trio di filosofi del gioco composto anche con Pau Gasol, oltre ai muscoli di Dwight Howard, vide Padre Tempo quale principale oppositore, col conseguente peso degli infortuni sempre maggiore per le stelle.
A 41 anni, con oltre 10000 assist smazzati (come solo altri 5 giocatori nella storia della NBA all’epoca del raggiungimento del primato) e quattro -più di tutti- presenze nel club del 50-40-90 (quello composto dai giocatori ad aver raggiunto in una singola stagione almeno il 50% nel tiro da 2, almeno il 40% nel tiro da 3 e almeno il 90% dalla lunetta), Steve Nash appese le scarpette al chiodo. Concludendo così il personale lunghissimo tour sui campi da gioco, costellato da passaggi magici, intuizioni geniali, giocate da illusionista: pochi appellativi potrebbero riassumerlo meglio come l’Use Your Illusion preso “in prestito” dai Guns’n’Roses.
E chiusa l’esperienza da giocatore, pochi mesi dopo, sempre nel 2015, è iniziata la sua carriera allenatore: consulente part time dei Warriors prima e ora (dopo aver meritatamente avuto il suo posto nella Hall of Fame della NBA) il ruolo da head coach nei Nets, in cerca di qualcuno che sappia armonizzare il gioco delle sue stelle, così come a Steve riusciva in campo coi propri compagni. Una “nuova vita”, una seconda fase del proprio percorso nel mondo della palla a spicchi, tutta da verificare, in cui rimettersi in discussione cercando di non adagiarsi sui traguardi già raggiunti: d’altronde, a proposito di anni peculiari nella sua storia, l’inizio della “seconda fase” dei Guns con Axl Rose e Slash di nuovo insieme venne annunciata proprio a fine 2015…