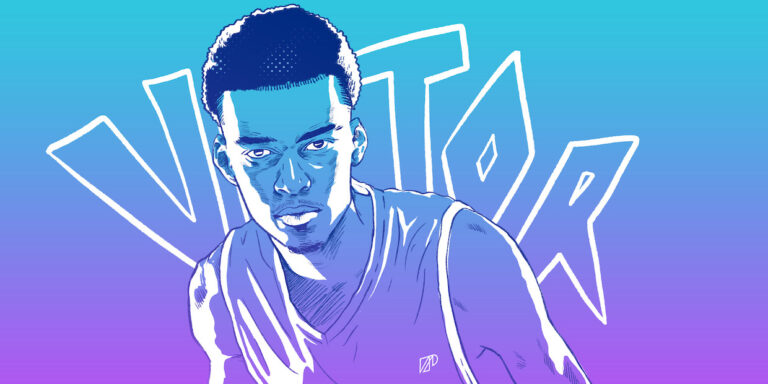di Davide Romeo
Se c’è una cosa che ha caratterizzato gli ultimi anni, si tratta della definitiva esplosione del politcally correct. La tendenza ad evitare ogni potenziale offesa nei confronti di qualunque categoria di persone ha pervaso molti ambienti sociali, incluso lo sport.
Esclusi i social…
L’NBA, ovviamente, non è estranea a questo processo. Non solo molti elementi di spicco della lega, da LeBron in giù, hanno preso posizione contro il presidente meno politically correct della storia, ma è ormai estremamente raro che un giocatore NBA si renda protagonista di un episodio socialmente controverso senza essere immediatamente ostracizzato.
Eppure, proprio in una giornata come questa, 39 anni fa nasceva l’ultimo grande personaggio controversial della NBA moderna.
La vita e le opere di Ron William Artest iniziarono al Queensbridge Houses, quando vide la luce come il primogenito di sei fratelli, in un contesto familiare non proprio benestante.
Il Queensbridge è infatti il più grande complesso residenziale di case popolari nel Nord America, nato per dare rifugio a famiglie – principalmente appartenenti a minoranze etniche – dal reddito medio basso, e gli Artest non facevano eccezione.
Ron trascorse dunque la sua infanzia in edifici con le mura privi di intonaco, con qualche scarafaggio nel bagno e con spacciatori e/o affiliati alla malavita come vicini di casa.
Nonostante tutto ciò, Ron ha sempre avuto un grandissimo attaccamento per il quartiere che gli ha dato i natali, dove ritorna ogni estate e spesso organizza tornei. Durante il suo stint con i Kings ha indossato il numero 93 sulla canotta perché gli ricordava le lettere QB di Queensbridge.
L’ambiente in cui è nato e cresciuto fu certamente decisivo nel formare il carattere del piccolo Ron, che fin da bambino era sì giocoso ma anche estremamente prono agli scatti d’ira. Si cacciava spesso in risse con altri ragazzini e la madre, esasperata, lo portò dunque da uno psicologo per aiutarlo a superare questo suo malessere. Al ragazzino fu suggerito di dedicarsi allo sport per sfogare la rabbia che portava dentro.
Due episodi segnarono molto il giovanissimo Ron Artest. La morte di un amico durante una partitella fra ragazzi: venne pugnalato alle spalle con la gamba rotta di un tavolo, al culmine di una discussione sul punteggio. E la morte della sorella Quanisha, ad appena qualche mese di vita, quando il nostro era quindicenne e in piena adolescenza. Da allora Ron promise a stesso che avrebbe migliorato le condizioni di vita della sua famiglia ad ogni costo, per non provare più una simile sofferenza. Capì in fretta che la pallacanestro, che aveva da sempre giocato nei campacci del Queens e da poco a livello liceale, era l’unica strada per raggiungere questo obiettivo.
Durante gli anni del liceo Ron giocò con Lamar Odom ed Elton Brand nei Riverside Church Hawks, la squadra giovanile AAU più dominante della decade. Nel 1996 realizzarono un record di 69 vittorie e una sola, fastidiosissima, sconfitta contro il Team California di Baron Davis e dei fratelli Collins, Jason e Jarron.
Si pensa che il trio formato da Artest, Brand e Odom sui campi degli high school fosse secondo solo ai New Jersey Patterson di Kobe Bryant, Rip Hamilton e Vince Carter. Ma questa è un’altra storia…
Artest dominò anche nel programma sportivo liceale del suo liceo. Nel 1997, suo anno da senior, fu la star della compagine del La Salle Academy che totalizzò un record di 27-0, fu convocato per il McDonald’s All American e nominato miglior giocatore dello stato di New York. Fu anche nominato miglior giocatore di New York City, ma dovette condividere il premio con tale Heddrick McBride.
Durante il periodo al college ha tentato di laurearsi prima in arte e poi in architettura, abbandonando però entrambe le materie. A suo dire ha completato il corso di studi e ottenuto il major in matematica, anche se difficilmente può esserci riuscito prima dell’approdo in NBA avendo trascorso solo due anni (da cinquanta vittorie e diciannove sconfitte) al St.John’s.
Ron afferma, inoltre, di essere un grande giocatore di dama e di non aver mai perso una partita. È così improbabile, dopo tutto?
Poco dopo essere stato selezionato dai Bulls con la 16esima scelta al Draft, Ron cercò di trovare lavoro come impiegato presso un locale Circuit City: la catena di negozi di elettronica forniva infatti ai dipendenti uno sconto sui prodotti in vendita e Artest voleva usufruirne. Lo sappiamo perché mise Jerry Krause come referente, e quelli del negozio chiamarono Jerry Krause.
Il suo sogno era quello di essere scelto dai Knicks che però scelsero alla 15 il centro francese Weis, quello che vide da vicino le palle di Vince Carter. La prese con filosofia dichiarando «Sono contento di non essere andato a New York. Li odio i fottuti Knicks».
Gli anni di Chicago furono facilmente dimenticabili, perché quei Bulls post Jordan erano veramente poca cosa: mai più di 21 vittorie stagionali finché Ron fu a roster. Il nostro all’epoca beveva whisky all’intervallo (!) e fece a botte con l’ex compagno di AAU Elton Brand – probabilmente per futili motivi – ma nelle prime due stagioni recuperò 271 palloni, superando un record stabilito precedentemente proprio da Micheal Jordan.
Quando His Airness, in maglia Wizards, realizzò proprio contro i “suoi” Bulls il punto numero 30.000, segnando il secondo libero assegnatogli dopo un fallo su tiro di Artest, il nostro la prese benissimo e tirò un pugno al tavolo degli ufficiali di gara, quasi sfondandolo.
Il Ron Artest a Indiana era arrivato a mettere circa una ventina di punti più cinque assist più cinque rimbalzi a partita, il tutto rallentando notevolmente il miglior esterno avversario di turno. Poi ci fu quella famosa nottata di Detroit che tutti conoscono. Era il 19 novembre 2004, Detroit-Indiana. La partita volgeva al termine con la vittoria di Indiana praticamente già in tasca. Artest fermò Ben Wallace con una mannaiata. Ben Wallace lo spintonò, Artest non rispose e decise di provocarlo sdraiandosi sul tavolo degli ufficiali di campo. Inziò il delirio: un ragazzotto ebbe la bellissima idea di lanciare un bicchiere pieno addosso a Ron il quale salì sugli spalti scatenando una rissa tra decine di persone. A dargli man forte Jermaine O’Neal e Stephen Jackson. Piovvero squalifiche, 86 partite per Ron (playoff compresi), 5 milioni di dollari di stipendio in fumo e una condanna a 60 ore di servizi sociali.
Quando anni dopo gli domandarono cosa avesse imparato da quell’episodio, la risposta fu “I don’t lay on tables no more.”
Nove mesi prima del Malice Ron Ron si era presentato ad allenamento col solo asciugamano attorno alla vita, per ricordare a tutti di rilassarsi.
E un anno prima dell’asciugamano era stato sospeso per tre gare per aver sfasciato delle telecamere dopo una sconfitta contro i Knicks, per essere coerente nell’incoerenza.
A proposito: in un’intervista ha dichiarato di essere contrario al sesso occasionale e in un’altra occasione ha consigliato a dei giovani atleti di “stare concentrati e non dare confidenza a donne che non conoscono”, però poi si è fatto beccare a tentare un maldestro sexting con una fan ventenne dell’Ohio. Con tanto di foto del pene, da antesignano Draymond Green.
Dimenticavo: la notte prima del Draft non si presentò all’appuntamento del “Rookie meeting” perché si svegliò troppo tardi dopo aver passato tutta la notte ad ubriacarsi in compagnia di una prostituta.
Tornando al basket giocato, nel 2005 notoriamente tentò di limitare un Paul Pierce con la mano caldissima tirandogli giù i pantaloncini, ottenendo solo l’ennesima tripla in faccia. Al loro successivo incontro Ron gli chiese sobriamente scusa in mondovisione.
Ron inziò a corteggiare i Lakers quando era ancora in Texas e si era rasato le parole “Houston” e “Rockets” sulle tempie in vista dei playoffs. Nello specifico, si presentò a Kobe Bryant nello spogliatoio dopo l’eliminazione alle Finals contro i Celtics per offrirsi di aiutarlo a vincere un titolo. Mentre Kobe era nudo sotto la doccia.
Subito dopo aver firmato con i Lakers scelse la maglia numero 37, in onore alle 37 settimane in cui il singolo Thriller di Micheal Jackson (che era deceduto da poco) era rimasto in cima alle classifiche. Poi festeggiò andando in spiaggia a Playa del Rey e si unì ad un barbecue di una famiglia filippina, finendo a giocare a monopoli e a mangiare halo-halo, un dolce tipico simile alla granita. Tutto regolare.
Con i Lakers vinse il titolo e non solo dominò nella gara decisiva, ma fece lo stesso nella conferenza stampa post partita La prima persona che ringraziò fu il suo psichiatra. Il resto godetevelo per l’ennesima volta.
Ron ha sempre sostenuto di non aver colpito intenzionalmente James Harden in occasione della famosa gomitata, ma di aver “esagerato” con la celebrazione del canestro che aveva realizzato poco prima. Dopotutto “an elbow is just a bent arm with some ambition”.
In compenso Artest non si fece sfuggire l’occasione di commentare un errore decisivo di Harden – uno sfondamento su LeBron James – durante le Finals di quell’anno, twittando un perentorio “All beard, no brain”.
Qualche tempo prima di questo episodio, Ron aveva cambiato nome (dopo alcuni ritardi burocratici dovuti a multe non pagate) in Metta World Peace. Il primo termine, che fungeva da nome proprio, era un vocabolo buddista il cui significato corrisponde ad “amorevolezza”, mentre il cognome era sostanzialmente uno spot per ispirare i giovani fan dei Lakers a lottare per la pace nel mondo.
Prima di tornare, recentemente, al suo nome di battesimo, Ron aveva cambiato nome una seconda volta in The Panda’s Friend, in occasione del suo ingaggio in CBA con i Sichuan Blue Whales.

A suo dire ha scelto questo nome in onore della cultura cinese e della squadra in cui avrebbe giocato, che si trovava in una regione spesso simboleggiata dall’animale. Inoltre, gli piacevano i panda, quindi perché no?
A 36 anni è venuto a giocare in Italia, a Cantù, annunciando il suo arrivo con due tweet: “Whatever you can do I Cantu better” e “Can you play ball? I Cantu”.
A proposito delle multe non pagate menzionate poc’anzi: durante il periodo a Los Angeles ha preso una multa mentre guidava in strada una Indycar, il veicolo con cui si corre la 500 miglia di Indianapolis e che può raggiungere picchi di velocità superiori ad una monoposto di Formula 1. Paradossalmente però la multa non riguardava né un eccesso di velocità né un’illegalità di fondo dell’atto, ma semplicemente per una scadenza dell’immatricolazione o del libretto di circolazione.

L’account Twitter di Ron è una fonte inesauribile di gag, perle di filosofia spicciola e sentenze ermetiche. Talvolta si esprime riguardo al gioco della pallacanestro (Basketball is a simple game. Put the ball in the hoop) mentre altre volte prende posizione su argomenti importanti: pochi giorni fa ha deciso e comunicato che avrebbe iniziato a mettere like ai propri tweet.
Di recente ha suggerito di introdurre una regola che consenta a chi commette fallo l’opzione di chiedere scusa e abbracciare il giocatore che lo subisce, ottenendo l’annullamento degli eventuali tiri liberi assegnati. E se il giocatore avversario rifiutasse l’abbraccio, dovrebbe ricevere un tecnico per comportamento antisportivo.
Non è chiaro se sia una delle sue criptiche gag o no.
Oggi Ron è uno degli assistenti ai South Bay Lakers, in G-League, ma si tiene impegnato fuori dal campo – come ha sempre fatto – con l’agenzia sportiva che gestisce insieme al fratello e con la sua etichetta musicale Tru Warier (sic!), tramite la quale aveva composto un album rap hip-hop nel 2006 che gli costò anche due partite di sospensione perché chiese ai Pacers un mese di “aspettativa” per seguirne l’uscita.
Pare che spesso compia opere di beneficenza a Queensbridge e, in generale, a New York City senza pubblicizzarle troppo. È però noto che ha venduto il suo anello di campione NBA – il suo unico anello vinto, con tanto di nome e volto impresso nel gioiello – e donato il ricavato della vendita a due ospedali pediatrici di Long Island.
Più di 100 giorni complessivi di sospensione, 77 falli tecnici, 8 espulsioni, 7 diverse canotte indossate, 4 inserimenti nel primo e secondo quintetto difensivo, 3 nomi, una presenza all’All Star Game e un titolo NBA: questi sono i numeri della carriera di Artest, terminata quasi in sordina un paio di stagioni fa, e trascorsa tra alti e bassi professionali. Ma come cantava Ronan Keating nel 2000, proprio durante la prima stagione da pro di Ron Artest, life is a rollercoaster, just gotta ride it.