Alameda County Coliseum di Oakland, luglio 1977. Il caldo torrido che molesta la California si dissolve contro il visibilio delle cinquantamila persone che cantano e battono le mani sulle note di “Stairway to Heaven” dei Led Zeppelin. La stessa “scalinata verso il paradiso” cominciata qualche mese più tardi, ottobre, da Paul figlio di Lorraine e George Pierce.
Nasce ad Oakland, città in cui si mastica parecchio baseball: ci sono gli Athletics di Reggie Jackson e di Catfish Hunter, uno dei più grandi pitcher passati per la California, protagonisti di uno storico “threepeat” tra il ’72 e il ’74, con la conquista di tre World Series consecutive. Ma, nonostante la popolarità e l’entusiasmo che vivevano attorno a questo sport, Paul non riuscì mai ad avvicinarvisi, per varie ragioni.
Lorraine è sola, George, il padre, non c’è (e per la verità mai c’è stato) e Paul non l’ha mai conosciuto. Però è una donna intraprendente, e decide di cambiare aria. Insieme ai tre figli si trasferisce a Inglewood, Los Angeles, la città in cui sorge “the Forum”, il tempio dei Lakers di Kareem Abdul Jabbar e Magic Johnson. E’ una folgorazione immediata ed inevitabile quella che si impossessa di Paul, anima destinata alla pallacanestro, forse fin dall’inizio, dai tempi del baseball a Oakland.

Nel 1991, a quattordici anni ancora da compiere, l’entrata alla Inglewood High School. Le mani erano già educatissime ma un fisico rivedibile e una velocità di piedi inadatta per una guardia lo costrinsero a passare i primi mesi incollato alla panchina. Paul era sereno, lavorava sui propri difetti con l’umiltà di chi non aveva mai dato nulla per scontato, ed alle prime opportunità non si fece attendere. Dopo quattro anni di high school la chiamata al McDonald’s All American, una delle manifestazioni più importanti a livello giovanile di tutti gli Stati Uniti, sintomo di una strada ormai già spianata. E’ l’estate del 1996 quando Paul Pierce fa la scelta più importante della sua vita, fino a quel momento: giocare per Kansas University.
Non solo basket però, perche Paul nei primi anni a Inglewood, ancor prima della high school, aveva conosciuto tale Scott Collins, poliziotto e addetto alla sicurezza al Forum, che lo prese sotto la propria ala trasmettendogli la passione per la pallacanestro e per la criminologia, la disciplina che scelse di studiare proprio a Kansas.
Era cambiato molto il ragazzo da Oakland: aveva perso chili e preso centimetri, migliorato la rapidità di piedi e viveva di passioni. Al primo anno a Kansas sfiora le Final Four NCAA vincendo il premio di miglior matricola della stagione, al secondo i Jayhawks sono i favoriti numero uno per alzare il trofeo finale, dopo una stagione da 32 vittorie su 34 partite in regular season. Tutto come da copione, anzi no: alle sweet sixteen Arizona timonata da Mike Bibby, poi vincitrice del torneo, sgambetta la corsa di Kansas in un incredibile upset.
Anche al terzo anno l’esuberanza cestistica di Paul Pierce non fu sufficiente per arrivare in fondo al bracket e vincere quel tanto sospirato trofeo che il figlio di Lorraine sognava fin da piccolo, quando si appassionò, ancor prima della NBA, al basket universitario.
A quel punto era scoccata l’ora, quella di rendersi eleggibile al draft. Scelgono per primi i Los Angeles Clippers, che tra i nomi di Vince Carter, Mike Bibby, Dirk Nowitzki e lo stesso Paul Pierce fanno quello di Michael Olowokandi, una delle più grandi meteore del secolo ventuno. Dopo la chiamata di Nowitzki alla 9 da parte dei Mavericks, tocca ai Celtics: “with the tenth pick, in 1998 NBA draft, the Boston Celtics select…”. L’uomo da Oakland passato per Inglewood e Kansas, Paul Anthony Pierce.
E’ il 5 febbraio del 1999 quando Paul Pierce debutta per la prima volta tra i professionisti. Nonostante i ventidue anni anche lui ha già qualcosa che caratterizza il professionista, per la verità: ha le sembianze del leader, del trascinatore nato per giocare e interpretare la pallacanestro.
Il 25 settembre del 2000, però, prende parola il destino: fuori dal Buzz Club di Boston Paul rimane vittima di undici coltellate, al termine di una rissa. Viene colpito al collo, alla testa e sulla schiena, una potrebbe aver danneggiato il cuore o un polmone. Dopo la maledizione di Len Bias nel 1986, scomparso due giorni dopo la chiamata al draft dei Celtics, a Boston tornano ad aleggiare i fantasmi del passato con la vicenda Pierce. La corsa all’ospedale è provvidenziale, l’intervento d’urgenza riesce e Paul, salvato dallo spessore del suo giubbotto di pelle e dalla prontezza dei medici della Tufts University, è fuori pericolo. La polizia identifica i tre aggressori, tre come i giorni che serviranno a Paul per tornare di nuovo in piedi: dona due milioni e mezzo di dollari al centro di chirurgia dell’ospedale ed ha già un pensiero fisso che gli martella in testa. Ritornare, più forte di prima, a calcare il parquet del TD Garden.
“My name is Shaquille O’Neal and Paul Pierce is the truth”, dice a fine partita Shaq. Quale partita? Lakers – Celtics, 13 marzo 2001. Pierce vince la partita scrivendone 42 con percentuali sovraumane, e il commento genuino di O’Neal gli ha definitivamente “appiccicato” il soprannome che si porterà dietro da quel momento in poi. The Truth, la verità, perchè Paul Pierce ha una peculiarità: ti fa capire veramente chi sei.
Come Al Harrington, ai playoff 2003, triste protagonista di una delle più grandi umiliazioni personali del secolo, dopo aver provocato il #34 sul tiro per decidere gara uno dei playoff: l’ala dei Pacers urla qualcosa, The Truth lo ascolta e risponde, poi palleggia e si arresta da otto metri. Il finale s’immagina facilmente, e se avete ancora dei dubbi il titolo del video qua sotto dovrebbe chiarirveli: “Paul Pierce permanently shuts up Al Harrington”. Fate voi.
Ancora? Spike Lee, Madison Square Garden. Tre secondi allo scadere dei ventiquattro, rimessa nelle mani di Pierce esattamente di fronte alla poltrona del regista che lo applaude ironicamente e gli urla qualcosa. The Truth riprende la palla, giro e tiro allo scadere ai limiti della legalità. Dubbi anche sta volta?
Dopo sette anni di assenza dai playoff i Celtics tornano a farne parte nel 2002, arrivando in finale di conference contro i New Jersey Nets. La sconfitta contro Kidd e soci è il chiaro segnale che mancano ancora dei tasselli per completare il mosaico: il primo, dopo Paul Pierce, arriva nell’estate del 2004 via Orlando Magic e risponde al nome di Doc Rivers, chiamato per diventare il direttore d’orchestra di una realtà che sarebbe stata costruita, di lì a poco. Ma quando? Il 2006 per i Celtics fu l’anno del baratro: l’infortunio di Paul Pierce spense le speranze di giocarsi i playoff e la sua frustrazione degenerò nella richiesta di essere ceduto se qualcosa non fosse cambiato. Non solo, la scomparsa di Red Auerbach e del suo inseparabile sigaro, una delle figure più importanti della storia della franchigia, fu una pugnalata: se n’era andato uno che per i Boston Celtics aveva dato tutto e fatto ancor di più. Cominciò a percepirsi la sensazione nitida di dover ripartire da capo, anche se da capo, in realtà, non era.
Nella stessa estate i Celtics misero le mani su Rajon Rondo, ventunesima scelta al draft da parte dei Phoenix Suns: playmaker puro e clamoroso difensore, tanto discusso per i suoi limiti ma con un estro ed una personalità palesemente fuori dal comune. Appena un anno dopo il mosaico venne completato con gli arrivi di Ray Allen da Seattle e Kevin Garnett da Minnesota, più Paul Pierce, se mai l’aveste scordato. La front-line dei Boston Celtics era a quel punto fra le prime tre della lega, per motivi palesi: tre giocatori nel pieno della propria carriera più un playmaker da sistema ed ogni tanto sopra le righe. 66 vittorie e 16 sconfitte, miglior record della lega e playoff, per andare dritti verso il Larry O’Brien Trophy. I Celtics fecero fuori gli Atlanta Hawks al primo turno e i Cleveland Cavaliers al secondo in sette gare, poi i Detroit Pistons in sei. Per il titolo il grande classico, forse la finale più bella di tutte, per la rivalità e la storia che divide e lega le due squadre. Los Angeles Lakers contro Boston Celtics, Kobe Bryant e Pau Gasol contro Ray Allen e Kevin Garnett ma, soprattutto, The Truth, Paul Pierce.
Vincono gara uno i Celtics forzando Bryant a tirare 9 su 26 dal campo, con un Garnett monumentale da 24+13 e i 22 di Paul Pierce. The Truth esagera per davvero in gara due portando i Celtics sul doppio vantaggio con 28 punti più 8 rimbalzi e 4 assist, in una partita che il #34 non avrebbe dovuto giocare per infortunio. In California però, proprio da dove Paul Pierce era partito, la reazione dei Lakers è inevitabile: i 36 di Kobe Bryant riaprono una serie che i Celtics torneranno a governare in gara quattro con una devastante prova di forza sul parquet dello Staples Center, con altri 20 punti di Pierce e 19 di Ray Allen. Gara cinque è dominata a larghi tratti e conquistata dai Lakers che in una partita già vinta hanno però il demerito di farsi riagganciare dai Celtics poco cinici nei momenti chiave. Tutto in gara sei, davanti al pubblico del TD Garden di Boston: The Truth aspettava da tempo questa partita, forse nemmeno riusciva più ad immaginarla. E’ racchiuso un pò tutto, dagli insuccessi a Kansas all’infortunio, alla frustrazione per le sconfitte. I Celtics giocano la gara perfetta e game six è una passerella, finisce 131 a 92 con Paul Pierce MVP delle Finals. Boston, inguaribile romantica e nostalgica città memore delle imprese di Bird, Russell e Parish torna ad alzare, dopo ventidue interminabili anni, un titolo NBA.
Da quella notte, nonostante l’ascesa vertiginosa di Rajon Rondo, i Celtics non riuscirono più ad arrivare in fondo. Nel 2010 la rivincita persa contro i Lakers, due anni dopo la finale di conference contro i Miami Heat di LeBron James, una partita carica di significato. A 28 secondi dal termine di gara 7 la partita è già chiusa, con gli Heat sopra di undici lunghezze. Doc Rivers con gli occhi lucidi richiama in panchina i big three, forse per l’ultima volta: sa meglio di ogni altro che si è giunti all’atto finale di un ciclo, e quelle che scendono sono le lacrime di commozione per quello che si è creato e che voltandosi, anche solo per un attimo, si riesce a rivivere ancora una volta. C’è tanta consapevolezza negli occhi dei protagonisti, soprattutto in quelli di Paul Pierce diventato bandiera e simbolo di una città devota alla pallacanestro. Tutti in piedi per Ray Allen, che presto tornerà a calcare le tavole del parquet dell’American Airlines Arena con la maglia dei Miami Heat, e per Kevin Garnett e Paul Pierce, che a Boston rimarranno per un’altra stagione, l’ultima.
E’ l’estate del 2013. Paul, insieme a Kevin, direzione Brooklyn. E’ la città ideale, è una franchigia nuova che giocherà al Barclays Center. L’11 aprile del 2014 The Truth scrive un altro pezzo di storia, contro gli Atlanta Hawks. Ricezione fuori dai tre punti, tiro ed errore, rimbalzo di Alan Anderson che serve di nuovo il #34 fuori dall’arco: stavolta è solo rete, e per Paul Pierce sono venticinquemila punti segnati in carriera. Più di ventimila solo con la maglia dei Boston Celtics.
Saranno due stagioni di alti e bassi per i Brooklyn Nets e per lo stesso Paul, ora specialista e arma tattica più che straripante realizzatore. L’avventura a Brooklyn si chiude con l’eliminazione ai playoff, la seconda consecutiva, ad opera dei Miami Heat. Ma per Paul Pierce è alle porte una nuova avventura.
I Washington Wizards mettono sul piatto un biennale da undici milioni che The Truth accetta senza patemi per rimettersi in gioco, a 37 anni, in una nuova realtà. E’ una squadra con due giocatori potenzialmente all-star come Wall e Beal ed una coppia di lunghi solidissima con Nenè e Gortat. E’ la chioccia del gruppo, il leader neanche troppo silenzioso in missione per la vittoria. La stagione è positiva, 46 vittorie e 36 sconfitte con la quinta posizione ad est: l’accoppiamento ai playoff preannuncia una serie equilibratissima contro i Toronto Raptors. I Wizards vincono gara uno e gara due di misura, ed inevitabilmente gara tre è la partita decisiva per spostare gli equilibri della serie, per riaprirla o per spaccarla a metà. A 30 secondi dalla fine Washington con palla in mano sul +3, penetrazione di Wall e scarico per Pierce che fuori dai tre punti ci pensa un attimo, giusto il tempo di ricordarsi quanto conti quel tiro, alza la mano e segna il tiro che chiude i giochi. Tornando in panchina, con l’indice verso il basso, l’urlo “that’s why i’m here”, ecco perchè sono qui, e non può essere diversamente.
Chiusa la serie in quattro gare contro i Raptors, i Wizards al cospetto della sorpresa della stagione, gli Atlanta Hawks di coach Mike Budenholzer. Pari uno dopo due partite, ancora una gara tre decisiva. Parità a quota 101 con quattordici secondi da giocare, rimessa Washington che la mette nelle mani di Pierce in lunetta. Cronometro che scorre in testa, otto, sette, sei, virata, palleggio arresto e tiro sulla sirena con tre difensori addosso: parabola eterna, palla contro il tabellone, canestro allo scadere. La risposta “i called game” alla domanda “did you call bank?” a fine partita è l’epilogo di un’altra, l’ennesima, clamorosa prova di forza firmata Paul Pierce.
Salvo il documento che contiene queste righe, è mezzanotte. La serie tra Hawks e Wizards è sul 3 a 2 e all’una si gioca gara sei: vorrei vederla, ma la sveglia suona troppo presto. Tocca rassegnarsi, mi infilo sotto le coperte e gli occhi si chiudono da soli. Gli Hawks sono a +3 con 5 secondi e 4 decimi da giocare, i Wizards hanno nelle mani il possesso per impattare. Riceve Wall, velo di Pierce che riceve fuori dall’arco. Passa in mezzo a due corpi con un palleggio ed un movimento irrispettoso dei principi della fisica, lascia partire il tiro che vale tre a fil di sirena. Boato del Verizon Center, The Truth potrebbe averlo rifatto. E’ questione di decimi di secondo, neanche, millesimi. Gli arbitri si affidano alla provvidenza dell’instant replay, che non lascia interpretazioni: il tiro non è valido. Paul Pierce è incredulo, si gratta nervosamente il capo guardando verso l’alto. Gli occhi sono lucidi come quelli di Doc Rivers quando capì che qualcosa stava finendo. Forse, per Paul, è l’ultima fermata.
Era il 1992 quando Aaron Sorkin fece uscire “A Few Good Man” con Tom Cruise e Demi Moore ma soprattutto Jack Nicholson, sfegatato tifoso Lakers. Paul aveva appena quindici anni, era da poco entrato a Inglewood ma amava già la pallacanestro.
“You can’t handle the truth” urlava Nicholson in una scena in tribunale, come se già sapesse, prima di ogni altro, cosa sarebbe successo.
Ha vinto un titolo da MVP, ha perso da protagonista e le sconfitte l’hanno forgiato rendendolo uno dei giocatori più decisivi della NBA. “The Captain and The Truth”, leader, uomo popolato da cromosomi irrimediabilmente predisposti alla vittoria. Come Shaq ai microfoni ESPN, “Paul Pierce is the truth”, è la verità, perchè se non sai chi sei ti aiuta a scoprirlo. Come? Facendoti raccogliere la palla dal fondo della retina per fare una rimessa, ammesso e concesso che abbia lasciato il tempo per farlo. Il tiro è già partito, Paul Pierce per la vittoria, titoli di coda. D’altra parte, The Truth è sempre stato qui per questo. Game, set and match.
















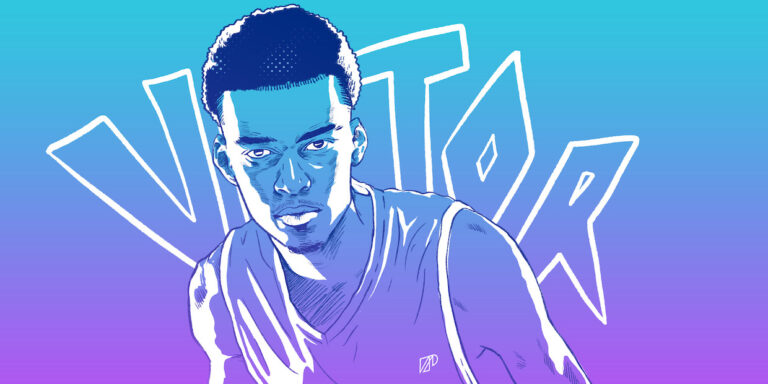











complimenti per l'articolo veramente
Cazzo, veramente un grande articolo mi sono venuti i brividi almeno 4/5 volte, ancora complimenti!
bello, bello, bello!!!
Finale commuovente. Stupendo