illustrazione grafica di Paolo Mainini
racconto di Alessandro Piscitelli
Flavio Ferri, sedicenne, passava quasi tutti i pomeriggi e molte domeniche in compagnia del suo pallone da basket, a cui aveva dato un nome: l’arancia.
Era il giocatore più talentuoso della squadra giovanile in cui militava e, nella prima parte di campionato, aveva trascinato i suoi in testa al girone con diciotto punti di media a partita e una sola sconfitta, maturata in sua assenza.
Frequentava il liceo scientifico di una cittadina della provincia lombarda ed era un grande tifoso dei Lakers. Circa un mese prima era rimasto sconvolto dalla scomparsa di Kobe Bryant. Quella tragedia l’aveva colpito non solo perché Kobe aveva dedicato l’intera carriera a difendere i colori giallo-viola della sua squadra del cuore, ma perché era stato un uomo buono, un uomo giusto, un uomo capace di unire i fan di tutte le squadre: sia quelle NBA, sia quelle italiane, sia quelle degli altri paesi del mondo.
Come tutti i giovedì pomeriggio Flavio aveva da poco terminato l’allenamento, si era fatto la doccia con i compagni di squadra e poi era tornato a casa in bicicletta per cenare insieme ai genitori e al fratello Claudio.
La famiglia Ferri era regolarmente riunita a tavola quando in televisione passò l’improvviso annuncio del Presidente del Consiglio. Il Coronavirus, che da inizio anno aveva infettato la Cina, ora chiudeva tutto anche in Italia, campionati sportivi nazionali, allenamenti di gruppo ed individuali compresi, e Flavio era rimasto alquanto perplesso.
Così salì in camera sua, iniziò a chattare con i compagni di squadra su whatsapp e, dopo un’ora abbondante, decise che quell’infelice giornata potesse considerarsi conclusa. Indossò la t-shirt gialla che usava per dormire, quella griffata Nike e con la scritta Lakers 23 sul petto, ma quando stava per spegnere la luce dell’abat-jour il cellulare squillò. Il numero era anonimo. Solitamente in quei casi non rispondeva mai, ma dato l’orario insolito trascinò il dito sul tondo verde del display e disse: «Pronto».
Una voce profonda gli provocò un sottile brivido lungo la schiena.
«Ciao Flavio. Io ti conosco ma tu non sai chi sono io. So che sei bravo a giocare a basket e vorrei proporti un gioco, è molto semplice: dovrai scegliere se essere ricordato come l’eroe di un unico tiro decisivo oppure come uno dei tanti che per anni hanno calcato i parquet NBA senza lasciare traccia.»
«Pronto? Ma chi parla?»
«Puoi chiamarmi l’arancia. Tu sai a cosa mi riferisco.»
«Chiunque tu sia non è divertente. Cosa vuoi da me?»
«Credevo di essere stato chiaro. Voglio che tu faccia una scelta: preferisci “The shot” o una lunga, anonima ma remunerativa carriera?»
«Ma cosa vuol dire?»
«Ogni decisione comporta delle conseguenze nella vita. Pensa bene a ciò che ti ho detto, ci risentiremo tra non molto. Buonanotte campione.»
La telefonata s’interruppe e Flavio rimase con il telefono in mano a fissare la foto impostata come screensaver, quella in cui era ritratto sorridente sul parquet insieme ai suoi compagni di squadra. Piuttosto turbato, attese ancora qualche minuto prima di spegnere la luce e convincersi che quella telefonata fosse solo uno scherzo architettato da qualche amico, così si mise tranquillo e si addormentò.
La notte scivolò via regolare e lui dormì sereno, nella solita posizione a pancia in giù. Raramente faceva sogni che l’indomani riusciva a ricordare, ma quella mattina di marzo le cose andarono diversamente.
Aprì gli occhi di soprassalto, era madido di sudore, e quando si levò dal letto le immagini di ciò che aveva sognato erano ancora lì, chiarissime, davanti a sé.
Era in campo, allo Staples Center, e vestiva la canotta della vita, quella giallo-viola con il numero 23. Aveva appena ricevuto da Ricky – suo miglior amico e compagno di squadra – un assist perfetto per il più facile dei tiri da tre punti. Lui si era aperto in maniera ideale, appena qualche centimetro fuori dalla linea bianca dei 7,25 e si era alzato per caricare il tiro: l’arancia aveva lasciato la sua mano in modo naturale e roteava indisturbata verso il canestro avversario.

Sarebbe stato il tiro della vittoria, il tiro che avrebbe risolto quei durissimi quaranta minuti. “The shot”. L’arancia girava nell’aria, girava che era una meraviglia ma poi, all’improvviso, si colorò di grigio. Alcune parti erano più scure, altre di un colore livido, e dei piccoli, sanguinosi fiorellini rossi ne puntellavano la superficie esterna. Era un’immagine demoniaca, quel pallone sembrava maledetto e una voce profonda, la stessa che la sera prima l’aveva chiamato al telefono, rimbombava all’interno dello Staples per informare tutti che il Coronavirus si era impossessato dell’arancia prendendone le sembianze. Tutto era incredibilmente assurdo e spaventoso. Flavio distolse lo sguardo dalla sfera grigia con i fiorellini rossi e si voltò in direzione del suo amico Ricky. In quel momento si accorse di essere rimasto solo, tutto il pubblico intorno era scomparso e anche l’arancia maledetta non si vedeva più. Era come evaporata, svanita. Forse era stata solo una brutta allucinazione, ma il primo pensiero che gli venne in mente fu: “L’arancia era entrata nel canestro?”
Si era svegliato con quel dubbio atroce e per sapere come fosse finita cercò in tutti i modi di riaddormentarsi ma fu uno sforzo inutile: la voce di sua madre prese a chiamarlo a intervalli regolari dalla cucina. Una nuova giornata lo aspettava al piano di sotto, con una tazza di latte freddo e i Ringo già pronti sul vassoio colorato in terrazza.
Dopo aver fatto colazione in compagnia del fratello Claudio si vestì e si precipitò in garage per inforcare la bicicletta che l’avrebbe condotto a scuola. Giunto davanti al portellone verde del garage rimase però “di stucco”: suo padre stava lavando l’auto con indosso la tuta che solitamente usava in casa e, dato che era venerdì, gli domandò: «Pa’ che fai? Non vai al lavoro oggi?»
Suo padre lo fissò con espressione interdetta, riprese ad insaponare il cofano della macchina e con voce calma rispose: «Non hai sentito il discorso del Presidente ieri sera? Per due settimane sarà tutto chiuso: scuole, uffici, palestre, piscine, cinema, teatri… dove vuoi che vada?»
Flavio cercò di ricordare, mise una mano sul mento e bofonchiò: «Ma io… io credevo che, che fosse solo… che oggi comunque potessi andare a scuola e poi ad allenarmi…»
Suo padre nemmeno si voltò e gli disse: «Dai, vieni qui, prendi questo straccio e dammi una mano.»
Il padre di Flavio era un dirigente d’azienda. Lavorava praticamente sempre e a casa si vedeva giusto la sera a cena e nei weekend. Aveva quarantotto anni, ma l’aspetto ne rifletteva qualcuno in più. Lapancetta evidenziava una scarsa cura del proprio fisico e uno stile di vita non troppo sano. Da giovane, però, al pari di suo figlio era stato un grande appassionato di basket e si era avvicinato a quel magnifico sport osservando le gesta di Magic Johnson, dei suoi Lakers e degli acerrimi rivali Boston Celtics. Poi negli anni Novanta i Bulls avevano dominato il mondo, suo padre continuava a tifare i Lakers, ma riconosceva quanto superiore fosse quell’incredibile numero 23 con la canotta rosso fuoco. Anche se si vergognava ad ammetterlo, dopo la finale del 1991 in cui Chicago aveva sconfitto in finale la “sua” squadra per 4-1, era contento dei successi che MJ collezionava in serie.
E così, mentre Flavio era impegnato ad aspirare gli interni del SUV aziendale, il suo vecchio gli fece una proposta: «Che ne dici di un 1 vs 1 ai 31 punti?»
Flavio riemerse dai tappetini dell’auto e vide suo padre puntare il dito indice della mano destra verso il canestro attaccato sopra al portellone del garage. Sorridendo, rispose: «Ma dai papà? Vuoi essere umiliato?»
Con lo sguardo serio e fiero, il suo vecchio lo invitò a cambiarsi mentre lui avrebbe spostato la macchina. Flavio rientrò in casa, indossò la canotta viola di LeBron James e si presentò nuovamente in giardino per onorare la sfida che gli era appena stata lanciata. La persona che vide apparire da dentro il garage, però, sembrava tutt’altro che il suo vecchio: il signor Alberto aveva sostituito la blusa blu della tuta con una sfavillante canottiera vintage di Magic. Era di un giallo più acceso di quello dei Lakers versione 2019-20, c’erano il logo della Champion e quello rosso-blu-bianco di Jerry West in palleggio che rappresentava l’NBA ma, soprattutto, c’era il numero 32 in bella vista. Due generazioni a confronto pronte a sfidarsi: Magic vs. LeBron.
Flavio strinse tra le mani l’arancia, rigorosamente Spalding, che suo padre gli aveva lanciato. Il Coronavirus stava rivoluzionando le loro vite e quelle di altri milioni, miliardi di persone, ma in quella soleggiata mattina di marzo tutto ciò che per lui contava era la sfida nello spiazzo davanti al garage della loro casa. Il canestro, con tanto di tabellone bianco e scotch nero, era stato bullonato ad un’altezza quasi regolare e i due avversari avevano stabilito che il tiro da dietro la fontanella sarebbe valso 3 punti. Il primo possesso se lo sarebbero giocato tirando proprio da quella distanza e suo padre aveva fatto canestro.
Flavio palleggiò, raccolse il pallone, spezzò il polso della mano destra e, come nel sogno di poche ore prima, l’arancia prese a volteggiare perfettamente verso il canestro sopra il garage. Il tiro era pulito, un vero e proprio “The Shot” ma, per sua sfortuna, risultò leggermente lungo e dopo aver toccato il ferro rimbalzò tra le braccia del padre.
Il signor Alberto prese allora posizione fronte a canestro, a circa sei metri di distanza dal portellone del garage, passò l’arancia a suo figlio che gliela restituì e senza tanti complimenti partì in palleggio, lasciandolo inchiodato sul posto: 2-0 per Magic Johnson.
Come nei migliori playground la regola era “chi segna regna”, così il signor Alberto mantenne il possesso dell’arancia e piazzò un arresto e tiro vincente, seguìto da un terzo tempo a gomiti larghi che lo fece volare sul 6-0. Flavio sorrideva ad ogni canestro del padre ed era certo che al primo errore avrebbe raccolto il rimbalzo e infilato poi una serie di cesti per chiudere il confronto in suo favore.
Sebbene fosse marzo c’erano già venti gradi e poco vento, il sudore iniziava a colare dalla fronte dei due contendenti ma nonostante ciò il livello dell’agonismo si alzava ad ogni azione. Il signor Alberto sbagliò la sua ultima conclusione fronte a canestro e Flavio-LeBron insaccò di risposta i suoi primi quattro punti riequilibrando così la partita. Aveva l’inerzia a suo favore, un maggior atletismo e non fu difficile andare via sul lato destro del padre e schiacciargli in testa. Sul 15-14 in favore di LeBron, Magic piazzò una tripla da dietro la fontanella che il figlio contestò perché, a suo parere, non era proprio così dietro. Tra i due si accese un battibecco e sembrò di assistere, con le dovute proporzioni, all’1 vs 1 tra padre e figlio più famoso della storia del cinema: quello tra Jack e Jesus Shuttlesworth in He Got Game. Suo padre, però, non era un galeotto e Flavio non era Ray Allen così, mentre anche la madre e il fratello Claudio erano usciti in giardino attirati dalle urla di quei due, tutto si risolse con la convalida di soli due punti.

LeBron vinse 31-20 per manifesta superiorità ma quando strinse la mano ad un vecchio e stanco Magic non poté esimersi dal fargli i complimenti: «Giochi davvero forte pa’!»
«Eh… mi ci vorrebbero le ginocchia di vent’anni fa e quindici chili in meno.»
«Ma no, dai. Hai un ottimo arresto e tiro.»
«Frutto di anni passati davanti alla tv a vedere i primi sprazzi di NBA con la voce di Dan Peterson e tentativi, poi, di emulare le gesta di Magic, Jabbar, Bird, Jordan al campetto. Non ho mai giocato veramente.»
«Eri molto appassionato?»
Suo padre si appoggiò al cofano dell’auto appena pulita e, sorridendo, prese a ricordare alcuni episodi della sua vita da ragazzo. Gli raccontò di quanto fosse stato bello “vivere” le Finals degli anni ’80 con i Lakers sempre protagonisti, prima contro Houston, poi contro Phila e Boston, poi arrivarono i Bad Boys ed infine, nel nuovo decennio, contro sua maestà Michael Jordan. Erano i tempi della scuola, medie e superiori, e quelle partite le aveva viste tutte a casa del cugino Vanes. Erano due ragazzini, due adolescenti ma sognavano di cambiare il mondo. Lui, poi, aveva studiato economia ed era diventato un dirigente d’azienda, mentre suo cugino era finito a fare il cameriere in una pizzeria prima di aprirne una tutta sua. Erano sempre stati diversi fin da piccoli ma il basket, in particolare l’NBA, li rendeva uguali.
Alberto continuò il suo viaggio nel passato tirando in ballo «la finale forse più bella: i Lakers non erano più protagonisti ma quella del giugno 1998 tra i Chicago Bulls di MJ, Pippen, Rodman e gli Utah Jazz di Stockton & Malone fu indimenticabile». La decisiva gara 6 l’aveva vista in ospedale mentre faceva la notte accanto ad un amico che aveva avuto un terribile incidente. Il televisore della camera, muto, era sintonizzato su Tele+ ma quando Jordan segnò il canestro decisivo lui non riuscì a trattenere un “Ooohhh” di stupore svegliando così l’amico e gli altri tre pazienti addormentati.
«Quello, per me, è stato il vero “The shot”: il migliore di tutti i tempi! Superiore anche a quello che, sempre MJ, realizzò contro Cleveland nei playoff dell’89.»
Flavio rimase a bocca aperta per la competenza del padre e, felicemente sorpreso, gli domandò: «Perché non mi hai mai raccontato queste cose? E’ una figata sentirti parlare di NBA!»
Alberto, con la canotta sudata di Magic ancora addosso, sorrise e gli diede un buffetto sui capelli. Com’era solito fare non replicò ma si irrigidì quando suo figlio, un attimo dopo, gli disse: «Ieri sera, prima di dormire, ho ricevuto una strana telefonata. Una voce che non conosco, di persona adulta, mi ha chiesto se vorrei essere l’eroe di un unico tiro decisivo o se preferirei una carriera ben remunerata ma anonima».
Il padre si voltò verso di lui con aria preoccupata, gli domandò chi fosse quella persona ma quando Flavio ribadì che non ne aveva idea si concentrò su ciò che gli aveva chiesto. «Mmmm… e tu che sceglieresti? Il tiro decisivo – “The Shot” – o la carriera ben pagata?»
«Non lo so. Forse il tiro decisivo.»
«Bella risposta. Andiamo a farci una doccia dai, tra poco è ora di pranzo.»
La prima mattina di quarantena forzata, per via del Coronavirus, era stata una delle più belle che Flavio avesse mai trascorso in compagnia di suo padre. Grazie a quell’1 vs 1 si era reso conto di non conoscerlo per niente e la cosa gli dispiaceva moltissimo. Mentre si asciugava i suoi biondi capelli ricci pensò che, forse, passare del tempo a casa con la famiglia non sarebbe stato poi così male: avrebbe finalmente potuto guardare le sue serie tv preferite su Netflix o su Sky, giocare alla Play con il fratello o sbirciare sua madre mentre cucinava e magari aiutarla a fare gli stampini dei biscotti. Poteva fare tutte quelle cose ma sentiva che il momento top delle prossime due settimane sarebbe stato sfidare suo padre ogni giorno nel campetto improvvisato davanti al loro garage che, per lui, era diventato come il Rucker Park di Harlem.
La partita era solo il pretesto per rimanere da solo con il suo vecchio e la parte che gli interessava di più era il dopo, quando sperava che suo padre gli raccontasse ancora qualcosa di quel meraviglioso sport che aveva scelto di praticare e che voleva far diventare una vera e propria professione. E così andò: Magic e LeBron si sfidarono alle 11 di ogni mattina, suo padre fedele al 32 giallo-viola, mentre Flavio diventò Steph Curry, Kevin Durant in maglia Oklahoma, Derrick Rose, Dirk Nowitzki e, per finire, Marco Belinelli con la maglia numero 3 degli Spurs.
Durante un’altra carrellata di aneddoti NBA snocciolata da suo padre, Flavio improvvisamente lo interruppe e gli disse: «Hai sentito che tra pochi giorni su Netflix andrà in onda una serie sui Chicago Bulls del 1998?»
«No. Che cos’è?»
«Si chiama “The Last Dance” e racconta l’ultima stagione di Jordan, Pippen, Rodman e Phil Jackson nei Bulls. E’ quella del famoso tiro di MJ.»
«Cavolo, vorrei vederla!»
«Ti va se la guardiamo insieme papà?»
Mentre disse papà, Flavio si accorse che non lo chiamava così da un’infinità di tempo.
Erano oramai tutti reclusi da più di una settimana ma quello che doveva essere un incubo si era per lui trasformato in uno dei periodi più sereni e felici della sua vita. Certo, nessuno di loro si era ammalato e ciò voleva dire tanto. Tutto. Ogni sera il bollettino della protezione civile vomitava numeri di morti superiori a quelli di una guerra e osservando le immagini dei telegiornali, dove gli ospedali erano ridotti a una carneficina, ci si rendeva conto del dramma che il mondo stava vivendo. Nessuno era preparato a quel periodo di arresti domiciliari ma saperne cogliere gli aspetti positivi era una delle qualità che Flavio stava facendo emergere.
Quando non sfidava suo padre era la volta del fratello Claudio. Di due anni più piccolo, anche lui giocava a basket ma i mezzi tecnici e la stazza fisica di cui era dotato o, per meglio dire, di cui non era dotato, facevano intuire quanto fosse semplice per Flavio vincere quei duelli. Si allenava anche da solo: tirava l’arancia in quel canestro ore e ore e si sentiva più forte di quando aveva giocato l’ultima partita. Con Claudio, spesso, facevano una scorpacciata delle più belle partite NBA di sempre, non solo le Finals. Erano partiti ammirando lo show di Magic nella gara 6 Lakers-Phila del 1980 in cui infilò 42 punti giocando come centro, avevano visto tutta Chicago-Utah dove MJ realizzò “The Shot”, poi erano passati alle prodezze di Allen Iverson nel 2001 contro i Lakers, agli 81 epici punti di Kobe Bryant del 22 gennaio 2006 contro i Raptors, alla tripla di “Jesus” Ray Allen che nel 2013 aveva tolto il titolo agli Spurs, a gara 7 Golden State-Cavs che aveva consacrato LeBron James, e ancora Dirk Nowitzki, Derrick Rose a Chicago, Kawhi Leonard, Luka Doncic, gli Splash Brothers…
Un pomeriggio si gustarono la vittoria del “Three point contest” di Belinelli all’All Star game di New Orleans perché, sebbene Flavio ammirasse tutti i più grandi campioni a stelle e strisce, in fondo sognava di fare la stessa carriera del ragazzo di San Giovanni in Persiceto. Come lui voleva arrivare a giocare di là, magari dopo aver vinto un campionato in Italia o in Europa, come lui voleva poter assaporare l’atmosfera delle città americane e quelle, sicuramente più emozionanti, del Madison Square, dello Staples o del TD Garden di Boston. Ci credeva, credeva nelle sue potenzialità e anche se a sedici anni giocava ancora in una squadra di provincia era sicuro che il meraviglioso campionato che stava disputando gli avrebbe aperto le porte di qualche società importante.
“Beli” era il suo punto di riferimento; quando nel 2007 era arrivato a San Francisco aveva dovuto mangiare merda ma poi si era fatto. Si era fatto rispettare, era diventato uno specialista, e aveva addirittura vinto il titolo nella finale 2014 contro gli Heat. Le sue lacrime di gioia erano state l’immagine che a dieci anni Flavio si era stampato in mente e da quel momento aveva capito quanto fosse bello il basket e quanto valesse la pena lottare per diventare, un giorno, un campione.
Il Presidente del Consiglio aveva appena comunicato a tutta la nazione che le misure restrittive decise due settimane prima sarebbero state prorogate almeno fino al 4 maggio. Dopo quella notizia il padre di Flavio si era lasciato scappare un’imprecazione perché, anche se era stato un fan di Magic e anche se sapeva molte cose sull’NBA, rimaneva comunque un dirigente d’azienda e non andare a lavoro stava diventando per lui un vero e proprio sacrificio. Al contrario, almeno inizialmente, Flavio pensò invece che fosse una cosa positiva: poteva continuare ad allenarsi con suo padre, con Claudio, continuare a vedere le partite che avevano fatto la storia e, soprattutto, sarebbe stato automaticamente promosso in terza liceo dato che, oramai era certo, le scuole non avrebbero più riaperto.
A lui piaceva studiare, frequentare i compagni di classe, sbirciare le ragazzine a ricreazione ma quell’anno, forse perché troppo preso dal basket o da chissà che, aveva storia e matematica sotto e difficilmente le avrebbe recuperate. Si sentiva colpevolmente euforico di fronte a gente che moriva, a persone in difficoltà economiche, ad altre che avrebbero perso il lavoro e, anche, davanti a suo padre. Poi, un lampo, gli ricordò che tutti i campionati giovanili nazionali e regionali, di ogni disciplina sportiva, erano stati definitivamente sospesi. Cancellati. Ciò che con impegno e sudore aveva fatto per la sua squadra non era valso a nulla: la stagione era persa e dei suoi diciotto punti a partita e del primato in classifica non si sarebbe ricordato più nessuno. Il suo sogno di essere chiamato da una grande squadra era morto sulle labbra del Presidente Conte e senza pensare a quanto c’era di più grave intorno si rattristò e si chiuse in sé stesso.
La mattina dopo fu ancora una volta suo padre a fargli tornare il buonumore. Il signor Alberto, infatti, aveva sistemato in giardino la griglia ed era pronto a riempirla con salsicce, bistecche di capocollo, pancetta e costine di maiale. Per Flavio le grigliate erano i momenti più belli in famiglia ma capitavano di rado; suo padre lavorava tanto e sua madre non era in grado di accendere il fuoco.
Quel giorno, poi, il barbecue avrebbe preceduto un momento particolare: il suo vecchio aveva disposto che dopo pranzo lui e i figli guardassero fianco a fianco le prime due puntate di “The Last Dance” e Flavio non stette più nella pelle. Contro ogni suo principio mangiò velocemente e si assicurò poi il posto migliore del divano, quello sotto alla finestra, per gustarsi ogni singolo minuto della serie sui Bulls.
I tre maschi della famiglia Ferri erano assorti dalle immagini e dai dialoghi sottotitolati in onda su Netflix e Flavio, anche se aveva mille domande per suo padre, rimase in silenzio perché non voleva disturbare nessuno. Conoscere la vera storia di Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson, Jerry Krause ma anche di avversari memorabili come Magic, Bird, Isiah Thomas e i Bad Boys di Detroit era come toccare il cielo con un dito.
Dopo quel pomeriggio attese ogni lunedì come l’unico giorno importante della settimana e rimase particolarmente colpito dall’episodio in cui MJ e Kobe si sfidarono all’All Star Game del ’98 al Garden di New York. Per lui Bryant era stato il più grande e ora che era morto aveva l’assoluta certezza che nessuno lo avrebbe mai superato come suo mito personale. Indossava la t-shirt e la canotta di LeBron, l’attuale 23 dei Lakers gli piaceva moltissimo, ma Kobe… Kobe era un’altra cosa e solo guardando attentamente quell’episodio della serie capì che tanto, forse tutto, lo aveva imparato da quello che considerava il suo maestro: MJ.
Finita quella puntata iniziò segretamente a tifare anche per i Bulls. Chicago era diventata la sua seconda squadra ma non lo avrebbe detto a suo padre, troppo banale, però gli domandò cosa pensasse della serie che stavano divorando davanti alla tv. Il suo vecchio ci rifletté un po’ sopra, lo faceva sempre prima di rispondere al figlio, poi disse: «E’ bella, è fatta bene! Jordan era davvero il migliore di tutti. Lo sai cosa mi ha colpito, forse perché ho vissuto da diciottenne quegli anni?»
«Cosa papà?»
«La rivalità umana che MJ e gli altri Bulls provavano per i Pistons. Certo, i Bad Boys giocavano sporco ed erano “cattivi” ma vincevano perché erano una vera e propria squadra. Michael era frustrato di questo perché voleva che i suoi fossero come loro, forse un po’ meno feccia di loro, ma con quella mentalità vincente. Hai visto quanto gli stava sul cazzo Isiah Thomas?»
«Beh, è naturale: quelli di Detroit se ne sono andati quando Chicago li ha sconfitti e Isiah era il loro leader.»
«Sì, è vero, ma gli stava così sulle palle perché con quel gesto era come se Thomas non avesse riconosciuto il suo grande valore. Jordan era estremamente competitivo ma se è diventato anche un vincente credo che molto del merito sia per quell’odio sportivo e quella rivalità umana che provava per Thomas e i suoi compagni. Le motivazioni sono tutto nella vita, ricordalo!»
Flavio annuì e dopo qualche minuto era già di nuovo in cortile con la sua arancia per farle accarezzare il cotone pendente sopra al portellone del garage.
Dopo cena giocò un paio di partite a NBA2K20 con suo fratello e poi andò a dormire. Come ogni notte vestì la t-shirt gialla di LeBron e in pochi minuti, nella solita posizione a pancia in giù, si addormentò. Al pari del sogno di alcune settimane prima era di nuovo in campo allo Staples Center, indossava la canottagiallo-viola numero 23 e aveva appena scoccato lo stesso tiro dai 7,25 che poi era scomparso nel nulla. L’arancia, adesso, era però del suo classico colorito; il grigio topo e i sanguinosi fiorellini rossi non c’erano più e la scritta Spalding roteava in bella vista insieme alle cuciture del pallone. Mancavano tre secondi al suono della sirena, il tabellone segnava Lakers 124 – Clippers 126. Si leggeva anche la data: 06-06-2032. Era la finale della Western Conference e quel suo tiro, “The Shot”, avrebbe mandato la squadra di Hollywood alle Finals per il titolo. Nel sogno precedente si era svegliato chiedendosi se l’arancia fosse entrata nel canestro ma adesso c’erano molti dettagli in più: i nomi delle due squadre in campo, il punteggio, il tempo, la data e il pallone era davvero un pallone.
Due secondi, uno… solo il rumore del cotone. Flavio aveva segnato il tiro della sua vita e aveva lanciato la squadra per cui faceva il tifo da bambino verso un’altra finale, l’ennesima della gloriosa storia dei Lakers. Era stato sommerso dagli abbracci dei suoi compagni di squadra, Ricky compreso – il suo migliore amico. Era incredibile come entrambi fossero finiti a giocare insieme allo Staples, nella stessa squadra e che l’avessero appena portata in finale. Tutto era così meraviglioso, troppo forse.
Improvvisamente, poi, si spensero le luci del palasport: gli spettatori erano andati via, i suoi compagni pure e anche l’arancia della vittoria era nuovamente scomparsa. Flavio si guardò attorno preoccupato, chiamò a gran voce Ricky e gli altri compagni ma ricevette l’inattesa risposta da quella cupa voce misteriosa che aveva telefonato al suo cellulare prima del primo sogno. «Eccoci qui, Flavio. Solo io e te.»
«Cosa… chi… chi parla, chi sei?»
«Ma come chi sono, non ricordi più? Ci siamo già parlati, io sono l’arancia.»
«L’arancia? Ma che… che vuoi da me?»
«La risposta alla mia domanda: un unico, trionfale “shot” o una lunga e remunerativa carriera?»
«Io… io ricordo la tua domanda ma non ho mai risposto e…»
«Ah, ma non serve che tu lo faccia. Era già tutto scritto, ciò che hai appena fatto è la risposta!»
«Vuoi dire che quello… quello era il mio “The Shot”?»
«Esattamente campione.»
«E ora che mi succederà?»
«Ora dipenderà da te. Io sono un’arancia speciale, vuoi vedere?»
Flavio non ebbe tempo di rispondere: una pioggia di palloni grigi con i sanguinosi fiorellini rossi invase il parquet dove lui era rimasto solo e quella voce, ridendo in modo satanico, gracchiò: «Io sono l’arancia ma anche il Coronavirus, sono il bene e il male, sta a te decidere che forma darmi. Ah ah ah ah…»
«No, aspetta che vuoi dire?»
«Ah ah ah ah…», la voce continuò a ridere ma pian piano si fece sempre più sottile fino a spegnersi del tutto. Flavio si ritrovò, di nuovo, isolato sul parquet dello Staples ma con due palloni: uno arancione e uno grigio con i fiorellini rossi. Era tremendamente spaventato e corse verso lo spogliatoio in cerca dei suoi compagni ma tutti i locali erano vuoti. Era rimasto l’unico all’interno dell’impianto e a fargli compagnia c’era solo la luce del tabellone attaccato al soffitto che recitava Lakers 127 – Clippers 126. Sorrise e capì di aver realizzato qualcosa di veramente grande. Con ancora indosso la canotta numero 23 aprì uno dei portoni dell’Arena ma in quel preciso istante si svegliò di soprassalto: la voce di sua madre lo chiamava dal piano di sotto e per due volte gli aveva ripetuto che il latte freddo e i Ringo erano già pronti sul vassoio colorato in terrazza.
Flavio, senza nemmeno passare dal bagno, si precipitò giù per le scale e quando arrivò in cucina vide sua madre. Chiese dove fossero Claudio e il padre e la signora Anna, con espressione ovvia, rispose: «Sono già usciti: tuo fratello dovrebbe essere a scuola e tuo padre a lavoro. Tu, oggi, non vai in classe?»
«In classe? Ma che… che dici mamma? Non… non si può andare a scuola, c’è il virus.»
Sua madre lo studiò in modo bislacco dalla testa ai piedi, gli domandò se si sentisse bene e gli mise una mano sulla fronte. Flavio la mandò via, prese il cellulare e digitò Coronavirus ma, stranamente, non trovò alcuna notizia o informazione relativa a quella parola.
Dopo aver velocemente trangugiato quattro biscotti si vestì e uscì per andare in garage: voleva controllare dove fosse la canotta numero 32 dei Lakers di suo padre. Cercò in tutti i cassetti dell’unico armadio ma non trovò nulla, spostò diverse cianfrusaglie, vestiti, tute da sci, persino un accappatoio ma della canottiera di Magic non vi era traccia. Visibilmente sconvolto arrivò a scuola, era venerdì e c’era il compito di matematica. Si sentiva un estraneo, uno capitato lì per caso dopo aver passato una vita intera su Marte.
In banco con lui c’era il suo amico Ricky. Si conoscevano dalla prima elementare e avevano condiviso sempre tutto: la scuola, il basket, gli amici, a volte anche le vacanze estive. Flavio aveva una faccia pallida, preoccupata e prima che potesse dire qualcosa fu Ricky a domandargli: «Oh, tutto bene? Ti vedo strano».
Si voltò verso il suo amico, lo osservò dritto negli occhi e a bassa voce rispose: «Sto bene. Ma il virus? Nessuno ne parla…»
Ricky assunse un’espressione esterrefatta, tenne lo sguardo fisso su di lui e disse: «Quale virus?»
«Come quale virus? Il Coronavirus: siamo stati tutti a casa più di un mese.»
«Flavio sei scemo? Che cavolo dici, cos’è sto virus?»
Flavio guardò il display del suo cellulare e notò che la data, in effetti, era venerdì 28 febbraio. Non era trascorso alcun mese dall’allenamento della sera prima e tutto ciò che aveva sognato, vissuto e sognato nuovamente era come se non fosse mai accaduto. Disse a Ricky che non si sentiva bene, chiamò sua madre e si fece venire a prendere.
Appena tornato a casa si sdraiò sul letto, provò la febbre ma la linea del mercurio segnava 36,5 gradi. Era tutto okay. Prese di nuovo in mano il telefono, selezionò il contatto di suo padre e spinse il tasto verde. Poco dopo stava parlando con il suo vecchio: «Pa’, ma tu hai mai avuto la canottiera dei Lakers di Magic Johnson?»
Suo padre restò in silenzio per alcuni secondi, lo faceva sempre. Poi rispose: «Flavio non dovresti essere a scuola?»
«Sì, ma non mi sentivo bene. E’ venuta a prendermi mamma. Per favore pa’ rispondi alla mia domanda.»
Suo padre sbuffò, si accese una sigaretta e disse: «No. Non ho mai avuto la maglietta di Magic. Perché me lo stai chiedendo?»
«Ma… ma i nostri 1 vs 1 in giardino? The Last Dance?»
«Flavio ma che ti succede oggi? Quali 1 vs 1? Cos’è The Last Dance?»
«Niente pa’, ci vediamo stasera.»
Capì di aver davvero sognato tutto: l’annuncio del Coronavirus, la telefonata della voce misteriosa, gli 1 vs 1 con suo padre, quelli con suo fratello, le partite NBA alla Play, The Last Dance – come gli era venuto in mente? E poi, vabbè, il sogno dell’ultimo tiro allo Staples Center era stato davvero un sogno ma questo lo sapeva già.
Era incredibilmente frastornato ma anche molto felice che quel maledetto virus, palesatosi nella sua mente, fosse stato solo un’invenzione. Si sentiva molto meglio e dopo aver discusso, ma convinto sua madre, era andato all’allenamento del pomeriggio perché due giorni dopo c’era un’importante partita da vincere. Quando prese in mano l’arancia tutto gli sembrò strano. Era come se non la tenesse in mano da diverso tempo, come se fosse un oggetto sconosciuto. Se l’era immaginata grigia con degli orrendi fiorellini rossi ma era felice di vederla con i soliti spicchi arancioni intervallati dalle righe nere.
La sua vita e quella di tutte le persone che lo circondavano continuò regolarmente. Il compito di matematica era andato benino – 6 – ma per recuperare c’era ancora tempo. In campionato la sua squadra mantenne il primato del girone e Flavio chiuse la regular season con 18,3 punti di media a partita. Era pronto per i playoff e voleva a tutti i costi regalare il titolo Under 16 ai suoi compagni.
In serie A la Virtus Bologna partiva con i favori del pronostico per aggiudicarsi lo scudetto, così come dall’altra parte dell’oceano i Lakers e i Clippers erano favoriti ad Ovest e i Bucks ad Est.
I playoff primaverili si preannunciavano elettrizzanti a tutti i livelli e Flavio avrebbe voluto dedicarsi solo al basket, proprio come aveva fatto nel suo periodo virtuale di quarantena. Invece, la scuola era lì in agguato: storia e matematica andavano salvate ma con gli ultimi compiti e le ultime interrogazioni ce la poteva ancora fare.
La sua squadra superò agevolmente il primo turno di playoff dell’Under 16, mentre le quattro semifinaliste di Lega A furono la Virtus, la Reyer, l’Olimpia Milano e la Dinamo Sassari. In NBA si giocavano le semifinali di conference: Lakers-Rockets e Clippers-Thunder da una parte, Bucks-Sixers e Raptors-Celtics dall’altra. Tutto procedeva per il meglio e la stagione 2019-20 si stava rivelando una delle più incerte di sempre sia in Italia, sia in America. Flavio adorava quel periodo dell’anno, in pratica viveva per quello.
Il compito di storia gli permise di tornare in linea di galleggiamento, ora serviva solo un 6 nell’ultima interrogazione e i giochi erano fatti, mentre matematica era ancora tutta da conquistare. Intanto, lui e il suo amico Ricky continuavano a superare turni di playoff ed erano arrivati alla semifinale della fase regionale. Le sue energie fisiche e mentali erano tutte concentrate nel fare entrare più volte possibile l’arancia dentro al canestro. Perché del basket si scriveva, si parlava, si facevano dibattiti in tv e al bar, si compravano le repliche delle canotte NBA, ci si vestiva come certi giocatori con le “maniche” gialle, nere o rosse, si allacciavano le Air Jordan, si sistemavano bene in testa le fascette della Nike ma alla fine l’unica cosa che contava davvero era far entrare in contatto l’arancia con il cotone della retina. Tutto il resto contava zero.
Lakers e Clippers si sarebbero sfidati per il titolo della Western conference, mentre Bucks e Celtics per quello ad Est. In serie A, invece, il tricolore era un affare tra la Virtus di Djordjevic e Teodosic e la Reyer di De Raffaele e del suo granitico gruppo capace di conquistare già due scudetti. Era tutto apparecchiato per il gran finale e anche Flavio aveva raggiunto l’ultimo gradino prima del titolo: il 2020 si stava rivelando uno degli anni più belli della sua giovane vita.
La scuola terminò: storia era tornata sufficiente ma matematica no e quasi certamente sarebbe stato rimandato a settembre. Poco male, avrebbe recuperato. Le sue attenzioni, ora, erano tutte per la palla a spicchi. Come nel suo sogno, la finale della Western tra Lakers e Clippers fu decisa negli ultimi secondi di gara 7: Kawhi Leonard, Paul George e Lou Williams avevano trascinato i Clippers ad un passo dalle loro prime Finals per il titolo ma LBJ ed Anthony Davis avevano tenuto i giallo-viola attaccati alla partita. Mancavano sette secondi, i Lakers erano sotto di due ma con l’ultimo tiro a disposizione. “The Shot” lo prese un protagonista forse inatteso, Danny Green, e lo mandò a bersaglio: cugini eliminati e strada spianata verso l’anello in un remake delle finali anni ’80 contro i Celtics che, in sei gare, avevano avuto ragione di Giannis e del resto dei “cerbiatti”.
Anche nella partita decisiva del torneo Under 16, come per il derby di L.A., tutto si sarebbe deciso nelle battute finali. Mancavano quindici secondi, la squadra di Flavio era sotto di uno e nel time-out il coach aveva disegnato uno schema perfetto dove Ricky avrebbe passato la palla all’amico in lunetta. Da lì Flavio avrebbe potuto tirare comodamente per la vittoria o, in alternativa, cercare un fallo. Rimessa. Lo schema disegnato dal coach fu eseguito alla perfezione, restavano da giocare quattro secondi, Flavio si arrestò e rilasciò l’arancia morbidamente per il più facile dei canestri. Era tutto fatto, avrebbero vinto di uno e si sarebbero laureati campioni regionali. Purtroppo, però, il tiro si spense sul primo ferro, l’arancia venne conquistata dagli avversari e il suo “shot” non si rivelò quello giusto.
Dopo aver pianto mezzora di lacrime, inconsolabile, si fermò a pensare alla voce del sogno e capì che forse, per lui, c’era davanti una carriera lunga ma mediocre. Oppure, semplicemente, quello non era il suo “shot”. Magari sarebbe arrivato nei playoff del 2032 allo Staples Center. Magari.
Venezia aveva vinto il suo terzo scudetto in quattro anni e si era confermata regina d’Italia, mentre in America, a sorpresa, Boston aveva conquistato l’anello grazie alle magie di Gordon Hayward, Jayson Tatum e Kemba Walker sapientemente guidati da coach Brad Stevens. La stagione del basket 2019-20 si era ufficialmente conclusa, tutto era stato bellissimo e finalmente si poteva pensare solo alle vacanze. Flavio c’era rimasto davvero male per la sconfitta della sua squadra, così come per quella dei Lakers. Proprio nel pomeriggio successivo all’anello di Boston, però, aveva trovato un pacco davanti al cancello di casa sua: era una scatola di cartone, anonima, e dalla curiosità non aveva nemmeno letto l’indirizzo di provenienza. Prese delle forbici, tagliò lo scotch e il suo sguardo divenne improvvisamente gioioso. Con estrema cura strinse tra le mani l’arancia che aveva appena estratto dall’involucro che l’avvolgeva e rimirò più volte il logo e i colori di quella squadra di serie A. Insieme al pallone c’era anche un biglietto che lo invitava a svolgere un provino; Flavio non stette più nella pelle, si diede diversi pizzicotti per essere certo di non trovarsi in un altro dei suoi sogni impossibili ma quando realizzò che tutto era vero prese a palleggiare quell’arancia speciale e la lanciò orgoglioso verso il canestro sopra il garage. Era un’arancia inaspettata, un vero e proprio dono e tra finzione e realtà vide il pallone roteante aprirsi in due: restò sospeso, come cristallizzato e mostrò a Flavio il suo “The Shot”, quello decisivo che gli avrebbe segnato tutta la carriera.
L’arancia aveva appena compiuto il suo ultimo miracolo e Flavio si specchiò sotto a quella curva di tifosi impazziti di gioia, festanti, felici che, come lui, da sempre vivevano per momenti come quello.





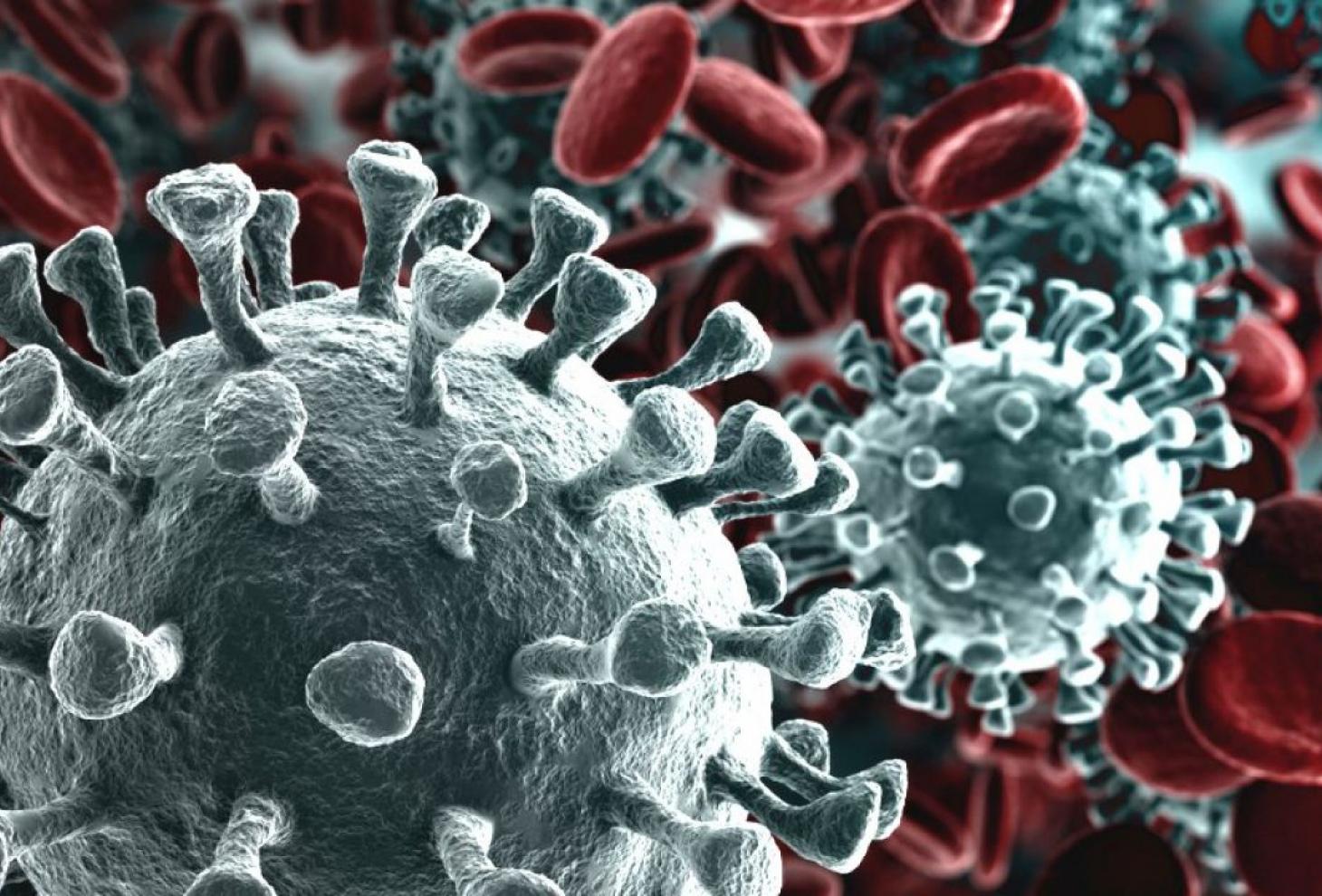





Bello e scritto molto bene. Non si leggono quasi mai racconti di questo genere sul basket. grazie!
Bello. Fa quasi dimenticare che ci sono,qui a Pesaro, degli amici morti dopo essere stati al Palasport per le finali di Coppa Italia con migliaia di tifosi cremonesi, bresciani e milanesi nel momento della “vera” esplosione del coronavirus.
Da non appassionata di basket…. sono rimasta incollata al racconto fino alla fine…. bravo Alessandro Piscitelli!
Bravissimo Alessandro, la tua arancia è davvero speciale, dolce e amara, piena di succo e ti lascia una piacevole sensazione.