28 giugno 1991
L’ultima Jugoslavia unita si appresta a mettere un’altra tacca sul suo cammino trionfale all’Europeo romano. In semifinale la Francia attende la sua ora al cospetto del Dream Team Europeo quando da Lubiana inizia ad arrivare l’eco delle bombe. La Slovenia, tre giorni prima, ha dichiarato l’indipendenza dalla Jugoslavia, che però non ha accettato serenamente la cosa: il 27 giugno esplode la cosiddetta “Guerra dei 10 giorni”, guerra-lampo che porterà all’indipendenza slovena e che farà di fatto da detonatore per la successiva implosione della federazione slava. Una generazione irripetibile, cresciuta fianco a fianco, da un giorno all’altro viene travolta da un processo più grande di quanto potesse percepire in quella che loro chiamavano “famiglia”: lo sport non era e non poteva essere “altro” dalla politica.
Per questo nella camera romana di Dusan Ivkovic, che di quella incredibile Jugoslavia era il timoniere, a poche ore dalla gara si presenta uno dei suoi ragazzi, Jure Zdovc. Non il più talentuoso (ce ne fossero eh, ma in mezzo a Divac e Kukoc, Radja e Paspalj…), non il più indispensabile. Ma comunque uno della famiglia. Sta piangendo al cospetto del santone serbo.
“Mancava poco alle 4 di mattina quando Zdovc è venuto nella mia stanza in albergo e mi ha detto, quasi in lacrime, che da Lubiana gli proibivano di giocare. Se l’avesse fatto, l’avrebbero considerato un traditore del popolo sloveno. Io continuo a considerarlo un mio giocatore, uno jugoslavo”. Ma il mondo sta cambiando sotto i loro piedi: da un giorno all’altro, Jure non è più uno jugoslavo, è uno sloveno di Maribor. “Politics is one thing, sport is another. Our team is like a family”, dice Kukoc ai giornalisti. Ma per Zdovc la medaglia d’oro, che, come da previsioni, arriverà pochi giorni dopo in finale contro l’Italia, non ci sarà. Ci sarà solo un pericoloso ritorno a casa nei giorni più tragici della storia della sua gente. Con un matrimonio mandato a monte dalla guerra, senza più una patria, senza più una famiglia: quella costruita sui campi da basket.

Nei giorni nei quali i carrarmati lasciano la capitale per dirigersi verso la rivoltosa repubblica accovacciata tra le Alpi giulie e le steppe ungariche, a Belgrado un playmaker ventenne di belle speranze ha appena firmato all’Okk Belgrado il suo primo contratto da professionista. E’ in macchina sull’autostrada che dal cuore dei Balcani affonda nelle sterminate campagne serbe quando un’auto gli piomba addosso. Un’incidente spaventoso dal quale esce per miracolo salvando la pelle, ma non la gamba sinistra, gravemente danneggiata al ginocchio e alla caviglia. Quattro operazioni in otto mesi non bastano a rimetterlo in piedi: Igor Kokoskov lascia il basket giocato ma non la palla a spicchi: la società gli propone di iniziare la carriera di allenatore, partendo dalle giovanili della piccola società nella sua città natale. Ci mette poco a scalare la piramide e, ad appena 24 anni, diventa il più giovane head coach del campionato.
Un enfant prodige.
La vita, come spesso accade, la cambiano però le sliding doors. Kokoskov se ne trova davanti una nel 1997, quando ad un clinic a Belgrado fa la conoscenza di Jim Calhoun, il santone di UConn. Un incontro che gli cambia la vita e che lo porta ad intessere rapporti sempre più stretti con il mondo collegiale americano. Fino a che, nel 1999, Quin Snyder lo vuole con sé come vice a Missouri: è il primo allenatore europeo ad essere full-time in uno staff tecnico di Division I. Un anno dopo, si prende lo stesso record ma al piano di sopra, in Nba, mettendosi agli ordini di Alvin Gentry ai Clippers.
Quindici anni da assistente sulle panchine di mezza Nba (dopo L.A., Pistons, Suns, Cavs, Magic e attualmente Jazz), un avventura di un anno alle spalle di Zeljiko Obradovic chiusa col fallimento della Serbia-Montenegro agli Europei 2005, la prima, grande chance sulla panca della Georgia, instradando un movimento che sta ora iniziando a raccogliere i frutti del suo lavoro. Ma un’altra porta girevole è dietro l’angolo.
Zdovc era stato l’ultimo cestista sloveno a mettersi al collo una medaglia in una competizione per nazionali con l’oro mondiale 1990. La Slovenia, nel suo tragitto solitario iniziato in quei giorni critici dell’estate 1991, ha sviluppato anno dopo anno generazioni di giocatori di grandissimo talento che però mai erano riuscite a chiudere il cerchio. Nesterovic, Smodis, Lakovic, Milic, Udrih, Nachbar, Vujacic, Lorbek e giù giù fino ai più giovani, i fratelli Dragic e ovviamente Doncic. È sempre mancato qualcosa, quel qualcosa che neanche Zdovc, l’unico in patria a sapere come fare, era riuscito a trasmettere ai team che aveva portato nel 2009 ai piedi del podio e nel 2015 fuori prematuramente dalla corsa ai metalli. E nemmeno l’Europeo in casa nel 2013 aveva dato migliori soddisfazioni, con Dragic e compagnia stoppati nei quarti da una Francia in missione.
A gennaio 2016 l’intuizione ce l’ha uno dei grandi del basket sloveno, Matjaz Smodis, nel frattempo diventato direttore sportivo della Nazionale: mettere in mano un gruppo di talento ma tutto da plasmare nelle mani di Kokoskov. Facendo leva su un dettaglio cruciale. “Credo sia un grosso vantaggio per noi che il coach abbia lavorato per così tanti anni con la nostra stella, Goran Dragic, e che abbiano buoni rapporti”, diceva Smodis presentando la firma. Eh sì perché i due si erano conosciuti nel 2008 a Phoenix, lavorando spalla a spalla per un triennio. Anzi, di più che semplicemente lavorare: Kokoskov fu colui che lo andò a prendere all’aeroporto di Phoenix per portarlo al primo workout pre-draft con i Suns.
Quel giorno nasce il grande rapporto tra i due, quel giorno nascono le fortune della Slovenia.
Un rapporto tanto forte da spingere Dragic, pungolato dopo la vittoria sulla Spagna di qualche giorno fa, a ritrattare (formalmente, visto che il calendario NBA impedisce a Kokoskov di essere sulla panchina slovena per le prossime qualificazioni mondiali) sul suo possibile addio alla nazionale: “Se resta il coach, resto anche io”. Goran sloveno, Igor serbo. La politica è una cosa, lo sport un’altra.
Kokoskov si affida mani e piedi al suo pupillo: è lui la stella, da lui si riparte. Perché la Slovenia che ora festeggia un’incredibile medaglia d’oro, poco più di un anno fa non era ancora qualificata per Eurobasket. Dopo la mesta debacle a Lilla 2015, i verdi il pass per Eurobasket 2017 se lo sono andati a prendere in Kosovo, in Bulgaria, in Ucraina. E l’uomo ombra sulla panchina degli Utah Jazz ha avuto da subito le idee chiare su come farlo: costruire una squadra da corsa con i tanti giovani al servizio del play ora a Miami. “Non si può essere testardi, si deve essere flessibili, accettando il gruppo che si ha a disposizione per quello che è ed aggiungendoci la propria filosofia – diceva Kokoskov in una intervista illuminante alla vigilia di Slovenia-Kosovo di un anno fa che avrebbe poi dato la certezza matematica della qualificazione agli Europei – io dico sempre che il basket moderno è il basket che vince. Chi vince detta quale tipo di basket sia vincente. Se vuoi giocare ad alto ritmo ma non hai i cavalli per farlo, devi per forza andare più piano. Per fortuna una delle nostre forze è che abbiamo guardie ed ali che possono spingere e giocare up-tempo, specialmente con Goran che lo ha fatto per anni a Phoenix e che ha queste caratteristiche nella sua natura. Io ho lavorato con stili di gioco diversi, ero ai Suns quando giocavamo con Steve Nash ed ero ai Pistons quando giocavamo sempre a metà campo. Non ho preferenze: finché si vince, va bene. I tifosi vogliono vedere la propria squadra vincere e io non voglio certo giocare veloce e perdere. Ho solo assecondato gli input che arrivano dai giocatori, cercando di accentuare i punti di forza e coprendo quelli di debolezza”.

E così la Slovenia di Kokoskov corre, pressa, corre e ancora pressa da oltre un anno, dal netto 113-68 con il quale si sbarazza del Kosovo il 31 agosto 2016 all’esordio nelle qualificazioni europee, che i verdi chiudono con sei vittorie su sei segnando 89,3 punti a partita, primo attacco del continente.
Questa era la squadra che 13 mesi fa si presentava alla Stozice Arena di Lubiana. Sette su 12 c’erano anche qualche giorno fa ad Istanbul e ci sarebbe stato anche l’altro Dragic, quello milanese, voluto a tutti i costi dal fratello Goran sul podio con il resto della squadra, al netto dell’infortunio al ginocchio dal quale sta recuperando. Solo due over 30 (Dragic e Zagorac, più Vidmar che ha festeggiato i 30 con la vittoria sulla Spagna in semifinale) e tanti giocatori con già esperienza europea alle spalle ma con la fame giusta per accaparrarsi il proprio posto al sole. Ma soprattutto la voglia di essere una squadra. “A volte ho ancora gli incubi pensando a quella partita con la Francia agli Europei del 2013 – rammentava Dragic a marzo 2016 – voglio vincere una medaglia o un titolo con la mia nazionale prima di ritirarmi. Ma prima dobbiamo qualificarci”. Non fermarsi mai, puntare ogni volta più in alto con umiltà e dedizione è uno dei segreti del successo di Goran Dragic.
Carico a molla, nel pieno della maturità e con un basket disegnato su misura per lui, il Dragone sloveno fa vedere di essere pronto a caricarsi in spalla la squadra ancora una volta. Ma la batteria di onesti mestieranti messagli al fianco non può bastare per i propositi di medaglia. Ci vuole qualcosa in più.
Un paio di telefonate a Madrid, tanto per cominciare. La prima al nuovo Messia dei Balcani: quel Luka Doncic che nel frattempo ha rifiutato le lusinghe della Spagna per giurare amore eterno alla sua patria natale. “Lo conosco sin da piccolo avendo giocato col padre, era uno dei ragazzini che giocava col pallone durante le nostre partite – raccontava Goran nell’invernata guardando verso Eurobasket – gli auguro tutto il meglio, soprattutto di restare sano perché è la cosa più importante”.

Non basta ancora. E allora perché non giocarsi la carta della naturalizzazione in modo più “efficace” del pur onesto Alen Omic (bosniaco di Tuzla trapiantato in terra slovena) con un giocatore che dia qualità, esperienza e versatilità in un reparto lunghi dove non possono essere sufficienti cuore e sapienza di Gasper Vidmar? Andato a vuoto il tentativo con Bryant Dunston (che ha preferito… l’Armenia), ecco il colpo: Anthony Randolph. “Ci dà la possibilità di avere un modo diverso di giocare – dice Dragic alla vigilia della finalissima contro la Serbia – in passato non abbiamo mai avuto uno cui alzare degli alley-oop, che può cambiare su tutti in difesa, che può tenere i big men e che può sparare sia dalla media che da 3. È un giocatore completo, penso che dovrebbe essere in NBA”.
I Big Three – Slovenia Edition sono pronti alla battaglia.

Massimizzare i pregi, coprire i difetti, diceva Kokoskov. E il serbo che vive tra i mormoni ha trovato la formula giusta.
La Slovenia è stata fondamentalmente una squadra che ha prodotto quantità, giocando ad alto numero di possessi volando sulle ali delle folate di Dragic in primis e Doncic in seconda battuta. Attaccare il ferro di continuo, sia in transizione che a difesa schierata, è stato un mantra del gioco dei balcanici, che fosse per andare al ferro o per trovare con i piedi sull’arco i tanti cecchini appostati in posizione di sparo. Perché è vero che la percentuali di squadra non è stata eccezionale (zavorrata dal non esaltante 31% su quasi 7 tentativi a partita di Doncic, che, a voler trovare il pelo nell’uovo del suo strepitoso Europeo, ha tirato 2/12 tra semifinale e finale), ma i quattro migliori tiratori della squadra hanno tutti volato sopra il 40%, messi in ritmo dalle percussioni del Dragone (5,1 assist a sera oltre ai 22,6 punti messi in proprio): Randolph (41,7% su 2,7 tentativi), Blazic (41,7% su 1,3 tentativi), Nikolic (42,9% su 0,9 tentativi) e soprattutto Prepelic (43,8% su 5,3 tentativi), l’aspirante terzo violino in verde.
La Slovenia ha segnato tanto (2° attacco del torneo, di un soffio dietro la Lettonia) rendendo produttiva ai massimi una pallacanestro dispendiosa (chiedere ai muscoli di Dragic azzannati dai crampi nei minuti finali del match con la Serbia) e che porta spesso a generare caos e palle perse: la Slovenia ha chiuso al 22° posto per turnovers con appena 11,0 a partita, di un soffio dietro a Ungheria ed Italia. E questo concretizzando con percentuali di poco superiori alla media del torneo. Pazzesco.
Tra i difetti da coprire, sulla carta, doveva esserci la tenuta sotto canestro. Certo, il passaporto di Randolph era arrivato anche per quello, ma un onesto mestierante dei campi europei come Vidmar e un Dimec che dopo aver acceso i sogni di qualche scout Nba un paio d’anni fa è rimasto a svernare a Novo Mesto sembravano decisamente pochino per duellare contro i Gasol e i Marjanovic, i Valanciunas e i Lauvergne. Ma se tanto l’ala del Real (in positivo) quanto il lungo del Krka (in negativo) non hanno tradito le attese, il rendimento del lungo sul quale Boscia Tanjevic puntò in gioventù senza mai vederne l’esplosione è stato a dir poco clamoroso. Troppo basso per un centro con zero tiro da fuori (2,08 ufficiali), troppo poco tecnico per portare a scuola gli avversari in post basso, troppo lento per inseguire i piccoli lontano dal ferro, Vidmar ha fatto dimenticare a tutti i suoi difetti massimizzando i suoi pregi: blocchi di granito, presenza difensiva in area (4° per stoppate a 1,4 a partita), intelligenza tattica sopraffina (2,1 assist di media, a pochi decimi di punto da lunghi osannati per la loro visione di gioco come i Gasol, Saric e Diaw).
The Slovenian Rock.

A dare un mano significativa nel pitturato è stato anche Luka Doncic. Il baby prodigio ha iniziato il suo Europeo con qualche titubanza soprattutto al tiro (0/5 da 2 contro la Polonia all’esordio, 0/5 da 3 contro la Finlandia il giorno dopo), ma la sua importanza nell’economia del gioco sloveno e in particolare nella lotta sotto canestro è stata cruciale. La stellina madridista ha chiuso al 4° posto tra i migliori rimbalzisti DEL TORNEO con 8,1 carambole tirate già a partita, 1° con distacco se consideriamo solo gli esterni (Ponitka non è lontanissimo con 7,2, gli altri sono ad anni luce). Una forma mentis la sua, più evidente in fase offensiva, quando non è raro vederlo volare dietro alla parabola del suo stesso tiro, ma più redditizia in difesa, con una capacità innata di incunearsi in area sfruttando, nel caso specifico, il pazzesco lavoro sul tagliafuori di Vidmar.
Quando ne ha voglia, poi, si mette pure a stoppare. E a scherzare Porzingis.
Potential No. 1 pick Luka Doncic (he’s 6-7) protects the rim on one end then backs down Porzinigis on the other. (Porzinigis has 3 fouls) pic.twitter.com/zVD14CtTr2
— Harrison Wind (@HarrisonWind) 12 settembre 2017
Punti, difesa, rimbalzi, ritmo. Tutto giusto, tutto bello. Ma la Slovenia ha dimostrato prima di tutto di essere quello che non era mai stata nel ventennio abbondante della sua storia cestistica: una squadra. E il quarto periodo della finalissima contro una Serbia ringalluzzita dopo 30’ di rasoiate in faccia dall’indemoniato Dragic ne è stato il manifesto. La caviglia girata di Doncic e i crampi del Dragone sembravano davvero troppo anche per una squadra in missione come quella dei nostri vicini orientali. Significava togliere due pezzi con un impatto offensivo sul proprio team senza paragoni tra le altre big di questo Europeo.
“Avevo piena fiducia nei miei compagni – ha confessato Dragic – Prepelic è venuto fuori alla grande. Blazic è venuto fuori alla grande. Sapevamo come giocare di squadra e lo abbiamo fatto. Non ero impaurito. Nervoso, al massimo”.
“Non ho potuto aiutare i miei compagni, ma apparentemente oggi non avevano bisogno di me – ha ricordato Doncic – hanno vinto la partita contro una squadra forte come la Serbia. Sono davvero orgoglioso di loro”.
E loro di te, Luka.

Se un gruppo di persone è una squadra, tutti sono utili, nessuno indispensabile.
Zdovc non era la stella della Jugoslavia dei fenomeni, che sotto il proprio ombrello teneva insieme anche coloro che oggi stanno su parti opposte della barricata. Ma era uno del team, uno della famiglia. L’esperienza vissuta sulla sua pelle non era riuscito a replicarla infondendola in gruppo con la maglia verde addosso. Paradossalmente, invece è stato un serbo ad indicare la via, per di più a scapito della sua stessa patria. Ma, come direbbe Kukoc, la politica è una cosa, lo sport un’altra.
















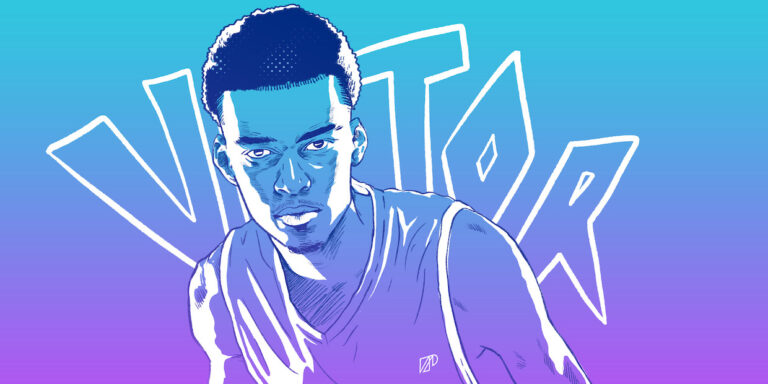









Io ti dico grazie per l’articolo.