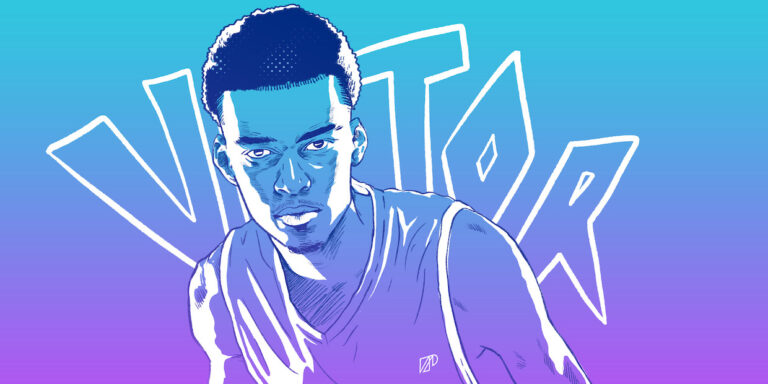Non affliggerti a motivo dei malvagi,
non portare invidia a quelli che operano in modo perverso,
perché saranno presto falciati come il fieno e appassiranno come l’erba verde.
Confida nell’Eterno e fa’ il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà.
Prendi il tuo diletto nell’Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore.
Rimetti la tua sorte nell’Eterno, confida in lui, ed egli opererà.
Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce, e la tua rettitudine come il mezzogiorno.
(Salmo 37 di Davide, tatuaggio sul braccio sx)
Seattle, Washington, Luglio 2015. Paul Allen non è più un pezzo grosso di Microsoft da diverso tempo, seppur ne sia stato il fondatore assieme a Bill Gates, ma quell’estate il telefono continuava a squillare, squillava sempre. Certo, due soldi li aveva messi da parte, se è vero che con gli anni era riuscito a farsi due yacht ed a costruire un museo dedicato ad un suo idolo di gioventù ed eroe locale, l’immortale Jimi Hendrix. Dall’altro lato del filo, però, non c’erano quasi mai i dirigenti dei suoi Seahawks della NFL, e neppure i neonati Sounders del campionato di calcio americano: c’era Terry Stotts, head coach dei Portland Trail Blazers. Incazzato nero.
Già, perché i Blazers avevano perso male, se non malissimo, una serie di primo turno play-off con Memphis. Avevano appena perso (quasi) tutti i titolari. LaMarcus Aldridge era tornato in Texas ad affiancare un ormai stanco Tim Duncan in pitturato, Nicolas Batum aveva deciso di svernare a Charlotte dopo 7 stagioni in Oregon, Wes Matthews si era rotto il tendine d’achille mesi prima e se ne andrà di lì a poco come il suo sostituto, Arron Afflalo, mentre Robin Lopez era stato seviziato in quella serie dai lunghi dei Grizzlies e, alla fine, è stato richiamato a fare le valigie. I discorsi nella cornetta erano, presumibilmente, gli stessi che facevamo noi al campetto: “Ma quante ne vince Portland?” “Così non si può andare da nessuna parte!” “Nella Western Conference non hanno scampo.” “Hanno rifatto una squadra senza una squadra, incredibile”. A Settembre, gli stessi pagati ed autorevoli opinionisti nutrivano più di un qualche, ragionevole dubbio. Ma l’errore era dietro l’angolo. Semplicemente, stavamo clamorosamente sottovalutando la squadra del più sottovalutato giocatore NBA.
“Ho scelto il numero zero perché sono nato ad Oakland,
sono andato a scuola ad Ogden,
e ora sto giocando in Oregon.”
(“The Letter ‘O’”, il debut album Rap di Damian Lillard)

Il numero zero non sembra un caso. Nella NBA attuale sembra passato di moda, fatta eccezione per Kevin Love, Russell Westbrook e pochi altri, mentre una volta chi lo indossava lo poteva lanciare come provocazione, perché la critica lo identificava col giocatore, e viceversa: Gilbert Arenas lo scelse ad inizio carriera, appena draftato (solamente) con la N.30 dai Golden State Warriors, in quanto un suo ex Coach pronosticò che non avrebbe giocato neppure un minuto nella lega più bella del mondo. La storia ispirò anche l’adidas, che, quasi 10 anni fa, ne trasse un famosissimo spot pubblicitario.
Qui, però, siamo totalmente fuori strada. Parliamo di uno che si è fatto un mazzo così senza alzare la voce contro nessuno, neppure ai tempi del liceo, quando ad ogni estate si passava da una high school all’altra perché si cercava un team che non gli facesse riscaldare la panchina troppo a lungo. Le ultime due annate sulla baia furono soddisfacenti, ma non abbastanza per consentirgli una borsa di studio di prima classe. Da Oakland ad Ogden, Weber State, Big Sky Conference. Dalla splendente California al freddo Utah, senza batter ciglio e senza rimorsi, in un’università con pochissima tradizione cestistica, cui figura di riferimento nei ’70 era stata quella del compianto Willie Sojourner (per i reatini, semplicemente, “lo zio Willie”). Bisognava dimostrare tutto, con la consapevolezza che si sarebbe sfiorato a malapena il torneo NCAA – che effettivamente non fu mai raggiunto. Ha lottato contro gli infortuni, perché la rottura del piede da junior gli poteva condizionare la carriera in modo inevitabile. Ha collezionato premi e riconoscimenti, pur fini a sé stessi: del resto un esterno come lui con la maglia dei Wildcats non si era mai visto e, di certo, la Conference di riferimento non è fra le più competitive. Al giorno d’oggi, i grandi campioni vengono scelti dalle franchigie NBA dopo uno, massimo due anni di college. Damian Lillard se li è fatti tutti.
Damiano è un fenomeno, e fin dagli esordi fu abbastanza chiaro ai tifosi di Portland con chi avessero a che fare: il suo debutto in NBA, contro i Lakers, inizia con una sontuosa tripla, a due passi dall’arco, in faccia ai miseri resti di Steve Nash; continua con un botticelliano passaggio schiacciato dietro la schiena ad assistere uno smarcato LaMarcus Aldridge; si chiude con un totale di 23 punti e 11 assist messi a segno sul referto.
Ma quello che più colpisce è l’attitude, la grande consapevolezza di doversi porre come leader della squadra, nettamente inusuale in un rookie. Damian possiede un letale mix di concentrazione, autorevolezza e freddezza a cui si accompagnano grandi doti realizzative e visione di gioco, e mostra una certa leadership dentro e fuori dal parquet. Esattamente quello che serviva ai Blazers, che, dopo la prematura scomparsa delle carriere di Greg Oden e Brandon Roy, erano alla disperata ricerca di una stella da affiancare al buon Aldridge.
“Non gioco in maniera egoista.
Mi piace trovare i compagni in campo
e metterli in condizione di giocare bene”
Quelli che, prima del draft in cui Portland lo scelse with the 6th pick, tacciavano Lillard di egoismo e nutrivano dubbi sulla sua capacità di giocare bene con costanza a livello NBA, ben presto rimasero con l’amaro in bocca. Dopo aver iniziato la stagione con tre gare di fila in cui aveva totalizzato almeno 20 punti e 7 assist, mostrò grande costanza di rendimento e stupì per l’all-aroundness (termine che, se non esiste, invento adesso) del suo gioco.
If you make it in New York, you can make it anywhere, o almeno così dicono.
Nel dubbio, nella sua prima visita al leggendario Madison Square Garden, Lillard mise a segno 21 punti, 6 assist, 5 rimbalzi e 2 recuperi, e fece persino esultare involontariamente qualche tifoso avversario quando suggellò la performance con una tripla decisiva a pochi secondi dal termine.
Da quel momento iniziarono a sprecarsi i paragoni: Damiano iniziò ad essere additato come il nuovo D-Rose, il nuovo Westbrook, il nuovo Chris Paul. Secondo Pistocchi, era un De Nicolao più atletico.
Tutti paragoni sbagliati, persino l’ultimo: l’unicità di Lillard sta anche nella completezza del suo repertorio offensivo, che lo rende pericoloso da ogni punto del campo e gli permette di attaccare efficacemente in pitturato pur non essendo un atleta straordinariamente esplosivo. In pochi possono vantare la creatività con cui riesce a trovare soluzioni di appoggio a canestro.
La stagione 12/13 dei Blazers non fu particolarmente esaltante. Il quintetto composto da Lillard, Wesley Matthews, Nicolas Batum, Aldridge e J.J. Hickson era certamente solido, ma il supporting cast era decisamente mediocre: basti pensare che quello con più punti nelle mani in uscita dalla panca era il sesto uomo Eric Maynor, oggi alla Openjobmetis Varese, che ne faceva 7 a partita.
Nonostante qualche vittoria in più rispetto all’annata precedente, la stagione si concluse con record negativo e mancata qualificazione ai playoffs.
I tifosi di Portland però ebbero comunque motivo di sorridere, perché il nucleo base faceva ben sperare e soprattutto per il primo anno di Lillard, che fu decisamente spettacolare.
Totalizzò 19 punti, 6 assist e 3 rimbalzi di media a partita, medie ottime per una matricola, vinse all’unanimità il titolo di Rookie of the Year (il cui acronimo, manco a dirlo, è ROY) e si tolse la soddisfazione di insaccare la tripla della vittoria contro gli Hornets di Anthony Davis, il rookie inizialmente più quotato per la vittoria del prestigioso titolo individuale. Fu inoltre il secondo Blazer a totalizzare 1500 punti e 500 assist in una singola stagione: l’altro, wait for it, era stato Clyde Drexler.
Con una stagione d’esordio così, non potevano che esserci grandi aspettative per l’anno da sophomore.
Sarebbero state superate oltre ogni previsione.
“La reputazione è qualcosa che devi continuare a guadagnarti.
Se non lo fai, sparirà come se non fosse mai esistita.”
“Ogni volta che scendo in campo,
mi sento come se stessi dichiarando che appartengo a questo livello”
La storia insegna come ad un anno da rookie eccelso possa seguire un calo drastico nella stagione successiva, che sia per una sensazione di appagamento o per un mutamento delle circostanze: l’esempio più lampante e recente è quello di Micheal Carter-Williams, che ancora oggi fatica a trovare il ritmo e la forma del suo straordinario primo anno nel deserto di Philadelphia.
Eppure, tra le critiche e i malumori per l’ingaggio di Robin Lopez – “il fratello scarso di Brook” – e per la costanza di rendimento di Batum, e tra i dubbi sul mancato salto di qualità di Matthews e le richieste di trasferimento di Aldridge, pareva che l’unica certezza dei Blazers fosse il giovane Lillard, nonostante fosse quello con meno esperienza nel roster.
Eppure non solo Damian si mostrò all’altezza del compito, portando le sue prestazioni a livello All-Star, ma gli ingranaggi del meccanismo orchestrato da coach Terry Stotts iniziarono finalmente a girare: Lopez si rivelò fondamentale per gli equilibri difensivi in pitturato, Matthews trovò finalmente la quadratura del cerchio del pallone in uscita dai blocchi e divenne letale, Batum riuscì a trovare più continuità e sostanza in difesa e Aldridge disputò arguably la miglior stagione della sua carriera.
Il nostro, proprio in questo periodo, realizzò un totale di 62 punti in due nottate consecutive, rispettivamente contro Cleveland e Minnesota. Potrebbe essere la chiave di lettura dell’intera stagione di Lillard: la capacità di portare in campo, ogni sera, una dose sicura di qualità offensiva. Solo in tre occasioni realizzò meno di dieci punti, e in una di queste (l’ultima di regular season contro i Clippers) ne fece 9 in 12 minuti.
Quando un compagno di squadra infonde tanta sicurezza, spesso porta anche gli altri che indossano la stessa casacca ad acquisire più fiducia in attacco – ed è esattamente quello che successe, visti i netti miglioramenti dei comprimari durante il corso della stagione.
A Febbraio Lillard ebbe un All Star Weekend pienissimo, in cui divenne il primo giocatore della storia ad essere convocato per il Rising Stars Challenge, lo Skills Challenge, il 3-Point Contest, lo Slam Dunk Contest e l’All Star Game (insieme ad Aldridge). Neanche il tempo di fare il bucato tra un evento e l’altro.
La trionfale stagione, conclusasi a ben 54 vittorie, consentì ai Blazers l’accesso ai playoffs, in cui si trovarono a fronteggiare gli Houston Rockets di James Harden e Dwight Howard. La serie non fu mai davvero in dubbio, sia per la maggior efficienza del sistema offensivo di Portland che per le grosse lacune difensive dei texani: se un falegname ebreo diceva nemo propheta in patria, Aldridge di certo non ne sapeva nulla, e viaggiò a 30 punti di media nelle 6 partite disputate. Lillard, dal canto suo, esordì anch’egli con un sano trentello in gara 1, per poi mantenere la media sopra i 25 punti a partita.
Ma il simbolo di questa serie fu il finale della gara 6 disputata al Moda Center.
Inutile cercare di descriverlo.
Poco importa che al turno successivo i Blazers fossero stati eliminati in ciabatte dagli Spurs per 4-1: l’aver superato il primo turno per la prima volta in quattordici anni era la piccola grande soddisfazione che il popolo dei Blazers aspettava da tempo, per rifarsi delle sfortune, degli errori dirigenziali, delle occasioni perdute.
Nulla di eclatante, nulla di memorabile per gli annali della lega: ma un ricordo sicuramente da incorniciare con cura per la storia recente della franchigia.
E l’artefice era proprio lui, il sophomore draftato alla 6 nella stagione precedente.
“I see the world from the lens of my own perspective, I see the anger driven by color in a recession — sad to see the reality of our regression”
Opinione personale: partecipare al camp estivo di Team USA in preparazione del mondiale dev’essere un’esperienza a metà tra il raggiungimento del Nirvana e quel momento in cui si fanno le squadre all’oratorio. Beh, se tagliamo la parte di Paul George che si distrugge la gamba contro la base del canestro.
Per Lillard, invece, è stato il momento in cui ha capito che, nonostante le sue ottime prime due stagioni, nella considerazione generale non era ancora considerato tra i migliori giocatori della lega, e questo probabilmente lo spinse a migliorarsi ancora di più.
Confermato il nucleo della stagione precedente, i Blazers affrontarono un’annata molto più complessa, a causa delle assenze a lungo termine di Lopez e Matthews, ma grazie all’ingaggio del cecchino Arron Afflalo e le solide prestazioni del veterano Kaman e del giovane Meyers Leonard riuscirono comunque a scollinare le 50 vittorie stagionali.
La Regular Season di Lillard fu ancora estremamente solida, con gemme come il quarantello (più dieci assist) regalato per Natale agli Oklahoma City Thunder, che gli valse la seconda convocazione all’All Star Game e fu l’ennesimo statement a dimostrare che era uno dei top 5 del ruolo.
Purtroppo la stagione si concluse in sordina, in una serie senza storia contro i Memphis Grizzlies. Unica nota positiva, iniziò a farsi finalmente notare C.J. McCollum, che aveva disputato una prima stagione piuttosto sottotono.
Oltre che a confermarsi una stella in campo, Lillard intraprese anche la carriera musicale, sotto il nome d’arte di Dame D.O.L.L.A. (acronimo, credo, di Damien Ollie Lamone Lillard), il che si rivelò ben più di una mera gimmick ma un lato inscindibile della sua personalità. Inizialmente accolto con perplessità, ben presto il suo talento da rapper si rivelò più profondo e creativo di quanto ci si potesse aspettare.

Prima del debuttare con un singolo (“Soldiers In The Game”) nell’estate del 2015, Damiano aveva dato vita al #4BarFriday, sfidando fans e “colleghi” a dar mostra delle loro capacità di freestyle su Instagram, e già allora aveva dimostrato gran talento.
Non sono mancati endorsements dalla Lega (che fu ben meno supportiva della carriera musicale di Iverson, per dirne uno) e da parte di compagni e altri giocatori, nonché delle collaborazioni di livello con artisti del calibro di Lil’ Wayne.
Non è certamente il primo cestista a tentare la carriera di rapper: i più noti erano Shaq (che inspiegabilmente vinse anche un disco di platino al debutto), il già citato Allen Iverson e the player formerly known as Ron Artest, ma ricordiamo – con cordoglio – le iniziative musicali di Steve Francis, Tony Parker e Jason Kidd, e anche Iman Shumpert e Chris Webber che in realtà avevano una discreta dose di talento.
Talento musicale che non manca al nostro Dame, che nei suoi rap parla della sua vita ad Oakland e del desiderio di vincere un anello, ma pure di temi più controversi come gli episodi di violenza da parte delle forze di polizia e la necessità di stare uniti con il prossimo durante i tempi più duri, per altro tirando fuori delle lyrics niente male per tecnica, flow, e profondità di significato. Lillard mostra di essere uno che, per citare una sua campagna pubblicitaria adidas, Here To Create, cerca di valutare il mondo e sé stesso con grande spirito critico e personalità, con uno stile personale dentro e fuori dal campo, che lo rende diverso rispetto alla massa.
Secondo il famoso rapper canadese Drake, che io personalmente apprezzo quanto una cartella esattoriale di Equitalia, lo Sport e la Musica sono due mondi estremamente complementari: “They want to be us, and we want to be them.”
Damian Lillard è, nel suo piccolo, il punto di congiunzione tra questi due mondi, ed è unico per il talento sopraffino che dimostra in entrambi.
Personalmente non posso che consigliare di dare personalmente un’occhiata alle canzoni, e magari al suo ultimo album, The Letter O.
“In questa estate (2015) si è consumato il peggior scenario possibile per i Blazers”
(Alex Kennedy)
“Non serve essere dei geni per capire che Portland farà almeno due, tre passi indietro.
Voglio fare gli auguri a tutti i miei amici di Rip City”
(Moke Hamilton)
“Preparatevi, tifosi Blazers.
Scordatevi le 50 vittorie e la corsa play-off, ne avrete per molto tempo.”
(Lang Greene)
I giudizi autorevoli degli opinionisti di Basketball Insiders ci riportano alla nostra introduzione. Coach Stotts vede sbucare dal mercato estivo Noah Vonleh, Gerald Henderson, Mo Harkless, Al-Farouq Aminu, Ed Davis e Mason Plumlee, e dopo due campi prestagionali di 5vs5 capisce che “No, non siamo davvero più quelli di prima”. Inoltre, se nel 2014 Portland si presentava senza scelte al draft dopo 15 anni, nel successivo l’unica pesca dei Blazers fu quella di Hollis-Jefferson, poi spedito come pacco regalo a Brooklyn. La decisione presa dalle alte cariche della dirigenza (quindi, anche dallo stesso Paul Allen) fu quella di ricominciare da zero, e dallo zero. Non ci si provò neanche, a cercare un sostituto per Aldridge: e non siamo più nemmeno a Weber State. Ma questa è la squadra di Damian Lillard.
C’è bisogno di tempo, ovviamente, perché stiamo pur sempre parlando di una formazione under 25. Portland inizia male, malissimo: perde le prime due partite contro i derelitti Phoenix Suns, a Novembre incassa 7 battute d’arresto consecutive, chiude l’anno solare con un record di 14-21 complice un lungo giro di trasferte prenatalizio, capitato nel momento peggiore per una compagine così inesperta. Persino il calorosissimo pubblico del Moda Center non fa più registrare il tutto esaurito ma, dopo aver toccato il fondo proprio nel periodo dell’Epifania, Damiano suona la carica: 31+9 assist nello scalpo eccellente di Oklahoma City, doppia-doppia contro Utah e in casa dei Nets, essenziali per far riprendere fiducia a tutto l’ambiente. Una grande mano – finalmente – arriva da CJ McCollum, uscito da Lehigh University con l’etichetta di futuro giornalista, finito per diventare il segreto di Pulcinella dei Blazers: il ventello di media col quale chiude l’annata 2015/16 gli varrà il premio di Most Improved Player (giocatore più migliorato) della stagione. Stotts tiene ben salda la sua panchina, anche perché i suoi collezionano 18 vittorie fra Gennaio e Febbraio: ciò non basta a garantire a Lillard un posto, quanto mai doveroso, all’All Star Game, cui parteciperà beffardamente il suo vecchio compagno Aldridge. Lo zero se la prende, chiaramente. Ma in silenzio, sul campo. Come ha sempre fatto durante la sua carriera. Guarda caso, subito dopo la pausa, arriva Golden State…
I Blazers ne mettono 137 in faccia ai campioni in carica. “Dame” fa registrare il massimo in carriera in punti (51), recuperi (6) e triple (9), davanti ad un incredulo Steph Curry: sarà una delle nove sconfitte stagionali dei Warriors. Se si pensa al tipo di giocatore che è Lillard, col suo passo, con la sua andatura in una pallacanestro che tende sempre più ad estremizzare velocità e atletismo dei suoi attori, cinquantuno punti realizzati da una point guard sono surreali. Tecnica sopraffina, superba intelligenza cestistica, capacità di coordinazione evidente sia nell’uso del corpo che nel saper modificare in poco tempo le proprie decisioni. Con queste basi, l’uomo arrivato proprio dalla Oakland dei Warriors ha conquistato una volta di più la gente dell’Oregon.
E’ una vittoria che ha un doppio significato, perché il record di Portland scollina così oltre il 50%. Da qui in avanti ci sono alti e bassi, ma non si può dire lo stesso dello stato di forma del playmaker: altro cinquantello servito in casa dei Raptors (tòh, l’ASG si giocava proprio a Toronto…), 41, conditi da 11 assist, nell’importante successo con Washington. Si arriva ad Aprile, dove accade ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato, neppure nei talk-show da salotto NBA. Fra Thunder, Spurs e Splash Brothers, al grande ballo dei play-off ci sono pure gli enfants terribles del Nord-ovest. E’ un miracolo. Ed è inutile specificare chi sia stato, ancora una volta, il principale artefice di tutto.
Al primo turno c’è Los Angeles, sponda Clippers. I Trail Blazers escono dalle due sfide iniziali in California con le ossa rotte e un 2-0 secco. “La favola è finita”, “Grazie ragazzi”, pronostici e commenti di metà primavera recitavano ripetutamente gli stessi contenuti. C’è sempre quello che non è d’accordo, però. Damiano piazza il trentello in una difficile Gara 3, e nel quarto scontro c’è l’harakiri dei Clippers, che in 48’ perdono Chris Paul (frattura alla mano, dopo un intervento difensivo su Henderson) che Blake Griffin, costretto a lasciare il campo dopo essere atterrato male su un jumper, totalmente da solo. “La solita sfiga dei Clips”, direbbe Federico Buffa. Portland impatta la serie, espugna L.A. senza troppa fatica e chiude sul 4-2 davanti al pubblico amico. Lillard gioca senza strafare, per la verità, ma è impressionante come il supporting cast attorno a lui sia migliorato nel corso dei mesi, uno su tutti Papé Satàn Aminu: è un segno di come la fiducia e la stima riposta verso i compagni sin dal momento del training camp abbia fatto emergere le qualità migliori dei giovanissimi della Rip City.
“Se vuoi ben figurare davanti a migliaia di persone,
devi lavorare meglio di migliaia di persone”
Tolto lo sfizio della semifinale, quella contro Golden State diventa quasi una passerella. Damian chiude ogni match del secondo turno da top-scorer, in gara3 ne mette 40, con 8 bombe, nell’unica affermazione sui Warriors. E’ l’ultima soddisfazione di un’annata incredibile. Difficilmente avrà mai in carriera la visibilità di un Westbrook, se vogliamo parlare di numeri zero. La stessa Portland, come dimostra anche l’inizio di questo 2016/17, non riuscirà a competere per il titolo prima di lungo tempo.
Quella Portland, situata all’estrema periferia degli States, deve il nome all’omonima Portland del Maine, quello spesso descritto nei libri di Stephen King: da quei luoghi proveniva infatti uno dei pionieri – in inglese, appunto, Trail Blazers – giunti fino a quelle terre di frontiera. Il nome “copiato” è forse l’unica pecca per la metropoli più cult, che più rappresenta quella cultura alternative che si fregia di una genialità spesso incompresa, quasi sempre per pochi e costantemente fuori dal coro. E, naturalmente, la patria di Matt Groening, Chuck Palahniuk e Tommy Thrayer non poteva non innamorarsi subito e follemente di quel playmaker col numero zero, con il tatuaggio biblico, una delle rarissime scelte azzeccate al draft dai Blazers e decisamente il giocatore più alternative della lega: quel Damian Lillard da Oakland che li ha portati oltre il primo turno di playoffs per la prima volta in quattordici anni e che, in un caldo settembre, si è reso conto di essere il leader di una squadra di scappati di casa su cui neanche Anfernee Hardaway avrebbe scommesso un penny.
Sarà stata quella tripla decisiva contro Houston, giunta al termine di un quarto periodo in cui dall’arco non era entrato nulla, a consacrarlo definitivamente come the man agli occhi di tifosi e dirigenza? Quella bomba che fece urlare di gioia il Moda Center ma non lui, che sul campo non esulta mai. Una volta, al liceo, si fece fischiare un fallo tecnico per una celebrazione troppo esuberante sul canestro del +1 a spiccioli sul cronometro. Quei due liberi gli costarono la partita.
Ferrea concentrazione in campo, ricerca ossessiva della vittoria, ripudio per lo swag, due palle così: perfetto per l’Oregon, insomma. Un (anti) eroe che ha imparato a fare il gesto dell’orologio ogni volta che scocca il tiro decisivo. Cioè, sempre.
Do you know what time it is?
a cura di Carlo Pedrielli e Davide Romeo
disegno di Damian Lillard a cura di Diego Di Nunzio