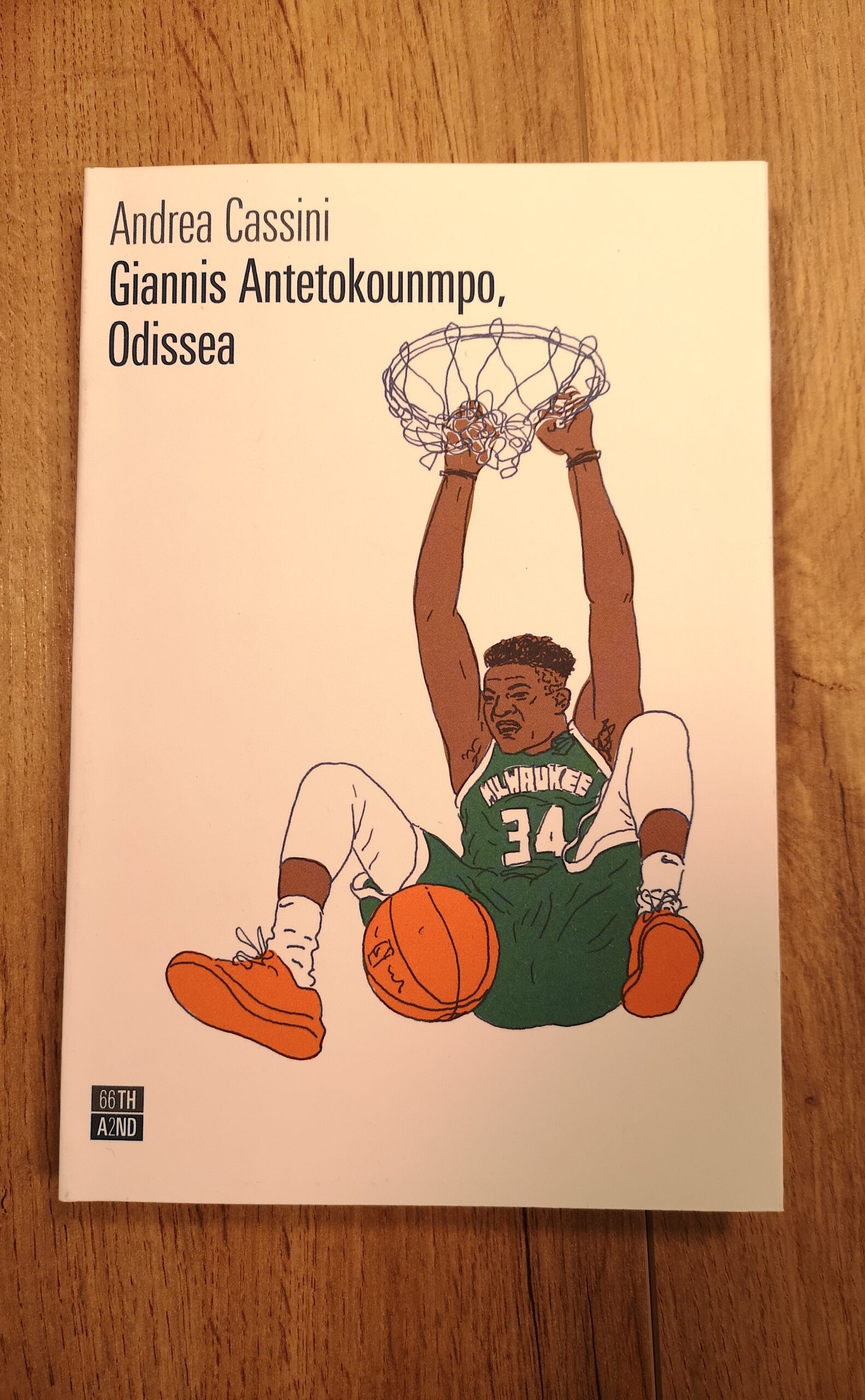illustrazione di Paolo Mainini
articolo di Andrea Cassini
tratto dal libro “Giannis Antetokounmpo, Odissea” https://amz.run/6CJd
Sembra un’operazione difficile mettersi a raccontare la carriera – quasi a tirarne le somme, come si fa dopo il ritiro o sul viale del tramonto – di un giocatore che, per quanto sia in NBA da una vita, in realtà ha solamente 28 anni. Si trova all’apice fisico e tecnico del suo gioco, è nella squadra più competitiva in cui abbia mai militato, ha vinto l’anello NBA 2021 che certo, sapeva di coronamento, ma solo perché le impazienti attenzioni di tifosi e stampa condannavano Giannis Antetokounmpo a vincere già da qualche anno: nessuno ha la sfera di cristallo, la competizione è forte e i Bucks restano una franchigia dalle risorse economiche limitate, ma quell’anello, a posteriori, potrebbe rivelarsi il primo di una serie, più o meno lunga. E gli strabilianti record che Giannis ha già fatto segnare potrebbero rivelarsi le prime bozze di un libro in continuo aggiornamento, che nessuno ha mai scritto prima d’ora.
E tuttavia, la storia di Giannis Antetokounmpo contiene altre storie. Contiene una moltitudine di altre storie, accadute, presenti o potenziali. I suoi 28 anni si aprono a ventaglio ad abbracciare tre continenti, innumerevoli culture – da quelle africane, antiche quanto l’umanità stessa, all’epica contemporanea dello sport americano –, viaggi per mare ma anche nel tempo, e uno stuolo di personaggi, eroi, trickster, mentori. È una storia giovane ma tutt’altro che acerba. Una storia che si può raccontare, che anzi si deve raccontare, per tutto ciò che nella vita di Giannis è accaduto quando il suo primo pallone da basket ancora non aveva rimbalzato a terra, e che continua ad accadere a migliaia di altri ragazzi come lui, lontano dai riflettori.
Come tutte le grandi storie, è una storia di conflitti e contrasti. Dell’imparare a conoscersi e a costruirsi scegliendo da che parte stare, nella luce o nell’ombra, e lottando per restarci – o per andare via. Giannis Antetokounmpo è nato nell’ombra, ci è cresciuto, perché alla luce non ci poteva uscire. Non poteva dire in giro dove abitasse la sua famiglia, in quale delle case che cambiavano regolarmente perché non potevano pagare l’affitto, per paura che qualcuno facesse la spia alle autorità e arrivasse la polizia a deportarli. Non poteva girare di notte per i vicoli bui di Sepolia, per paura che le ronde di skinhead di Alba Dorata gli facessero passare un brutto quarto d’ora. La parola d’ordine era non dare nell’occhio; non esattamente facile quando sei l’unico ragazzino nero – insieme ai tre fratelli – in una scuola di bianchi, hai un cognome che nessuno sa come pronunciare e figuriamoci scrivere, sei alto fin da piccolo una testa più degli altri. Il controsenso, che in realtà tanto paradossale non è e purtroppo nemmeno buffo, è come le stesse caratteristiche che puntavano un riflettore su Giannis quando lui voleva nascondersi si ribaltassero trasformandolo in un invisibile quando invece voleva essere visto. Bastava cambiare prospettiva. Il quartiere di Sepolia era una chiassosa e problematica macchia di colore nell’austera capitale, dove si parlavano tante lingue diverse, quasi tutte le quali chiedevano aiuto, ma Atene preferiva girarsi dall’altra parte, beandosi dei propri marmi bianchi. Non c’è da meravigliarsi che un partito come Alba Dorata sfondasse (anche letteralmente, cioè facendo irruzione nei seggi durante le elezioni, uno dei motivi per cui oggi Alba Dorata fortunatamente non esiste più se non nell’albo delle organizzazioni criminali) proprio in zone come Sepolia, fornendo semplicemente un orecchio dove altri si rifiutavano di ascoltare. È storia nota anche in tempi e in lidi ben più vicini ai nostri. Quando Giannis e il fratello Thanasis accompagnavano i genitori, oppure più grandicelli andavano da soli, per le strade più pittoresche della capitale a vendere souvenir o capi di moda contraffatti, i fiumi di turisti gli passavano attraverso come se fossero stati fantasmi. E ancora, soprattutto, quando i greco-africani di Sepolia e degli altri quartieri popolari, tutti nati e cresciuti in Grecia, parlando greco, studiando in scuole greche, si riunivano in associazioni per chiedere qualche diritto in più e magari la cittadinanza, le porte dei palazzi governativi restavano chiuse.
Giannis ha cominciato a giocare a basket non per passione, e nemmeno per inseguire un sogno. C’è pochissimo della retorica del sogno, nella sua storia. Lo ha fatto perché qualcuno ha avuto la pazienza di guardare nell’ombra e trovarvi la sua luce, convincendolo a provare la pallacanestro come compromesso per far guadagnare due soldi ai genitori, anche se lui preferiva il calcio, anche se aveva già quindici anni. E così il conflitto si spostò sul campo e nei suoi immediati dintorni. Doveva imparare a fidarsi dei compagni di squadra, a trattarli come amici e non come un gruppo di superiori a cui dare del lei – lo faceva veramente, agli inizi, anche con i pari età. Ma questo significava aprirsi, mostrarsi, schiudere uno spiraglio di luce nell’ombra. Accettare l’idea che, con prudenza, anche quel branco ristretto e protettivo che era la sua famiglia poteva allargarsi, stringere una mano tesa. E in campo, doveva capire dove stava la linea dell’orizzonte. Certe volte doveva uscire alla luce, palesarsi in tutta la sua altezza e lunghezza, cavalcare con il pallone in mano da un lato all’altro del campo e lanciarsi verso il canestro, anche se le gambe non erano ancora abbastanza forti per portarlo a schiacciare, anche se le mani non erano ancora abbastanza educate per un appoggio al tabellone. Certe altre doveva fare un passo indietro e tornare a nascondersi nelle zone d’ombra del campo, nelle pieghe della difesa. Gli capitava spesso, quando cominciava a diventare bravo, le squadre avversarie concentravano le attenzioni su di lui e Giannis andava in crisi, pungolato sui punti deboli della formazione cestistica ancora acerba. Doveva lasciare spazio ai compagni, fungere da esca magari, contribuire con corse, salti, tuffi, tutto ciò che è invisibile, intangibile – e, nel farlo, capire quanto anche ciò che è invisibile sia totalmente concreto.
Una lezione che gli è tornata utile anche quando poi, alla fine, bravo lo è diventato davvero. Bravo al punto che molti lo considerano il più forte giocatore del pianeta, e si spazientiscono se la sua squadra non vince l’anello. Senza quella lezione, forse, Giannis non avrebbe saputo battere in maniera così perentoria i Miami Heat al primo turno dei playoff 2021. Le grandi storie, dicevamo, sono spesso anche storie di riscatto, quando non di vendetta, e per Giannis Antetokounmpo i Miami Heat avevano segnato il punto più basso, quel baratro in cui ogni protagonista cade, a un certo punto del suo arco, ed è lì, nella risalita, che si pesa l’animo dell’eroe, la sua caratura. Nel 2020 c’erano cause concomitanti, è vero, presagi che da un lato hanno distratto Giannis e i Bucks dalla loro missione e dall’altro ne hanno ridimensionato il tracollo, poca cosa su scala globale e morale in confronto alla pandemia e alla rovente estate di Black Lives Matter. Fatto sta che, nella bolla di Orlando, i favoriti Bucks si erano arresi ai Miami Heat senza nemmeno l’onore delle armi, con Giannis imputato principale, reo di essersi infranto sul muro eretto dalla difesa di coach Spoelstra. Luci e ombre, di nuovo. Sotto l’occhio di bue dei riflettori, nel silenzio dei palazzetti a porte chiuse, Giannis si era incaponito rasentando la fatale hybris, l’arroganza che condanna gli eroi all’oblio: se c’è una montagna invalicabile a sbarrarmi il cammino, voglio che la luce degli dei splenda ancora più forte su di me, in modo che tutti mi vedano quando riuscirò a scalarla, di pura forza e di rabbia – quella rabbia covata negli anni di Sepolia, forse, che non aveva ancora trovato un suo sfogo, un suo significato, e rischiava di trasformarsi nella nube tossica che avvolge gli eroi caduti.

E invece, un anno dopo, Giannis è stato più saggio di così. Basta guardare la prima azione di gara 1, primo turno dei playoff a Est, per capirlo. Si mette in punta con il pallone in mano, gli altri quattro compagni aperti sul perimetro, il classico schema – se così vogliamo chiamarlo – dei Milwaukee Bucks Antetokounmpo-centrici, tutti, compagni e avversari, in attesa che lui inneschi l’azione. E invece Giannis passa la palla a Middleton e si allontana, si nasconde sul lato debole. Torna il ragazzo dei primi anni al Filathlitikos, quando coach Zivas lo mandava a giocare con la prima squadra e lui, smilzo e altissimo, per non finire nell’autoscontro dei robusti veterani della A2 greca, doveva muoversi tra le linee, tra le ombre, sbucando fuori felino per una zampata, un rimbalzo, una rubata, una galoppata in contropiede. Quel pallone ceduto a Middleton gli ritornerà in mano poco dopo per un’affondata a canestro – ma intanto gli occhi della difesa si erano spostati da un’altra parte, e Giannis aveva capito, aveva dimostrato, che non è necessario abbattere le mura a testate o scalarle con un balzo: si possono aggirarle o farle crollare dalla base, se si lavora insieme.
E siccome le grandi storie sono spesso anche storie costruite a incastro, a matriosca, un gioco di presagi e rimandi, pochi giorni dopo la vendetta sui Miami Heat Giannis rivive lo stesso ciclo vertiginoso, il crollo e l’ascesa, ma condensato in una settimana scarsa. Nelle finali di conference contro gli Hawks, una pratica che per i lanciatissimi Bucks sembra ordinaria amministrazione, il ginocchio sinistro si piega in modo innaturale, si teme per un infortunio grave e la stagione sembra finita. Mentre si attende il responso dell’oracolo medico, Giannis deve imparare un’altra lezione: scomparire dalla scena, lasciare il resto del lavoro ai compagni, avere fiducia incondizionata in loro. Subito dopo, quando si scopre che il ginocchio d’acciaio, in qualche misterioso modo, ha retto all’urto, ne deve imparare un’altra più urgente: scoprire i limiti del corpo infortunato, adattarvisi, conservarsi, spingersi fino a un soffio dalla rottura, trovare l’equilibrio aureo fra coraggio e temerarietà, il tutto mentre dall’altra parte dello schieramento ci sono cinque guerrieri in maglia Phoenix Suns. La risposta, ancora una volta, è nel muoversi tra luci e ombre. Lo Giannis Antetokounmpo delle Finals 2021 è chiaramente un giocatore in difficoltà fisica, eppure è forse lo Giannis migliore di sempre, reso lucido e preciso proprio dal costante pungolo del dolore, come un eroe assediato che lotta sull’orlo di un precipizio.
Ed ecco il raggiungimento della saggezza. Stavolta Giannis impartisce una lezione anziché impararla. Mostra come mescolare luce e ombra fino a dipingere il quadro perfetto, un chiaroscuro naturale, la rabbia e la paura indirizzate verso il traguardo senza sprecare nemmeno una goccia di sudore o una briciola d’odio. Quando torna nei ranghi dei Bucks dopo l’infortunio, non cala dal cielo su ali d’angelo come un deus ex machina. Torna come testa d’ariete di una macchina d’assalto che è stata capace di vincere anche senza di lui. Capisce quando dosarsi e lasciare spazio ai compagni, un po’ d’istinto e un po’ con la guida di coach Budenholzer, e il gioco dei Bucks diventa più variegato, imprevedibile, corale. Capisce quando prendersi il palcoscenico, e i 50 punti di gara 6 sigillano il secondo trionfo dei Bucks in NBA 50 anni dopo Kareem e Oscar Robertson.

Anche l’immagine pubblica di Giannis Antetokounmpo rispecchia questa dualità tra luce e ombra, tra nascondersi e mostrarsi. A inizio carriera non parlava volentieri della propria adolescenza greca, non si esponeva su tematiche politiche o sociali, nonostante possedesse una vasta esperienza diretta in materia di razzismo, discriminazione, integrazione. Lasciava che fosse Thanasis, il fratello maggiore suo portatore di lancia e scudo, a esporsi: lui si concentrava sul gioco e sul business, per paura che magari, a causa di una parola di troppo, gli strappassero dalle mani quel contratto che significava una vita diversa per la sua intera famiglia. Nascondeva una parte di sé in un angolo buio, ma non la cancellava, non la dimenticava. Oggi ne parla a viso aperto scegliendosi i set più luminosi. Le copertine delle riviste, documentari e film dedicati, i cortei di Black Lives Matter, eventi pubblici in Grecia e a Milwaukee. Giannis Antetokounmpo è diventato l’ambasciatore della NBA nel mondo, una figura che calza a pennello con le politiche globali e progressiste di Adam Silver, ma non è diventato – non diventerà mai – un prestanome di cause altrui, un mero megafono. Quando parla, che sia a gesti o a parole, lo fa sempre con la propria voce, perché dentro la propria voce c’è quella di tre mondi tra i quali Giannis ha steso un ponte: la città di Milwaukee, che rischiava di fallire senza il nuovo Bradley Center costruito sulla fiducia che Giannis sarebbe diventato una star; Sepolia, i sobborghi di Atene e di qualsiasi altra città dove le minoranze lottano per emergere, per avere cittadinanza e diritti; e l’Africa, quel corteo di antenati e divinità che in passato percorsero la rotta della tratta atlantica, dividendo la stiva delle navi con gli schiavi esportati in America, e che Giannis porta con sé ogni volta che s’imbarca su un aereo.

La storia di Giannis Antetokounmpo è protetta da fraintendimenti e strumentalizzazioni. Parla di sogni, ma non di American Dream. La parte più importante del sogno, ha detto Giannis alla Casa Bianca in visita al presidente Biden, arriva al mattino quando ci si sveglia. Non è vero che tutto è possibile, non bisogna ascoltare le promesse del pensiero magico, false come sirene. Il successo di Giannis insegna invece che i capricciosi venti del fato possono essere cavalcati, mai ammaestrati, e men che meno ignorati. Bisogna essere umili e grati per i favori ricevuti, senza cercare spiegazioni, ma anche orgogliosi del proprio valore e della propria onestà al punto da difenderli con la forza, se necessario. È quello che in greco si chiama philotimo, e che Giannis mostrò nei suoi primi playoff, nel 2015. I Bucks stavano per essere eliminati dagli spigolosi Bulls, la frustrazione cresceva, e Giannis si guadagnò l’espulsione andando a lanciare contro la prima fila Mike Dunleavy, che nel primo tempo della partita, non visto, aveva rifilato un pugno al Buck Michael Carter-Williams. Nella religione igbo, quella della mamma di Giannis, Veronica, esiste un forte concetto di giustizia retributiva: gli dei conoscono il cuore degli uomini e puniscono ogni menzogna. Nessuno però stava punendo Mike Dunleavy, quel giorno, così Giannis uscì alla luce e si prese l’incarico sulle proprie spalle, perché aveva un onore da difendere, un branco da proteggere – non l’avrebbe mai fatto ai primi anni del Filathlitikos, quando dava del lei ai compagni di squadra, e credeva che non avrebbe mai avuto altra famiglia di quella composta da padre, madre, e fratelli.
Un eroe ha molte voci, molti volti – e molte maschere. A volte nessuna, è un semplice corpo: il famoso corpo, tra i tanti appellativi di Ulisse che si abbina perfettamente anche a Giannis, per la sua dimensione meccanica di atleta, i muscoli costruiti e modellati scientificamente intorno al telaio da airone. Ma avere molte maschere non significa mancare di identità, o peggio nascondersi: significa incarnare, attraverso la propria storia, varie sfaccettature e aspetti archetipici dell’essenza umana, ciò che ci distingue e al tempo stesso ci accomuna. È ciò che fanno gli eroi. Se proviamo a indagare il volto di Giannis Antetokounmpo sotto queste maschere, è vero, può essere difficile coglierne lo spirito profondo, quello che appartiene a lui soltanto. C’è la maschera del ragazzino scanzonato che, appena arrivato in America, guardava con occhi sgranati quel mondo zuccheroso e luccicante, e imparava l’inglese cantando a squarciagola le canzoni rap. C’è la mean mug, la faccia cattiva ispirata alle esultanze di Russell Westbrook che Giannis provava davanti allo specchio prima di ripeterla in allenamento, in partita, e infine di farla sua. C’è quel misto tra ammirazione e animosità che riserva alle stelle avversarie, che ricorda più l’aspra NBA anni Novanta o Duemila che quella attuale tutta meme e smancerie, ma che è semplicemente il dovuto e bellicoso rispetto fra guerrieri di pari caratura. C’è l’istrione che racconta barzellette, e c’è il cuore inquieto che talvolta, come nei recenti europei con la Grecia, sfoga rabbia e frustrazione contravvenendo al codice sportivo.

Le preferenze individuali degli eroi, è risaputo, contano fino a un certo punto. Compiti, missioni e destino vengono prima di tutto il resto. Ma guardando tra le pieghe, tra luce e ombra, c’è forse una zona che Giannis Antetokounmpo preferisce, quella in cui si sente più comodo. Quando gli è stato chiesto, recentemente, a chi vorrebbe ispirarsi per la sua carriera dopo la pallacanestro, ha risposto senza indugi: Tim Duncan. Perché? “Perché chi lo sa dov’è finito, Tim Duncan? Chi lo sa cosa sta facendo?”
Tornare nell’ombra una volta concluso il proprio arco, dunque, lasciando che le gesta passate continuino a raccontare la storia, come una statua – e come Ulisse, re senza corona, eroe senza patria, la cui unica patria era il viaggio. Pensandola da questo punto di vista, forse anche l’unica nota apparentemente stonata nella parabola dell’eroe Giannis Antetokounmpo acquista una sua armonia, anche se agrodolce. Quando a diciotto anni Giannis ricevette il passaporto greco insieme al fratello Thanasis, il documento che gli permetteva di andare a giocare a basket in America, fu una corsa contro il tempo per tutte le parti coinvolte. Il draft non poteva certo aspettare le traversie burocratiche di un apolide, e la famiglia Antetokounmpo, oltre ad aver messo in moto il leviatano dell’amministrazione greca, si era rivolto alla Nigeria e addirittura alla Spagna per avere delle carte valide in tempo utile. È probabile che il governo greco si sia infine deciso, spinto dalla federazione cestistica, proprio per non vedersi scippare il talento di Giannis da altre nazioni. Ma la motivazione del rilascio era chiara. Eccezionali meriti sportivi. Un’eccezione dunque, non un modello, come dovrebbe essere un eroe. Perché mentre Giannis e Thanasis volavano in America battendo bandiera greca, deglutivano bocconi amari all’idea di rappresentare la nazione che amavano e di cui si sentivano parte mentre, nel frattempo, mille altre persone come loro, i loro stessi genitori e fratelli, restavano privi di cittadinanza. Privi di identità, agli occhi di uno stato che non sa nemmeno come trascrivere il tuo cognome su una carta. Quasi dieci anni dopo, la situazione non è migliorata, a sentire le comunità greco-africane e le associazioni che le rappresentano – ma possiamo facilmente tracciare un altro arco sopra il Mediterraneo e guardare le periferie di un’Italia ancora priva di una legge sullo ius soli ma colma di tanti Giannis Antetokounmpo che, verosimilmente, non godranno mai del lusso di poter scegliere tra luce e ombra.
Tuttavia, come scriveva l’autore nigeriano Chinua Achebe, “non esiste storia che non sia vera”: c’è ancora tempo per scegliersi i propri modelli, persino tra le eccezioni, e trasformare anche questa storia in realtà.
Questo articolo contiene degli estratti tratti dal nuovo libro “Giannis Antetokounmpo, Odissea” di Andrea Cassini. Potete ordinarlo online: su https://amz.run/6CJd, Mondadori, Ibs e Feltrinelli.