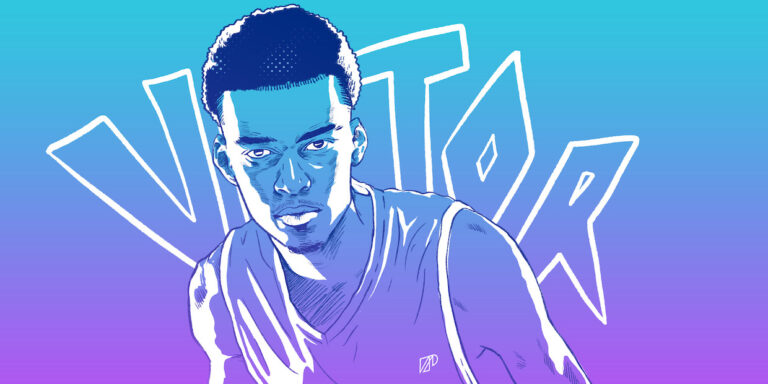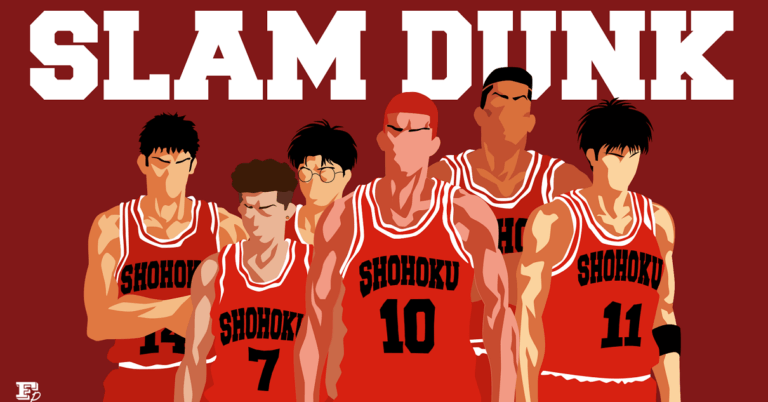È il 29 dicembre dello scorso anno. Il Tokyo Metropolitan Gymnasium è più adatto a un concerto che a una partita di basket ma quasi tutti i diecimila posti a sedere sono occupati. I giapponesi hanno la fama di spettatori ossequiosi, che rispettano lo sforzo degli atleti e vi si immedesimano, ma il loro silenzio a volte è più assordante del chiasso che facciamo noi occidentali. Specialmente quando si frammenta in un’esultanza incontrollata. Rui Hachimura sa come far schizzare sui seggiolini i suoi compagni d’istituto. Ha appena trascinato la sua scuola superiore, la Meisei High, al terzo titolo nazionale consecutivo. È uno scherzo della natura, un africano con gli occhi a mandorla; la mamma è giapponese e il padre viene dal Benin. Gioca ala, tratta bene la palla, ma con oltre due metri d’altezza e due spalle robuste salta in testa ai centri avversari. In finale ha segnato 34 punti e catturato 19 rimbalzi. Al suono della sirena dal tetto del Gymnasium iniziano a piovere festoni dorati, Hachimura e i compagni si abbracciano al centro del campo. Se fossimo lì, nella sua testa, e alzassimo gli occhi sugli spalti vedremmo gli studenti che fanno festa. Battono con le bottiglie vuote sulle transenne per fare rumore, sventolano bandiere e issano striscioni.

Se questa scena vi suscita una sensazione familiare, non preoccupatevi; forse siete cresciuti anche voi con le pagine inchiostrate di Slam Dunk sotto al naso, e adesso state ripensando al pel di carota Hanamichi Sakuragi che sconfigge lo strafavorito Sannoh Kogyo con la sua squadra di raccattati, mentre gli amici impazziscono dalla gioia. Insieme alla dolce Haruko, friendzonatrice seriale, a fare il tifo per lo Shohoku ci sono i teppisti più temuti della prefettura di Kanagawa; hanno riempito le bottiglie coi gettoni del pachinko, per fare più casino, e con le lacrime agli occhi brandiscono il vessillo dedicato a Hisashi “Anima Ardente” Mitsui. Il maestro Inoue non esagerava con l’entusiasmo: quei ragazzi, in quel momento, sono davvero degli eroi, ma non cercate oltre; tutto si esaurisce in questo fermo immagine. Il basket in Giappone non diventa più popolare di così, e Rui Hachimura lo sa bene. Tra mille difficoltà accademiche e di comunicazione si è trasferito in America dove ha già esordito con la prestigiosa maglia dei Gonzaga Bulldogs.
Questa è la storia di come Slam Dunk ha cambiato il basket giapponese. Se pensate che sia una grande storia di sport, forse rimarrete delusi. È una storia piccola. Ma la cultura che ha prodotto gli haiku e i bonsai ci insegna che la bellezza delle cose ama nascondersi nei dettagli.

Slam Dunk arriva dalla penna di Takehiko Inoue sulle pagine della rivista Shonen Jump nel 1990. Finisce sei anni dopo, ma non ha ancora smesso di vendere copie. Il contatore ha fatto il giro del mondo e ha raggiunto cifre milionarie, superato solo da quel mostro di popolarità che è One Piece. Indagando il gradimento dei lettori giapponesi la classifica non cambia; primo One Piece, secondo Slam Dunk, Dragon Ball a rincorrere, ma secondo un sondaggio del 2012 la battuta più famosa dei manga è proprio un insegnamento del serafico coach Anzai, quello che a Sakuragi ricordava il vecchietto del Kentucky Fried Chicken “Se ti arrendi, la partita è già finita”, a fare il paio con l’intramontabile “chi controlla i rimbalzi controlla la partita”, concetto che il capitano Akagi inculca nell’inesperto Hanamichi a suon di cazzotti sul cranio.
Quindi, esiste una Slam Dunk Generation in Giappone? Sì e no. Esiste in misura diversa da una Captain Tsubasa Generation – Holly e Benji per noi italofoni. Il primato di popolarità del baseball è inarrivabile, è il primo prodotto d’esportazione americano ad aver attecchito nel paese del sol levante, ma il calcio lo insidia da vicino grazie a ragazzini cresciuti sognando le sfide tra New Team e Muppet. I risultati si vedono. La nazionale giapponese compete con le migliori del mondo e c’è una nidiata di giocatori di qualità che si sparpagliano in mezza Europa da una ventina d’anni, dal nostalgico Hidetoshi Nakata ai contemporanei Keisuke Honda e Shinji Kagawa. La maggior parte di loro sono mezze punte, fantasisti, amanti della bella giocata, segno che i cuori di quei ragazzini erano tutti devoti alla classe di Oliver Hutton – per buona pace di quelli, come me, che facevano il tifo per Mark Lenders.

I mondiali di calcio organizzati in Giappone nel 2002 furono un successo clamoroso. Allora perché quelli di basket, quattro anni dopo, passarono inosservati? Ancora oggi il panorama è desolante agli occhi di noi appassionati occidentali. Se chiedi a un giapponese medio quale giocatore di basket conosca, la risposta è una sola: Michael Jordan. Hanno familiarizzato con la pallacanestro all’epoca della sua esplosione globale, quella di be like Mike, poi da lì non si sono più mossi. “E i talenti locali?” chiedo io. La faccenda si fa ancora più grigia. Salta fuori il nome di Kei Igarashi, ma non per le sue doti sul campo. “Perché è bello”, mi dicono. Almeno con Yuta Tabuse mi tolgo una soddisfazione. Sanno chi è, l’hanno visto in tv, non per niente è stato il primo giapponese a giocare in NBA, anche se solo per quattro partite coi Phoenix Suns, per poi accasarsi in D-League. Volete sapere come lo chiamano? “Il Michael Jordan giapponese”, avete indovinato. Gli altri che hanno tentato il successo oltreoceano sono degli emeriti sconosciuti, eppure meriterebbero un minimo di considerazione. Se non altro ricordano il sogno di Kaede Rukawa e il suo epico duello col prodigio Sawakita, durante il quale trovavano persino il tempo per confrontarsi sul dubbio che angustiava entrambi: dominare la scena locale o emigrare il prima possibile per trovare avversari alla loro altezza? Tra quelli che ci hanno provato, fuori dalle pagine dei fumetti, c’è lo Yuki Togashi che per un mese giocò a Sassari, o Yuta Watanabe, il miglior prospetto internazionale insieme a Hachimura, che furoreggia in NCAA a George Washington.
Le scarpe da basket, però, al nostro giapponese medio piacciono parecchio. Le Jordan, manco a dirlo. A Harajuku, un distretto di Tokyo, c’è una strada dedicata solo a quelle e non può non venirci in mente il negoziante logorroico che vende – anzi regala – a Sakuragi un pezzo pregiato per poi vedersele riportare rotte il giorno dopo.
Lo stesso Inoue era un collezionista di sneakers e a Tokyo l’estetica hip hop ha sempre trovato terreno fertile. Da’ loro un qualsiasi look appariscente e farai felici gli educatissimi alternativi giapponesi.
Gli sportivi più appassionati ricordano ancora una visita di His Airness in persona. Correva l’anno 2004 e Jordan tagliava il nastro di un playground a lui intitolato a Shibuya. A raccontarla sembra una cosa in grande stile, invece è un rettangolo più piccolo del normale, spesso deserto, con tabelloni scadenti e il logo che fagocita il campo. E pensare che pochi passi più in là un fiume di giovani si dà appuntamento ogni giorno sotto la statua di Hachiko; nascosto tra i palazzi in costruzione, nessuno sa dell’esistenza del Jordan Court.

I playground in Giappone soffrono di problemi logistici, pare che ce ne siano una trentina in tutto l’arcipelago. Intanto c’è la stagione delle piogge, per cui per qualche mese l’anno si sta a casa. Poi manca la cultura del pick up game, ognuno tirerebbe con la propria palla per mezz’ora prima che il più audace si decida a fare le squadre. Preferiscono giocare al chiuso, pagando le palestre a ore, organizzando in anticipo partite e tornei. Dato che amano essere precisi si affidano a un sito internet, rokyu.net, con un motore di ricerca che gestisce tutto quanto. Comodo, ma un po’ meno emozionante che entrare in scena da soli con la palla sotto braccio e una bottiglia d’acqua in mano. I playground di solito li cercano i gaijin, gli stranieri costretti in Giappone per lavoro, e restano irrimediabilmente delusi. Vai a Okabe Park, consigliano i locali, ma informati per tempo perché metà delle volte ospita una gara di mangiatori di ostriche. Oppure ti indirizzano a Komazawa, e tu non lo trovi. Facile, ti spiegano poi. C’è un tabellone solo, giallo. Attaccato a un muro. Sotto un cavalcavia.

Yoyogi è il più famoso, in mezzo a un verdissimo parco per famiglie, infatti è spesso occupato da tornei o partite promozionali. Se sei fortunato, però, trovi un bel mix di americani in trasferta, giocatori liceali e modaioli assortiti, con squadre che attendono il loro turno neanche fossimo a New York, e i bambini ancora più pazienti che entrano quando i grandi hanno finito. Intanto chi aspetta si diverte a osservare la fauna locale; freestyler, skater, concerti rock ai bordi dei viali e bizzarrie assortite.
![Su UnitedBallers [http://unitedballers.fr/], un progetto francese, trovate bellissimi reportage sui playground di tutto il mondo. Merita di farci un giro. Hanno visitato anche Tokyo, e questo è un tranquillo pomeriggio a Yoyogi Park](https://lagiornatatipo.it/wp-content/uploads/2016/11/jkPttyg.jpg)
Solo ai più giovani è concesso del tempo da dedicare al gioco, fine a se stesso. Poco, però, qualche ora. Quelle di educazione fisica e dei club sportivi che ogni scuola possiede, fedele al modello americano. Quando glielo chiedo, il mio giapponese medio spalanca gli occhi. Sì, nelle scuole il basket è gettonatissimo, alla pari del calcio; anzi, i maschi del club di basket sono i più affascinanti agli occhi delle ragazzine. Sembra che la scuola sia un mondo a sé stante, una riproduzione in miniatura del mondo reale che tuttavia si affanna per sfuggirgli. Ed ecco che il cerchio si chiude.
È di nuovo il 29 dicembre, siamo di nuovo al Tokyo Metropolitan Gymnasium. Per Rui Hachimura, i suoi compagni della Heisei High e tutti gli studenti che danno di matto sugli spalti il basket è un gioco, quindi è una cosa serissima. Quando cresceranno, quasi tutti loro dovranno dedicare il loro tempo a faccende più noiose, meno importanti, ma per ora sono loro la generazione Slam Dunk. Hanno letto dei dolori del giovane Hanamichi e di come la pallacanestro l’ha fatto diventare uomo, si sono commossi per la redenzione del bullo Mitsui, hanno desiderato un fratello maggiore come il gorilla Akagi, hanno odiato l’arrivista Rukawa ma l’hanno ammirato per la sua forza.
Nonostante il successo di Slam Dunk, abbiamo detto, il basket in Giappone non è esploso. La verità è che prima del 1990 non conoscevano nemmeno le regole della pallacanestro. Era uno sport minore tra gli sport minori, in una nazione che non impazzisce per l’attività fisica. Slam Dunk lo ha messo sulla mappa, lo ha sollevato dal grado zero.

La storia che abbiamo raccontato è piccola, non vi ho mentito. Ma potrà diventare più grande, un giorno? A qualcuno piacerebbe, e ci stanno provando – le donne più degli uomini, che già a Rio hanno affrontato a viso aperto gli Stati Uniti. Il coach della nazionale, Ken Hasegawa, ha le idee chiare: qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 tra le migliori tre del continente, poi sorprendere tutti con un dream team, di cui proprio Hachimura e Watanabe sarebbero i gioielli. Intanto la scena professionistica ha sterzato nella direzione giusta fondendo due leghe in un campionato unico. NBL e BJ League (sì, hanno davvero avuto il coraggio di chiamarla BJ League) sono confluite nella B-League che, si spera, diventerà qualcosa di più di un’americanata per gaijin in cerca di soldi facili. Già che c’erano, hanno messo su un campo a led: sono piuttosto bravi in queste cose.
In caso contrario, la pallacanestro rimarrà una cosa piccola, preziosa, un frammento di anni ’90 come Jordan e le sue scarpe. Condannata a un limbo di anonimia, diremmo noi, ma in Giappone riempiono d’oro le spaccature dei vasi perché le imperfezioni partecipano alla bellezza del tutto. Il Jordan Court è troppo stretto per la linea da 3? Okubo Park è chiuso per il festival del ramen? A Yoyogi trovi solo turisti in jeans e canotta di Iverson? Non è un dramma: sono tre strofe di un bellissimo haiku.
Rui Hachimura, intanto, se la ride con la faccia di chi ha intenzione di far parlare di sé l’America intera; chissà che non invogli i giapponesi a portare il basket a un livello superiore. Gli verrà più facile se ricorderà la lezione di Slam Dunk: se ti arrendi, hai già perso la partita.