“Aveva il potenziale per essere qualunque cosa: un gigante, il testimonial di punta di Dolce e Gabbana, il primo dittatore degli Stati Uniti o addirittura il primo essere umano a piegare la struttura stessa del tempo e a condurre la terra in un nuovo Rinascimento: ma tra tutti i doni tra cui poteva scegliere, lui decise di conferirne uno solo al suo popolo – il basket.”
Questa è, più o meno,è l’introduzione che fornisce il sito internet a lui dedicato; capelli talmente rossi da essere nominato membro della famiglia Weasley ad honorem, fisico da sollevatore di polemiche, elevazione non pervenuta, una tale padronanza della tecnica dello sventolamento di asciugamani da far impallidire persino Robert Sacre: parliamo ovviamente di the man, the myth, the legend, ossia di Brian Scalabrine.
Inevitabilmente, qualcuno di voi non lo conoscerà: ebbene, parliamo di un’ala grande scelta al turno numero 34 del secondo giro del draft del 2001, che ha giocato per 11 anni in NBA e ha totalizzato in media 3 punti, 2 rimbalzi e 1 assist in carriera.
Immagino sarete confusi: come può un semplice panchinaro essere descritto allo stesso tempo con toni epici e parodici? Quello che cercheremo di scoprire attraverso quest’articolo è proprio la risposta a questa domanda, analizzando la fenomenologia – ammazza come parlo bene – del personaggio di Scalabrine. Certo, essendo io l’autore dell’articolo potrei svelarvi già adesso la risposta, se mi inviate un bonifico. No? Ok, ve la siete voluta voi, procediamo.
Brian, il giocatore
Nato a Long Beach in California, in una famiglia di sei persone, Scalabrine ebbe una carriera NCAA migliore di quella che potreste immaginare: nella sua prima esperienza, iniziata nel 1996, all’Highline College di Des Moines, giocando per i Thunderbirds (dite la verità, lo credevate più uno da InternetExpolers – ok, attendo le querele) aveva totalizzato circa 13 punti, 9 rimbalzi e 2 assist di media, mettendo a referto diciassette doppie-doppie, mentre la squadra portava a casa un record di 31-1 vincendo il campionato statale.
Nel 1998 si era trasferito alla University of Southern California dove, forse in un presagio del suo futuro da eroe mitologico, giocò per i Trojans. Anche qui mise su numeri di tutto rispetto, con 14 punti e 6 rimbalzi di media, e nel suo anno da senior la squadra arrivò anche al torneo NCAA, dove furono eliminati alle Elite Eight dalla più quotata Duke, che vantava elementi del calibro di Jason Williams, Carlos Boozer, Mike Dunleavy Jr. e Chris Duhon.
 Fu scelto alla 34esima scelta del secondo giro dai fortissimi Nets, che avevano a roster Jason Kidd, Keith Van Horn, Kenyon Martin e Richard Jefferson, orchestrati da coach Byron Scott,che quell’anno arrivarono alle Finals. Brian rischiò di vincere l’anello nella stagione da rookie, ma O’Neal e Bryant non erano della stessa idea e i Nets vennero spazzati via 4 a 0.
Fu scelto alla 34esima scelta del secondo giro dai fortissimi Nets, che avevano a roster Jason Kidd, Keith Van Horn, Kenyon Martin e Richard Jefferson, orchestrati da coach Byron Scott,che quell’anno arrivarono alle Finals. Brian rischiò di vincere l’anello nella stagione da rookie, ma O’Neal e Bryant non erano della stessa idea e i Nets vennero spazzati via 4 a 0.
Sarebbe giunto, forse, il momento della vendetta per Brian, ma era effettivamente troppo presto per cercare la gloria: aveva ancora molto da imparare, e se c’è un posto dove si impara bene è proprio la cara vecchia panchina, la sua più fedele compagna durante il decennio trascorso in NBA.
 Nelle due stagioni successive i Nets furono eliminati sempre dalla squadra campione, dagli Spurs alle Finals del 2003 e dai Pistons alle semifinali di conference del 2004.
Nelle due stagioni successive i Nets furono eliminati sempre dalla squadra campione, dagli Spurs alle Finals del 2003 e dai Pistons alle semifinali di conference del 2004.
Proprio nella serie contro i Pistons, in gara 5 al Palace, mise in scena una grandissima prestazione mettendo a segno 17 punti, insaccando 4 triple su 4 di cui una fondamentale durante il terzo overtime.
All’epoca la sua leggenda era ancora in fase embrionale, ma aveva già iniziato ad attirare le attenzioni dei tifosi guadagnandosi il soprannome di “Veal”, che giocava sull’assonanza tra il nome del piatto “Veal Scaloppini” (scaloppine di vitello) e il nome del giocatore, ma anche un chiaro riferimento alla sua bucolica conformazione fisica. A questo punto però i tifosi iniziarono a notare quel bianco peldicarota che sembrava il cugino irlandese del vicino di casa, e nella stagione seguente, in cui iniziò a giocare ventuno minuti a partita, divenne l’idolo dei tifosi di casa.
Nelle quattro stagioni passate ai Nets, le statistiche e l’apporto in campo di Brian furono ascendenti: quando giunse la free agency del 2005 sembrava pronto per il salto di qualità, magari per un posto stabile da sesto uomo, ma in realtà, dal punto di vista puramente sportivo, i suoi anni migliori erano già trascorsi. Nonostante ciò, quello che lo aspettava era (forse) ancora meglio.
Scalabrine, l’antieroe
Nonostante venisse da quella che fu la miglior stagione della sua carriera, l’arrivo di Scalabrine in quel di Boston non fu affatto apprezzato dai tifosi. Fu firmato utilizzando la Mid-Level Exception, che all’epoca era di soli 3 milioni, per 5 anni: e nessuno credeva fosse una saggia mossa dare 15 milioni ad un comprimario privo di atletismo, sopratutto quando la squadra era in ricostruzione e a corto di spazio salariale.
I suoi detrattori all’inzio videro anche confermati i propri dubbi, visto che al primo di anno di Scalabrine al Boston Garden la squadra non fece i playoff e il successivo perse più di cinquanta partite. Certo, la colpe non erano di Scalabrine e dei suoi 10 minuti a partita, ma di certo qualcuno rimpiangeva che non fosse stato firmato un giocatore con un talento più tradizionale del suo.
Quando arrivò Kevin Garnett, quando nacquero i Big Three, quando Boston iniziò a vincere tanto e con facilità, in quel momento tutto cambiò: di colpo Scalabrine non aveva più bisogno di essere uno scorer per dimostrare di meritarsi il contratto. I tifosi non guardarono più ai punti che mancavano per vincere, non alle statistiche del boxscore, ma a quello che faceva in campo quel tale che rassomigliava al barista del pub all’angolo, anche se con trenta centimetri in più di altezza. E quello che faceva in campo non era nulla di speciale, si trattava semplicemente di tutti quei fattori che i bravi giocatori di sistema mettono in campo – i cosiddetti intangibles – e che, per quanto siano sempre di grande importanza per una squadra, devono essere accompagnati da un talento che Scalabrine non aveva. I tifosi però iniziarono a riconoscersi in quell’uomo comune che giocava in una lega di marziani e al contempo i compagni iniziarono ad apprezzare moltissimo la sua compagnia nello spogliatoio, al punto che Garnett lo ha definito “il miglior compagno di squadra che avesse mai avuto”.
Sarebbe oltremodo esagerato dire che divenne un elemento fondamentale della squadra, perché scendeva comunque in campo dieci minuti a partita e il suo contributo era sicuramente limitato e ma di sicuro divenne un’icona all’interno dello spogliatoio e uno dei fan favourite, il tutto senza aver compiuto alcun atto straordinario o inconsueto.
La stagione fu a dir poco trionfale per i Celtics, con ben 66 vittorie in regular season, e la squadra arrivò fino alle Finals dopo aver eliminato, nell’ordine, gli Hawks di Joe Johnson, Josh Smith e Al Horford, i Cavaliers di Lebron e gli ultimi Pistons a chiudere una stagione col record positivo.
Ad attenderli sull’ultimo palcoscenico c’erano i rivali di sempre, i Los Angeles Lakers, quelli che avevano tolto a Scalabrine la possibilità di vincere il titolo al suo primo anno: in una delle mie serie di finale preferite – chissà, magari un giorno la racconterò meglio – i Celtics sconfissero i rivali e divennero campioni NBA dopo tempo immemorabile.
Ah già, Scalabrine non giocò nemmeno un minuto di playoff.
 Oh, e appena dopo la vittoria in conferenza stampa rinfacciò a tutti i giornalisti la scarsa considerazione che la stampa dava ai Celtics riguardo ad una possibile vittoria finale e, quando gli fu chiesto degli zero minuti giocati in postseason rispose:
Oh, e appena dopo la vittoria in conferenza stampa rinfacciò a tutti i giornalisti la scarsa considerazione che la stampa dava ai Celtics riguardo ad una possibile vittoria finale e, quando gli fu chiesto degli zero minuti giocati in postseason rispose:
“Tra dieci anni sarò ancora un campione NBA, tra vent’anni dirò ai bambini che probabilmente sono partito titolare, tra trent’anni dirò loro che ho vinto l’MVP.”
E probabilmente fu in questo momento che avvenne la trasfigurazione.
The White Mamba, la leggenda
Dopo una conferenza stampa del genere avrebbe potuto essere preso per un pallone gonfiato ed un’arrogante, invece divenne un vero e proprio cult.
Probabilmente fu il suo carattere il fattore decisivo: se durante le interviste era sempre sorridente e dalla battuta facile, pronto a scherzare anche su sé stesso, durante le partite aveva il volto contratto in una maschera di concentrazione, roba da far sembrare Lillard uno sbadatone.
Durante le successive stagioni trascorse a Boston, ogni volta che segnava, prendeva un rimbalzo, toccava palla o semplicemente entrava in campo i tifosi andavano in visibilio: ma fu probabilmente a Chicago che la Scal-a-mania raggiunse l’apice assoluto.
Infatti, dopo le Finals 2010 perse contro i Lakers, il contratto di Scalabrine era terminato. Qualche mese dopo che Lebron ebbe portato i propri talenti in Florida, venne ingaggiato dai Chicago Bulls di Tom Thibodeau, che lo aveva allenato in qualità di assistant coach a Boston.
Non fu un caso che avesse deciso di portarselo dietro: con tutto quel tempo trascorso in panchina, Scalabrine aveva acquisito una grande conoscenza del gioco in generale e del sistema difensivo di Thibodeau in particolare, e avrebbe avuto il compito di aiutare i giocatori più giovani come Derrick Rose e Joakim Noah ad inserirsi meglio nelle tattiche di Thibs.
In questo periodo, proprio quello in cui le sue statistiche furono le peggiori, nacque il soprannome “White Mamba”, frutto della propraganda dei commentatori di casa di Chicago, Stacey King e Neil Funk: quando gli chi chiesero dell’origine del soprannome, lui rispose: “ Beh, Kobe Bryant è il Black Mamba, il serpente più letale del mondo. E io ho pensato, chi potrebbe essere il serpente più innocuo del mondo? Devo essere io, sono il White Mamba.”
I fan della Windy City lo accolsero in maniera calorosa, e lui ricambiò: foto, autografi, battute, non mancava mai di dedicare tempo ai tifosi. Dopotutto, per chi da giovane ha iniziato a giocare a basket per fare compagnia agli amici ed è stato tagliato dalla squadra del liceo – non come Jordan, perché la squadra aveva bisogno di lunghi, ma per mancanza di talento – di certo è gratificante avere tutta questa attenzione da parte della tifoseria.
Durante il lockout dell’anno successivo ebbe anche un’esperienza in Italia, alla Benetton Treviso. Il suo arrivo nel Bel Paese da dove provengono i suoi avi (non ditelo a quelli dei Celtics, che lo credono irlandese!) fu accolto da qualche perplessità, vista la contemporanea cessione in prestito di Motiejunas: però mise in mostra buone prestazioni (9 + 4 + 2 di media) e si trovò molto bene con l’ambiente e i tifosi. Quando gli domandarono come si sentisse a giocare 30 minuti, rispose con un sorriso “Se ci fate caso io gioco come sempre, trascorro semplicemente più tempo in campo.”
Al termine del lockout firmò di nuovo per i Bulls, dopo aver restituito a Treviso tutti i soldi che la società gli aveva pagato, e concluse la sua carriera a Chicago.
 Dopo essere stato assistant coach per Mark Jackson ai Warriors, aver giocato assieme al Reverendo con un gruppo di detenuti, essere approdato su Twitter e aver litigato per errore con la persona sbagliata, ha infine deciso di fare l’analista per Comcast Sportsnet, commentando le partite di Boston, ed ha annunciato il suo ritorno così. Vi dice nulla?
Dopo essere stato assistant coach per Mark Jackson ai Warriors, aver giocato assieme al Reverendo con un gruppo di detenuti, essere approdato su Twitter e aver litigato per errore con la persona sbagliata, ha infine deciso di fare l’analista per Comcast Sportsnet, commentando le partite di Boston, ed ha annunciato il suo ritorno così. Vi dice nulla?
 Ricordate il II libro dell’Iliade? No? Non guardatevi in giro, non cercate il suggerimento del vicino. Sì, siete ancora sulla Giornata Tipo, non siete stati catapultati in un momento particolarmente infelice del vostro passato scolastico. Va bene, state tranquilli, ci penso io.
Ricordate il II libro dell’Iliade? No? Non guardatevi in giro, non cercate il suggerimento del vicino. Sì, siete ancora sulla Giornata Tipo, non siete stati catapultati in un momento particolarmente infelice del vostro passato scolastico. Va bene, state tranquilli, ci penso io.
In quel passo dell’opera di Omero compariva il primo antieroe della storia: Tersite, un soldato brutto come un crossover di Lou Admunson e con le medesime proprietà di linguaggio di Chewbacca, che osò sfidare l’eroico Odisseo e incitò i compagni ad abbandonare l’assedio di Troia. In tutta risposta l’eroe di Itaca, in nome della retorica, gli stampò solennemente lo scettro sulla tempia, facendolo battere piangente in ritirata e sancendo l’ennesima vittoria dell’eroe di turno.
Perché vi sto raccontando questo? La mia teoria è che, duemila anni dopo, gli eroi ci siano venuti un po’ a noia.
Meglio tifare per quelli in cui ci riconosciamo di più, perché è un po’ come tifare per noi stessi.
Questa è, secondo me, l’essenza della devotion nata attorno a Scalabrine.
E questa deve essere: celebriamolo non come scarsone che ha vinto un anello, ma come un uomo comune che, con tanto lavoro e impegno è riuscito a ritagliarsi undici anni di carriera in NBA, e che nonostante l’hype subito non ha mai dimenticato di essere un uomo comune.


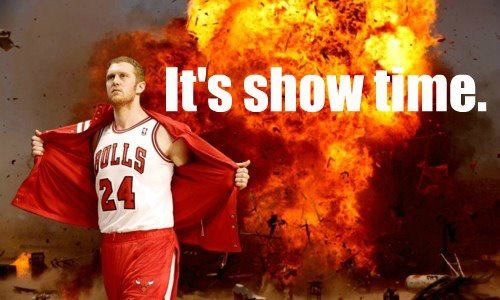





grande articolo! magnifico! il migliore che abbia letto sul sito! forse ho compreso a cosa serva studiare lettere antiche… forse
grande.complimenti per il collegamento.tersite state of mind
Spelandido articolo ! Aggiornamento : ora partecipa alla Big3 il torneo 3 contro 3 organizzati da Iverson !