illustrazione grafica di Paolo Mainini
articolo di Daniele Vecchi
L’agente della CIA è stato catturato nel regno del Dottor Klahn, nelle foresta, sospetto reclutatore e addestratore di mercenari per il suo sanguinario esercito. Lo yankee viene portato di fronte proprio a lui, al Dr. Klahn, per conoscere il proprio destino, assieme ad un altro prigioniero, che gli viene decapitato davanti. Arriva il suo turno, e per spavalderia, precedendo le parole di Klahn, gli grida, per provocarlo:
“Non mi spaventi cane giallo bastardo!”.
Il Dottor Khlan, dopo aver valutato come fare del male all’agente della CIA, opta per la soluzione più logica e dolorosa, e gli dice:
“Lui, riportatelo a Detroit”.
L’agente della CIA impallidisce e inorridisce, e grida:
“NOO!! DETROIT NOOOO!!!!”
Questo esplicativo spezzone di un geniale film del 1977 diretto da John Landis, Ridere per Ridere (“The Kentucky Fried Movie”), esprime alla perfezione quanto pessima sia la reputazione della città di Detroit negli Stati Uniti e nel mondo. Se possibile, Detroit è sensibilmente peggiorata negli ultimi vent’anni, dopo il default della amministrazione e dopo l’abbandono del territorio cittadino (e di tutto il Michigan) da parte dei colossi automobilistici, anche se il rating degli omicidi degli anni settanta fortunatamente non è più stato raggiunto.
Mayce Edward Christopher Webber III, da tutti conosciuto semplicemente come Chris, nacque nei sobborghi di northwest Detroit, ben oltre la famosa e famigerata “8 Mile Road”, divenuta famosa per il film che ha visto Eminem come protagonista, ma che ha dato i natali a fior di giocatori NBA come Jalen Rose, Terry Tyler, Johnny Davis, Dan Roundfield e ovviamente George Gervin, mentre un altro giocatore importantissimo proveniente da Detroit, Dave DeBusschere, è cresciuto in un contesto più “tranquillo” e agiato a North Detroit.
“Da hood is da hood, but this is Motowns” (talvolta sulla ultima parola, in classico accento detroitiano, vi cade una “S”, per questo “Motowns”). Un vecchio detto risalente agli anni 70, che voleva riaffermare la pericolosità e la durezza della periferia di Detroit, negli anni in cui gli omicidi erano intorno ai 700 l’anno.
Il progressivo abbandono della città da parte delle grandi industrie automobilistiche e la conseguente crisi occupazionale, mista agli anni della esplosione del crack come droga dei ceti bassi, hanno fatto in modo che la periferia detroitiana diventasse una vera e propria giungla, ancora di più che in altre città.
In questo contesto è cresciuto Chris Webber, che durante la propria carriera, e anche dopo, ha sempre dedicato tantissimo tempo e denaro alla sua Fondazione The Timeout Foundation (un nome “a caso” in ricordo di ciò che successe alle Final Four NCAA del 1993), una realtà che si dedica alla istruzione dei giovani provenienti da realtà disagiate.
Ad esempio fin dal suo periodo a Sacramento Webber è stato attivissimo nel distribuire biglietti a famiglie povere per le partite dei Kings, quindi si può affermare che Chris Webber non dimentica le proprie origini e che cerca di rendere meno dura, per quanto gli è possibile, la vita dei ragazzi provenienti dal ghetto.
Fin dai tempi della high school Chris era un predestinato, e forse questo è stato fin da subito un problema, per lui.
I problemi con Ed Martin, l’uomo che gli diede reiteratamente soldi extra per giocare a Michigan (e tutto lo scandalo che ne seguì, che portò alla cancellazione dello status di All American di Webber in maglia Wolverines, e a tutti i record e risultati ottenuti da Michigan in quegli anni) e che pare gli abbia anche sovvenzionato parte del suo ultimo anno alla high school, hanno comunque segnato la sua carriera e la sua vita, mettendo a nudo fin da subito la vulnerabilità al limite dell’ingenuità di Webber, che non è mai riuscito nella sua carriera a fare quell’ultimo difficilissimo ma importantissimo step finale che da dominante superstar lo poteva affermare come un vero vincente.
Chris Webber era una ala forte di 2.06 dalla grande esplosività, veloce ad aprirsi in campo aperto, ottimo passatore e ottimo tiratore dalla media distanza, e con un largo range di movimenti in post basso.
Fin dalla Country Day High School a North Detroit, Webber era uno spettacolo itinerante, la sua fisicità, che poi esplose al suo massimo anche nella NCAA e nella NBA, era totalmente abbacinante, a livello scolastico, che fece di lui un automatico predestinato.
Tre titoli MHSAA vinti con la Country Day, National High School Player of the Year nel 1991, MVP del McDonald’s Open e del Dapper Dan All Star Game, e decine di richieste per borse di studio da tutte le più importanti università americane.
Come sappiamo Webber scelse Michigan, per rimanere vicino a casa e probabilmente per non scontentare Ed Martin, e assieme ai Fab Five in maglia Wolverines, portò da freshman la sua squadra a due Final Four NCAA consecutive.
Quei Fab Five erano una specie di rivoluzione, non solo cestistica.

Beggy Shorts and Black Socks (pantaloncini larghi e calze nere), così erano i Fab Five a Michigan, di cui Webber era il leader indiscusso, con Jalen Rose (altro detroitiano doc), il chicagoano Juwan Howard e i due texani Jimmy King e Ray Jackson, cinque freshmen al loro primo anno che riuscirono a raggiungere la finale NCAA per la prima volta nella storia del basket universitario. Questo fatto, misto al particolare momento sociale degli Stati Uniti, con il consolidamento e sdoganamento della cultura rap e una sorta di nuova libertà di espressione afro americana, fecero in modo che i Fab Five divenissero una way of life.
Due consecutivi viaggi alle Final Four per Michigan, nel 1992 e 1993, entrambi conclusisi con una vittoria nella semifinale e con una sconfitta in finale, nel 1992 contro Duke e nel 1993 contro North Carolina.
Quest’ultima gara fu il recipiente di uno dei più ricchi e famosi sports drama del basket universitario, di cui Chris Webber fu purtroppo per lui protagonista.
12 secondi al termine, 73-71 per North Carolina, Webber, con la palla in mano, chiamò un time out dopo che la sua squadra li aveva esauriti.
Fallo tecnico in favore dei Tar Heels, e seconda finale persa.
Ci sta commettere un errore, capita a tutti.
Soprattutto nella foga agonistica.
Webber è stato pubblicamente crocifisso per quell’errore, per tutta la sua carriera e anche oltre gli è stato rinfacciata questa leggerezza, un errore che non ha comunque inficiato la fiducia che gli scout riponevano in lui, anche se, sempre facile parlare con il senno di poi, qualche piccolo segnale sulla sua tenuta psicologica al massimo livello di pressione, poteva essere visto.
Il 30 giugno 1993 al Palace di Auburn Hills a Detroit, nella sua Detroit, Chris Webber venne chiamato dagli Orlando Magic con la prima chiamata assoluta all’NBA Draft (venendo però scambiato subito con Golden State per “Penny” Hardaway), davanti a Shawn Bradley, Penny Hardaway, Jamal Mashburn e Isaiah Rider.


Webber arrivò nella Bay Area con grandi aspettative, e il suo coach era Don Nelson, con cui però immediatamente ebbe poco feeling. Le parole di Nelson, ricordando quei tempi, suonano molto amare:
“Avevo capito subito che con Webber non avrebbe funzionato. Parlai con la proprietà, e gli dissi di tenere lui e di lasciare andare me. Gregg Popovich era un mio assistente e andò a San Antonio, e anch’io ero destinato ad andare là. La proprietà invece cedette Webber a Washington, e disse che puntava su di me. Dopo quattro mesi mi licenziarono”.
Webber comunque giocò una ottima stagione, e anche i Warriors (50 vittorie e 32 sconfitte), con Latrell Sprewell e Chris Mullin sugli scudi, ma con lo stesso Webber che ebbe un grande impatto sul gioco, guadagnandosi il titolo di Rookie of the Year con una stagione da 17.5 punti e 9.1 rimbalzi, facendo vedere sprazzi di immenso talento.

Ma come detto la idiosincrasia con Don Nelson sfociò in una decisione radicale da parte dei Warriors, che cedettero Webber ai Washington Bullets, dove si riunì con il suo vecchio compagno di squadra ai Wolverines Juwan Howard, in una realtà però perdente.
I Bullets infatti in quella stagione vinsero solo 21 partite, anche se Webber si assestò su una media punti di 20.7, divenendo il leader della squadra.
Nella stagione successiva Chris giocò solo 15 partite a causa di reiterati problemi alla spalla destra (due volte slogata, necessitò di un intervento chirurgico), ma nel 1997 ritornò alla grande, portando Washington ai Playoffs per la prima volta dopo otto anni, venendo però sconfitti al primo turno dai Chicago Bulls del Repeat the Three-Peat.
Sempre con Howard al suo fianco e con l’aggiunta di un funambolico playmaker come Rod Strickland, quei Bullets erano una squadra altamente spettacolare, ma non abbastanza solida per riuscire ad impensierire la corazzata Bulls di Michael Jordan.

Anche nella stagione successiva Webber si confermò solido realizzatore, ottimo rimbalzista e discreto leader, ma Washington (che nel mentre aveva chiamato nome in Wizards) non riuscì a raggiungere i Playoffs, e i tempi per una trade del loro pezzo più pregiato sembravano essere nell’aria.
E così fu.
Il 14 maggio 1998 Webber fu ceduto ai Sacramento Kings in cambio di Mitch Richmond e Otis Thorpe, una squadra irreversibilmente perdente e apparentemente con poche possibilità di crescita.
Webber, non esattamente felice, in quel momento, di andare in una delle squadre più perdenti di queglie anni, dichiarò:
“Essere ceduto a Sacramento è stata la cosa peggiore che mi fosse mai capitata, anche peggio del Timeout”.
E invece le cose andarono molto diversamente.
Il turning point di quegli anni di Sacramento fu il Training Camp dei Kings nel settembre 1998, quando si ritrovarono assieme per la prima volta in maglia Kings Chris Webber, Peja Stojakovic, Vlade Divac e Coach Rick Adelman.
L’hardcore di ciò che solo parzialmente è stato, una squadra destinata a dominare e a mettere il proprio sigillo su quegli anni di National Basketball Association.
“The greatest dynasty that never was” è stata una espressione usata molto spesso per gli Oklahoma City Thunder di Russell Westbrook, Kevin Durant e James Harden, ma la madre di tutte le dinastie che non hanno mai avuto la propria realizzazione porta la corona, ed è la Capitale dello stato della California.
Da quella stagione 1998/99 in poi fu una rapidissima ascesa, per Sacramento, trascinati da una città impazzita che gremiva la Arco Arena facendola diventare la arena più calda e rumorosa della NBA. Quell’anno arrivò la prima stagione vincente dal 1983 (quando la franchigia era ancora a Kansas City), con un record di 27-23 (era la stagione del lockout, dove si giocarono solo 50 partite) e con la prima partecipazione ai Playoff per quei Kings in rapida crescita, sconfitti 2-3 dagli Utah Jazz di John Stockton e Karl Malone, ma dimostrando fin da subito un enorme potenziale e immensi margini di miglioramento.
Nella stagione successiva i Kings si confermarono come una ottima squadra, tra le migliori ad Ovest, terminando con un record di 44 vinte e 38 perse, uscendo al primo turno di playoff per mano dei Los Angeles Lakers, che qualche settimana più tardi andarono a vincere il Titolo NBA battendo in Finale gli Indiana Pacers.
I meccanismi offensivi del Princeton Offense disegnato da Pete Carril, anche se ancora Adelman stava cercando il giusto assetto, diedero a Webber, Divac e Stojakovic un ruolo che sembrava disegnato per le loro caratteristiche, e fu lì che Chris trovò la sua vera sublimazione.

Nella stagione successiva arrivarono l’esperto Doug Christie da Toronto, ottimo difensore e con ottima intelligenza cestistica, Bobby Jackson da Minnesota, altro ottimo difensore, e il rookie turco Hidayet Turkoglu, e i Kings migliorarono ancora, 55 vittorie in stagione regolare e una ambizione da contender nemmeno troppo velata.
Chris Webber e Vlade Divac giganteggiavano in area, dalla media e in post basso, Doug Christie riuscì a dare un apporto difensivo decisivo, mentre Peja Stojakovic visse la sua vera breakout season divenendo un vero e proprio punto di riferimento offensivo per Adelman.
In concomitanza con questa grande stagione arrivò anche la prima serie di Playoff vinta dai Kings, 3-1 sui Phoenix Suns, andando ad incontrare i campioni in carica dei Los Angeles Lakers al secondo turno.
I Kings però vennero ancora una volta sconfitti, stavolta molto nettamente 4-0, da Los Angeles, che andarono a vincere il loro secondo Titolo consecutivo battendo in finale i Philadelphia 76ers.
Sacramento aveva preso una forma ben precisa, ma aveva problemi in un ruolo, quello del playmaker.
La stagione del funambolico e spettacolarissimo Jason Williams era stata deficitaria, andando via via sempre più sottotono, fino ad arrivare alla Serie Playoff contro i Lakers, dove Williams praticamente non riuscì ad esprimersi, con 5.3 punti e 2.8 assist di media, rendendo definitivamente lampante l’esigenza dei Kings di portare a Sacramento un playmaker adatto al gioco di Adelman.
Nella estate 2001 arrivò in California Mike Bibby da Memphis in cambio di Jason Williams, il definitivo tassello per l’equilibrio offensivo dei Kings, che divennero lo specchio quasi integrale della perfetta esecuzione della Princeton Offense di Pete Carril.
E furono gli anni in cui Chris era totalmente immarcabile.

La presenza sul perimetro di Stojakovic lo liberava sistematicamente del raddoppio in post basso e dal gomito, la sua media punti si alzò sensibilmente (passò dai 20 punti di media nel 1999 ai 27.1 del 2001, assestandosi sui 24 di media nel 2000 e nel 2002), e divenne il leader offensivo di Sacramento, ma anche molto altro.
E qui subentra ancora il risvolto culturale della vicenda.
Chris Webber aveva tutto per essere l’uomo copertina di quel piccolo mercato televisivo che era ed è tuttora Sacramento. Sappiamo che la NBA ha costruito il suo status di miglior Lega del mondo sulla immagine, sulle icone, e sulla televisione. Le rivalità, la epica delle sfide, e i rappresentanti di ogni squadra dovevano essere “vendibili”, e per esserlo dovevano avere certi requisiti, al netto del talento puro che queste icone trasudavano sul parquet. Chris Webber era in un certo senso la “salvezza” della immagine di Sacramento, mercato televisivo piccolo pur essendo ufficialmente la Capitale della California, con poca storia cestistica, e con due serbi freschi di bombardamento NATO come punte di diamante. Chris Webber aveva tutto, per essere la icona dei Kings, il sorriso smagliante, il background giusto (errori compresi, da cui nell’immaginario comune ci si poteva redimere), cominciava a frequentare i salotti giusti (il fidanzamento con Tyra Banks, ad esempio), ed era culturalmente accettabile anche per i suoi trascorsi con i Fab Five, che avevano segnato una generazione con la storia sognante dei cinque freshmen al limite dell’incoscienza arrivati ad un time out dalla vittoria del Titolo NCAA.
Quindi tutta le responsabilità ricadevano pubblicamente su di lui.
Ad ottobre 2001 arrivò la stagione in cui i Kings sentivano davvero di poter fare il definitivo salto di qualità.
I Kings vinsero la Pacific Division con 61 vinte e 21 perse, confermandosi corazzata vera, stavolta capace per davvero di insidiare i Lakers ad Ovest e anche nella NBA, vista la netta superiorità della Western Conference sulla Eastern nei primi anni duemila.
Ai Playoff Sacramento continuò ad essere la schiacciasassi che era in regular season, eliminando gli Utah Jazz 3-1 al primo turno e i Dallas Mavericks 4-1 al secondo, ed ecco arrivare l’appuntamento con il destino, le Finali della Western Conference contro i Campioni in carica dei Los Angeles Lakers.
Con Stojakovic fuori per infortunio alla caviglia, incidentalmente la truppa di Adelman cercava ancora di più il proprio leader realizzativo, Webber.
In Gara 1 i Lakers espugnarono la Arco Arena 105-99, con Webber autore di 28 punti catturando 14 rimbalzi, ma con grossi problemi di falli, cosa che condizionerà i Kings in tutta la serie.
Gara 2 ancora a Sacramento, vittoria Kings 96-90 con Kobe Bryant che lamentò una intossicazione alimentare in hotel la sera prima, e con un Webber da 21 punti e 13 rimbalzi, serie pareggiata.
Si andò a Los Angeles, rumors dicevano che Peja poteva essere “Questionable” per la partita, ma fu presente in panchina solo in abiti civili, camminando con prudenza.
I Kings ristabilirono l’equilibrio del fattore campo, avendo la meglio 103-90 allo Staples Center, portandosi in vantaggio 2-1 con un grande Chris Webber da 26 punti e con un altrettanto grande Mike Bibby da 24.
La quarta partita fu il vero turning point della serie.
Kings avanti di 2 punti, 99-97 a 11 secondi dal termine, palla per i Lakers.
Jump shot di Kobe Bryant in area contestato da Divac, errore, rimbalzo per Shaquille O’Neal altro errore, ancora due secondi sul cronometro, Divac smanaccia fuori la palla che arriva a Robert Horry che non ha mai lasciato la sua posizione in punta.

Big Shot Rob raccolse la palla, e non sbagliò.
Sulla sirena l’uomo da Alabama mise la tripla della vittoria 100-99 per i Lakers, portando la serie in parità.
Poteva essere il 3-1 per Sacramento, e invece si ritornò a Sacramento sul 2-2.
Fu una brutta botta per i Kings, che praticamente stavano giocando in sei (il solo Bobby Jackson veniva dalla panchina con minutaggi e impatti significativi), e cominciavano a sentire la stanchezza fisica e mentale di quella battaglia che sembrava ben lungi dal finire.
In Gara 5 Stojakovic finalmente tornò in campo, ma totalmente fuori condizione e senza ritmo.
2 punti in 18 minuti con 0 su 3 dal campo per Peja, nella vittoria Kings 92-91 alla Arco Arena, vittoria che valse ai Kings la prima opportunità per accedere alle NBA Finals.
Quella partita fu dominata da Chris Webber, 29 punti e 13 rimbalzi, sembrava essere veramente il suo momento, sopra 3-2 con due chance per raggiungere la Finale, il suo sorriso e il suo lavoro in post basso sembravano andare di pari passo verso un’altra dinastia conseguente a quella dei Lakers di Shaq e Kobe.
Più che mai quelli erano i SUOI Kings, stava dimostrando che anche senza l’aiuto offensivo di Stojakovic poteva reggere da solo il peso offensivo di Sacramento (ovviamente ben coadiuvato da Mike Bibby e Vlade Divac).
Arrivò Gara 6 allo Staples Center, gara che venne poi da più parti etichettata come “Rigged” (truccata), a causa dei 27 tiri liberi concessi ai Lakers nel quarto quarto, a fronte dei 9 concessi ai Kings, con Vlade Divac e Scot Pollard fuori per sei falli e Chris Webber ancora in campo ma condizionato con 5.

I Lakers vinsero quella Gara 6 106-102, con un Webber da 26 punti, 13 rimbalzi e 8 assist, non abbastanza per accedere alla Finale.
Poi il momento arrivò.
I campanacci erano assordanti quella sera a “The Gas Station”. Così era infatti soprannominata la Arco Arena (perché era nel mezzo del nulla, sulla strada nord verso l’aeroporto di Sacramento, e soprattutto perché Arco era ed è un brand di carburante). Si giocava Gara 7, il 2 giugno 2002. La più classica delle “No Tomorrow Game”.
Nonostante la partita fosse sempre sul filo di lana, per i Kings fu una serata disastrosa al tiro. 2 su 20 da oltre l’arco dei tre punti per i Kings, con Stojakovic che a 12 secondi dalla fine sotto di 1 aveva la possibilità di uccidere la partita con una tripla, liberissimo, non toccando neanche il ferro.
Si andò al supplementare, con Vlade Divac fuori per falli.
Adelman non poteva permettersi Scot Pollard su entrambi i lati del campo nell’overtime, per marcare Shaquille O’Neal, quindi decise di mettere Webber su Shaq nei cinque minuti finali, che ovviamente lo marcava anche dall’altra parte del campo. Webber segnò il primo canestro dei supplementari e poi scomparve, divorato dalla difesa su Shaq e in attacco ovviamente soffrendo la fisicità del centro gialloviola, che non aveva brillato fino a quel momento, sotto i colpi di Divac e Pollard.
Ma Webber era stremato, e dopo quel canestro iniziale nell’overtime crollò, lasciando campo libero a Shaq, non riuscendo a trovare la lucidità necessaria per fare quell’ultimo step e mantenere in corsa i suoi Kings quando i Lakers se ne andarono definitivamente anche dopo il fallo sistematico. Persino O’Neal fece due su due dalla lunetta, assieme a Fisher e Bryant, e i Los Angeles Lakers vinsero quella partita 112-106 e volarono in Finale NBA, dove asfaltarono 4-0 i New Jersey Nets.
Dopo quel giorno, nonostante avesse solo 29 anni, la sua carriera accusò una flessione, e non solo per colpa sua.
Quella serie contro i Lakers fu l’apice da cui cominciò a tramontare.
Un’altra ottima stagione a Sacramento. 59-23 il record dei Kings, ancora primi nella Pacific Division, una squadra completa, con l’arrivo di Keon Clark e del journeyman Jimmy Jackson, con la esponenziale crescita di Hidayet Turkoglu, una squadra che aveva ancora delle ottime chance di arrivare fino in fondo.
Per Webber fu una ottima stagione, 23 punti di media e una grande condizione anche e soprattutto nei Playoffs, quando in Gara 2 della Serie di secondo turno contro i Dallas Mavericks incontrò il proprio destino.
“Career threatening injury” si chiamano questi infortuni, infortuni che mettono a rischio una intera carriera, un massacro al ginocchio sinistro mise fine alle speranze di quei Kings di raggiungere la Finale di Conference (dove li aspettavano i San Antonio Spurs che si sarebbero poi laureati Campioni NBA), e anche alle speranze di vincere il Titolo con quel gruppo.

Una stagione praticamente fermo, il suo ritorno arrivò alla fine della stagione 2003/2004, con la sconfitta ai playoff 3-4 in una battagliata serie con i Minnesota Timberwolves dei Big three Garnett, Sprewell e Cassell, e un gioco limitato dai postumi dell’infortunio, con un Webber costretto a consolidare il proprio gioco in between, a diventare una sentenza dal gomito, pur perdendo gran parte della sua esplosività in post basso.
Nella stagione successiva tutti a Sacramento si resero conto che il treno per il titolo ormai era passato, per quel gruppo, quindi all’ultimo giorno utile per i trasferimenti, Webber venne ceduto ai Philadelphia 76ers assieme a Michael Bradley e Matt Barnes in cambio di Kenny Thomas, Brian Skinner e Big Nasty Corliss Williamson.
Ai Sixers Webber trovò Allen Iverson e una squadra che a loro volta qualche anno prima aveva perso il treno per il Titolo, una squadra che cercava e non trovava un’identità, una squadra che non la trovò nemmeno con l’arrivo di Webber, incapace di ritrovarsi, dopo quelle NBA Finals 2001, per quasi un ventennio.

Philly venne eliminata dai Detroit Pistons al primo turno della Eastern, non fece i Playoffs nella stagione successiva 2005/2006, Iverson venne ceduto a Denver, i Sixers si sfaldarono definitivamente e Webber venne ceduto a Detroit, dove ebbe gli ultimi sussulti della sua carriera, giocando i Playoff fino alle Eastern Conference Finals, eliminati 4-2 dai Cleveland Cavaliers di LeBron James.
Chris Webber fece una breve apparizione di ritorno ai Golden State Warriors nel gennaio 2008, paradossalmente ancora agli ordini di coach Don Nelson, tornato pure lui nella Bay Area dopo 11 anni, ma sole 9 partite giocate con meno di 4 punti di media a partita in 14 minuti di impiego, martoriato dai gravi problemi al ginocchio, ritirandosi ufficialmente dal basket giocato il 25 marzo 2008.
Ma chi era veramente il Chris Webber giocatore?
E’ difficile pensare a un giocatore che abbia creato un range così ampio di estimatori e detrattori. C’è chi dice che un giocatore così talentuoso e completo su entrambi i lati del campo si è visto molto raramente, e allo stesso tempo c’è chi dice che è uno dei giocatori più sopravvalutati della storia, c’è chi dice che è uno scandalo che non sia ancora nella Hall of Fame, e c’è chi dice che è uno dei più grandi sprechi di talento mai visti.
Come spesso accade la verità potrebbe stare nel mezzo, anche se appare innegabile che l’impatto cestistico-culturale che Webber ha avuto nelle due fasi più importanti della sua carriera, ovvero i due anni a Michigan University e i cinque anni ai Sacramento Kings, sia stato veramente grande.
L’immensità del suo talento è esplicata nel fatto che Webber era in campo, negli ultimi minuti di uno dei più emozionanti All Star Game della storia NBA, a Washington nel 2001, dove in maglia Sacramento Kings fu tra i cinque giocatori della Western Conference che terminarono la partita (assieme a Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett e Jason Kidd), purtroppo per loro con una sconfitta, con la stoppata di Vince Carter su Tim Duncan e fallendo per un soffio il canestro della vittoria, venendo poi sbeffeggiato al termine della gara dal suo amico fraterno Latrell Sprewell, corso dalla panchina della Eastern Conference per esultargli in faccia.

A quel tempo Webber era all’apice della sua carriera, e quei Kings, con Jason Williams prima e con Mike Bibby poi, con Vlade Divac, Doug Christie e Predrag Stojakovic, erano una squadra bellissima da vedere, anche e soprattutto grazie a lui.
Dal 2013 Chris Webber è eleggibile per la Naismith Hall of Fame, ogni anno da allora è tra i candidati ma non è ancora stato scelto. In occasione del prossimo All Star Weekend ad Atlanta tra qualche giorno si saprà se Webber sarà selezionato, o se dovrà aspettare ancora.
Su una cosa non ci piove e non c’è assolutamente da discutere, e su cui probabilmente tutti, detrattori e non detrattori, sono d’accordo: Chris Webber è stato uno dei giocatori più talentuosi che abbiano mai calcato i parquet della NBA.

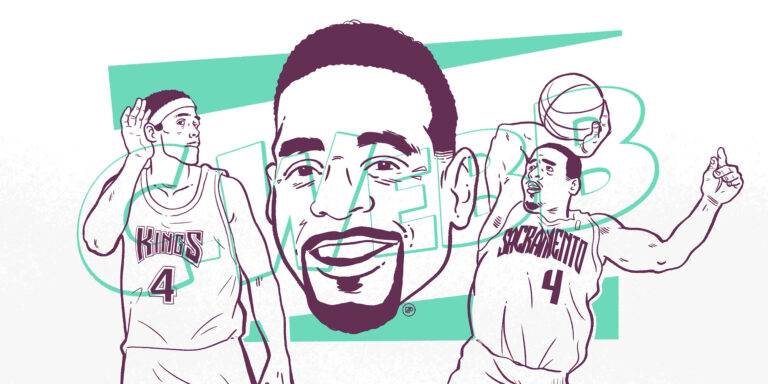




Ciao Daniele,
ho letto e apprezzato l’articolo.
Scrivo per segnalarti un errore:
“Washington (che nel mentre aveva CHIAMATO nome in Wizards)”
Rimuovi pure il commento una volta effettuata la correzione.