Ascoli Piceno è la città dove ha per la prima volta preso in mano un pallone un ex NBA come Nemanja Nedovic (il papà giocava a pallamano con la squadra locale). Ma non possiamo certo dire che sia Basket City. Lo sport, in città, gravita essenzialmente intorno alla squadra di calcio, che oggi milita in serie B ma che ha trascorsi anche discretamente importanti in serie A: 16 campionati giocati, una Mitropa Cup vinta e una comparsata di Hugo Maradona, fratellino di Diego.
Da poco più di tre anni, però, grazie ad un’intuizione di Daniele Aniello, è nata una struttura unica alle nostre latitudini: la IPA, Italian Prep Academy. Sostanzialmente, si tratta di una struttura che si affianca al settore giovanile della prima squadra locale, che ha sempre fluttuato tra serie C e D, ospitando decine di ragazzi provenienti dall’estero, per la maggior parte del Regno Unito. Ragazzi (qualche decina all’anno quelli che vengono reclutati) che vogliono passare una stagione ad allenarsi e misurarsi con una realtà diversa per poi provare a sfondare nel basket professionistico. Per fare un esempio, Callum Lawson, ala inglese classe 1996, l’ho incontrato lo scorso anno (dovrei dire, mi ha fatto il culo, ad essere onesto) sui campi della serie D marchigiana e qualche mese fa è sbarcato in America, a Western Wyoming, junior college di Division I.
“Sognano tutti la NBA, la conoscono alla perfezione. Ma dell’Eurolega o dei campionati europei sanno poco niente, ancor meno della lega britannica, la BBL – mi conferma Daniele, che nella sua carriera di giocatore è stato anche in Germania e in Irlanda – per questo in tanti tentano l’avventura al college in America (sono in 27 nella sola Division I quest’anno, ndr). Noi proviamo a dare loro la possibilità di fare un’esperienza che li aiuti a crescere”.
La questione che mi sono posto (e gli ho posto) è però un’altra: ma davvero per un ragazzo che sogna la NBA venire ad Ascoli (con tutto il rispetto per la patria dell’oliva fritta, sempre sia lodata) è meglio che restare in Inghilterra, in Irlanda, in Olanda?
La risposta è: sì.
Giusto un paio di settimane fa, spulciando nella Rete, mi sono imbattuto in un breve documentario, prodotto fresco fresco da Dazed and Confused, sulle negligenze delle istituzioni britanniche nei confronti del basket (è in inglese, ma merita davvero):
I 30” iniziali mi hanno piuttosto turbato. La Regina Elisabetta sgancerà 18 milioni di sterline agli sport equestri a partire dal 2016 e 0 (avete letto bene, zero) al basket? Già. La pallacanestro d’Albione non riceve un pound di contributi dal novembre 2014, quando la federazione inglese fu salvata sull’orlo del precipizio da un contributo una tantum di 1,8 milioni.
“Eh vabbè ma chi segue il basket in Inghilterra”, starete pensando se non avete visto quei 30” di documentario.
Niente di più sbagliato.
Nel Regno Unito, il basket è il secondo sport nella fascia di età tra i 14 ed i 16 anni, con 218 mila praticanti. Un numero che però si assottiglia progressivamente (e di molto) con l’avanzare verso l’età adulta. Niente soldi, niente investimenti, i giovani si danno ad altre attività, il basket di alto livello muore.
Eppure la NBA ci sta investendo forte. Ogni anno, la gara di regular season che si disputa a Londra va puntualmente sold out nel giro di un paio di giorni (ho assistito a Knicks-Pistons del 2012 alla O2 Arena e vi assicuro che l’atmosfera era davvero incredibile) e le Junior NBA Leagues (30 scuole medie londinesi sono state abbinate alle trenta franchigie NBA e hanno disputato un vero e proprio campionato) danno una forte spinta alla promozione del basket dalla base. E poi l’eco delle Olimpiadi 2012, con la grandiosa finale tra USA e Spagna, è ancora vicina e pure Eurolega ha provato a dare una mano portando le Final Four 2013 nella capitale, quelle del bis dell’Olympiacos sul Real Madrid, ventilando più volte l’ipotesi di una licenza A per un team inglese.
Insomma, è come se si riempisse un serbatoio dall’apertura principale ma lo si svuotasse forandolo sul fondo.
E pensare che il basket, in Europa, è arrivato proprio dall’Inghilterra. Ce lo portò CJ Proctor, presidente della Birkenhead YMCA, nel 1892, solo un anno dopo che Naismith aveva promulgato la tavola delle 13 regole. Il basket iniziò ad essere praticato in tutte le YMCA d’Inghilterra e la nazione restò punto di riferimento fino alla Seconda Guerra Mondiale, tanto che alle Olimpiadi di Parigi del 1924, quando ancora il basket non era sport olimpico, l’Inghilterra, rappresentata dal team della London Central YMCA, sbaragliò tutti gli avversari.
Nei decenni successivi, le altre potenze europee sorpassarono il Regno Unito, che però, a differenza di oggi, negli anni ’60 e ’70 erano presenze fisse nelle coppe europee. Il Crystal Palace, nei gironi della Coppa delle Coppe 1976, addirittura sbancò Milano, mandando al tappeto la Cinzano di Mike Sylvester e Pino Brumatti che poi vincerà la coppa. A trascinare i britannici era Jim Guymon, guardia da Eastern New Mexico che era stata scelta al draft dai Cincinnati Royals ma che aveva dovuto declinare i sogni di NBA per colpa di una epatite virale. Negli anni ’80, il Crystal Palace sbarcò anche in Coppa dei Campioni, dove tirò un discreto colpo mancino al Real Madrid di Dalipagic e Delibasic nella gara di andata dei quarti di finale: vittoria per 89-81 nel match di andata con 32 punti dell’ex campione NBA in maglia Sonics JJ Johnson.
Il Crystal Palace si fonde nel 1998 coi London Towers, l’ultima squadra britannica a disputare la massima competizione europea (l’Eurolega 2001-2002, chiusa con 0 vittorie), ma prima ci fu anche il Kingston a farsi valere. Eccome. Nella Coppa dei Campioni 1990-1991, i Kings, con in squadra l’ex Globetrotter Alan Cunningham e Alton Byrd (fece il camp estivo coi Celtics nel 1979 insieme al quasi omonimo Larry Bird), buttarono fuori il Cska Mosca negli ottavi di finale e nella fase i gironi batté a domicilio la Scavolini Pesaro, costringendo all’overtime la Pop ’84 Spalato di un Toni Kukoc che ci si dovette mettere d’impegno scrivendo 28 punti a referto.

L’ultima apparizione di una squadra britannica nelle coppe europee è quella dei Guildford Heat nell’Eurocup 2007-2008, avventura terminata ai gironi senza vittorie e con uno scarto medio di 23,7 punti. Da lì in avanti il nulla. Niente inviti in Eurolega, nemmeno l’idea di provare la carta Europe Cup dove si è persino iscritta una selezione dei migliori giocatori irlandesi sotto il vessillo Hibernia (con risultati tragicomici). Niente. A parte una puntatina di Dennis Rodman con la casacca dei Brighton Bears datata 2006, che peraltro rischiò pure di costare una penalizzazione alla squadra inglese, che nel match contro gli Heat (non Miami, ma Guilford) scesero in campo con quattro extracomunitari anziché tre.

“Di atleti e ragazzi con voglia di imparare ce ne sono molti – mi ripete Daniele – ma per migliorare davvero devono per forza andarsene, il livello locale è troppo basso”.
Se a livello di club la situazione è drasticamente peggiorata, è anche per questo: i migliori, quelli che hanno davvero le qualità per sfondare, lasciano presto la Gran Bretagna per andare in Europa (per i britannici il continente è l’Europa, loro sono una cosa a parte) o in America. Il risultato è che di giocatori britannici in NBA e nei principali campionati europei ce ne sono stati e continuano ad esserci. Luol Deng e Ben Gordon sono solo i più famosi, ma di recente sono passati tra i pro anche Joel Freeland, Pops Mensah-Bonsu, Robert Archibald e John Amaechi.
Proprio quest’ultimo, famoso più per l’essere stato tra i primi giocatori omosessuali a fare coming out che per la dimenticabile esperienza di 7 partite a Bologna sponda Virtus nel 1997 (3,5 punti e 2,5 rimbalzi di media), aveva lanciato un monito dopo le Olimpiadi di Londra, che molti credevano sarebbe stato il trampolino di lancio per il basket inglese. Che però è tornato nell’oblio dopo aver fallito la qualificazione a Eurobasket 2015 per mano dell’Islanda. “Non cambierà nulla ed è tragico, perché abbiamo il talento e abbiamo il potenziale – disse l’ex pivot di Magic e Jazz in un’intervista a Dailystar del luglio 2013 – non è un problema nemmeno di soldi, ma di volontà. Non ha senso avere strutture che costano meno se gli allenatori fanno schifo. Dovremmo mandare via tutti gli incapaci. Tutto ciò che è cambiato è l’entusiasmo intorno basket. Ma ci siamo basati sull’afferrare ragazzi che hanno le mamme irlandesi o cose del genere. Questo non è solo sostenibile. Poi è ovvio che non si stimoli a diventare professionisti in Inghilterra se il giocatore di basket medio prende 7 mila sterline all’anno”.
Insomma, di materiale umano ce ne sarebbe, le strutture non mancano di certo (nella sola Inghilterra ci sono ben 28 palasport con almeno 3.500 posti) e il terreno è dissodato da decenni. Non resterebbe che seminare davvero. I 14.500 (avete letto bene) che hanno riempito la O2 Arena di Londra per la finalissima del campionato 2014-2015 vinto dai Newcastle Eagles confermano.
















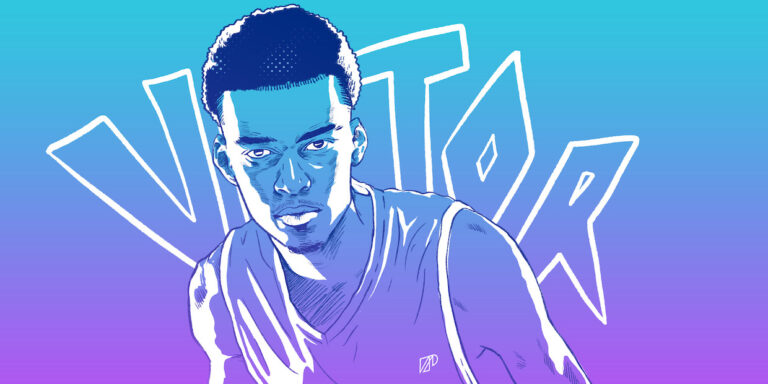








articol ofantastico, io ci ho vissuto ed è veramente così. al campetto c'è un livello molto alto, poi nulla più.