illustrazioni grafiche di Paolo Mainini
“La pressione può spaccare tubi o creare diamanti, altri tipi di pressione non ne conosco.”
Con questo mantra un giocatore d’azzardo dovrebbe affrontare il miscuglio di sensazioni che ha dentro, mentre si fa strada nello scintillante casinò della NBA. Se arriva alla fine del percorso nel fondo della stanza trova il tavolo migliore, quello dei playoffs, dove si tiene la partita di blackjack. Non importa se ci si presenta vestito con un trendy completo rosso, con un glamour abito gialloviola o con un distinto frac neroargento; ma solo che abbia fra le mani le carte giuste. Innanzitutto una figura, pezzo di alto valore, che renda elevate le possibilità di trionfo: sia esso un Hakeem Olajuwon o un Tim Duncan. E’ addirittura meglio possederne due, come Shaquille O’Neal e Kobe Bryant, ben sapendo che le possibilità di mantenere un equilibrio senza sballare non sono tantissime.
C’è però solamente una carta che vi si può associare per essere certi di non soccombere al dealer. Si tratta dell’asso, che non dà un punteggio fisso, potendo assumere il minimo o il massimo valore possibile nel gioco. Nonostante la sua variabilità, quando arriva il momento di esibire la propria dote, non c’è giocatore che non voglia averlo a disposizione. Nella sala giochi della Lega, l’asso è l’autore della citazione di apertura: Robert Horry.

7 punti, 2.1 assist, 4.8 rimbalzi, 1 rubata, 0.9 stoppate in regular season, dove è partito titolare in 480 partite su 1107; 7.9 punti, 2.4 assist, 5.6 rimbalzi, 1.1 rubate e 0.9 stoppate ai playoffs, con 116 partenze in quintetto su 244 apparizioni. Le medie della sua carriera non sono certo di quelle che fanno strabuzzare gli occhi. Al loro interno, però. si ritrovano valori che vanno oltre quelli dei semplici numeri. Sono quelli dei canestri realizzati quando il pallone pesa quanto il piombo, e infilandosi nell’anello cambia non solo le cifre del punteggio, ma anche l’inerzia della partita e l’emotività dei ragazzi sul parquet. In quegli attimi sono solitamente le superstar a farsi conduttori verso la Terra Promessa della vittoria; ma Horry ha spesso assunto al loro posto quel ruolo, svestendo occasionalmente i panni del comprimario e guadagnandosi così il moniker di Big Shot.
In un certo senso ha segnato un’epoca, visto che ogni squadra che ha conquistato il titolo dal 1994 al 2003 ha presentato nel roster o lui o Steve Kerr, altro role playerd’eccellenza nei momenti topici delle partite.
Se però il discreto contributo dalla panchina di Kerr, fra i suoi pregi (il tiro) e i suoi difetti (la taglia fisica) è stato continuo, il rendimento di Horry ha avuto un andamento sinusoidale.
All’interno di una stessa stagione, all’interno di una stessa serie, a volte anche all’interno della partita, Robert era in grado di passare dalle marce bassisime alle più alte in un amen: uno switch fulmineo da un atteggiamento quasi disinteressato alle lotte colpo su colpo, in difesa quanto in attacco, con le migliori ali forti della Lega (partendo da Malone e Barkley per finire a Webber e Rasheed Wallace). Il tocco del pallone di Horry poteva essere ferro o poteva essere piuma, con la tendenza nei possessi decisivi ad esser piuma.
Tanto leggera quanto invece fu pesante la sua infanzia, con il divorzio dei genitori poco dopo la sua nascita, il trasferimento dal Maryland all’Alabama e la possibilità di vedere il padre con continuità arrivata solo dopo vari anni. Una durezza tramutata sul campo di gioco in compattezza difensiva, nell’Andalusia High School primal e nella University of Alabama poi; in quest’ultima, nel corso della sua militanza, oltre a ritrovarsi per due anni Latrell Sprewell come compagno di squadra, piazzò 286 stoppate, fissando l’allora record dell’ateneo.
Tra gli scout NBA si alzò qualche sopracciglio e in un draft in cui solo le prime tre scelte (Shaq O’Neal, Alonzo Mourning e Christian Laettner) erano viste come prospetti impossibili da passare, venne selezionato per undicesimo dai Rockets. Si realizzò così il suo sogno di giocare con l’idolo Hakeem Olajuwon; per ingraziarsene i favori, da buon esordiente Horry si dedicò principalmente a sudare in difesa e sgomitare a rimbalzo, sacrificando le conclusioni personali pur di servire in post The Dream ogni volta che chiedesse l’arancia.
Ciononostante, diede una piccola prova del sangue freddo nel momento di insaccare i tiri decisivi: in gara 7 delle semifinali di Western Conference, fu lui a portare in vantaggio i Rockets a 34 secondi dalla fine. Il gesto passò sotto relativo silenzio, a causa del pareggio e successivo sorpasso dei Sonics al supplementare, in quella che si rivelò l’unica elimination game persa da Olajuwon fra ‘93 e ‘95; in pochi immaginavano che non si trattava di un’isolata preghiera accolta dagli dei del basket.
Nonostante l’avvio a razzo nella stagione successiva, con il 15-0 che pareggiava la miglior partenza in regular season nella storia della NBA, la ritrosia alle iniziative personali di Horry fu individuata come punto debole dai Rockets. Addirittura Olajuwon stesso mise in dubbio la suo impegno per la causa, celato sin troppo dietro un’apparente noncuranza. Il front office si mise alla ricerca di un miglior realizzatore, che fu individuato a febbraio in uno Sean Elliott in rotta coi Pistons. Come controparte, nella Motor City Horry lo avrebbe affiancato Matt Bullard; se però quest’ultimo era contento della nuova situazione, visto il ruolo di spicco promessogli da Don Cheaney (suo primo allenatore ai Rockets), Robert era ne avvilito.Provò a soffocare la delusione in qualche birra, come notato nelle inquadrature della tv dalla madre, mentre dal box presidenziale assistette al match dei Pistons dopo la richiesta precauzionale di non giocare. Il direttore del personale Billy McKinney infatti fece rinviare il suo debutto, raccontando come la finalizzazione della trade tardava ad arrivare per problemi nelle visite mediche di Elliott. Horry ebbe un’epifania: basta alle troppe rinunce, che lo avevano portato ad essere accantonato per il difetto di prendersi pochi tiri, l’opposto del vizio ben più comune di egoismo sfrenato.
La trattativa saltò definitivamente, per i problemi al rene che Elliott ammise quindi pubblicamente; il Robert che tornò a Houston con questa nuova risoluzione cominciò ad avvicinarsi alla figura desiderata dal front office dei Rockets. D’altro canto, c’era una possibile occasione da cogliere: Michael Jordan si era dato al baseball, l’albo d’oro della Lega attendeva un nome nuovo rispetto ai Chicago Bulls. I Rockets, secondi ad Ovest nella stagione regolare, avevano le carte in regola per la conquista dell’anello; superato il primo turno dei playoffs, trovarono sul loro percorso i Suns di Barkley, finalisti nell’annata precedente. Buttate le prime due partite dopo cospicui vantaggi, lo Houston Chronicle fu impetuoso nell’affibbiare il soprannome alla banda di coach Tomjanovich: Houston diventò Choke City.

Quel choke, termine che nello sport americano è utilizzato per sottolineare l’incapacità di primeggiare negli episodi chiave, finì per caricare i Rockets che reagirono alla grande: vittoria nei seguenti tre match, fino ad arrivare al titolo. Citando un’intervista del proprietario Leslie Alexander, il soprannome mutò in Clutch City, col vocabolo clutch che invece indica il successo nei momenti decisivi.
Un concetto che Horry comincerà ad abbracciare in pieno nell’annata successiva, in cui coi Rockets si lanciò alla ricerca del bis titolato. Dopo le ultime 8 gare della stagione regolare con un brutto 6/28 da 3 punti, Robert accese l’interruttore ai playoffs: nella postseason il suo bottino ammontò a 12.8 punti a partita, la percentuale dietro l’arco al buonissimo 38.7%. Ma soprattutto scrisse il manifesto della propria reputazione nei momenti topici. Il piatto forte delle finali della Western Conference fu il confronto fra Hakeem Olajuwon e David Robinson: ma in gara 1 i San Antonio Spurs sfoggiarono anche uno scintillante Sean Elliott. Già: indubbiamente, il destino sa disegnare con cura gli incroci nelle proprie trame. A 6.5 secondi dal termine del primo confronto, Horry si prese il jumper con cui mise definitivamente avanti i suoi; ovviamente, senza aver segnato dal campo nel match fino a quel momento.
Salto alle Finals, dove la posta in gioco diventa massima. Robert non si fece cogliere impreparato: i due punti non gli erano più sufficienti, e per respingere il tentativo di rientro nella serie da parte dei Magic, sfoderò una tripla a 16.5 secondi dalla fine per il 106-103 finale. 3-0 nel computo totale per i Rockets, che liquidarono in 4 gare la banda di Shaquille O’Neal per prendersi il secondo titolo consecutivo.
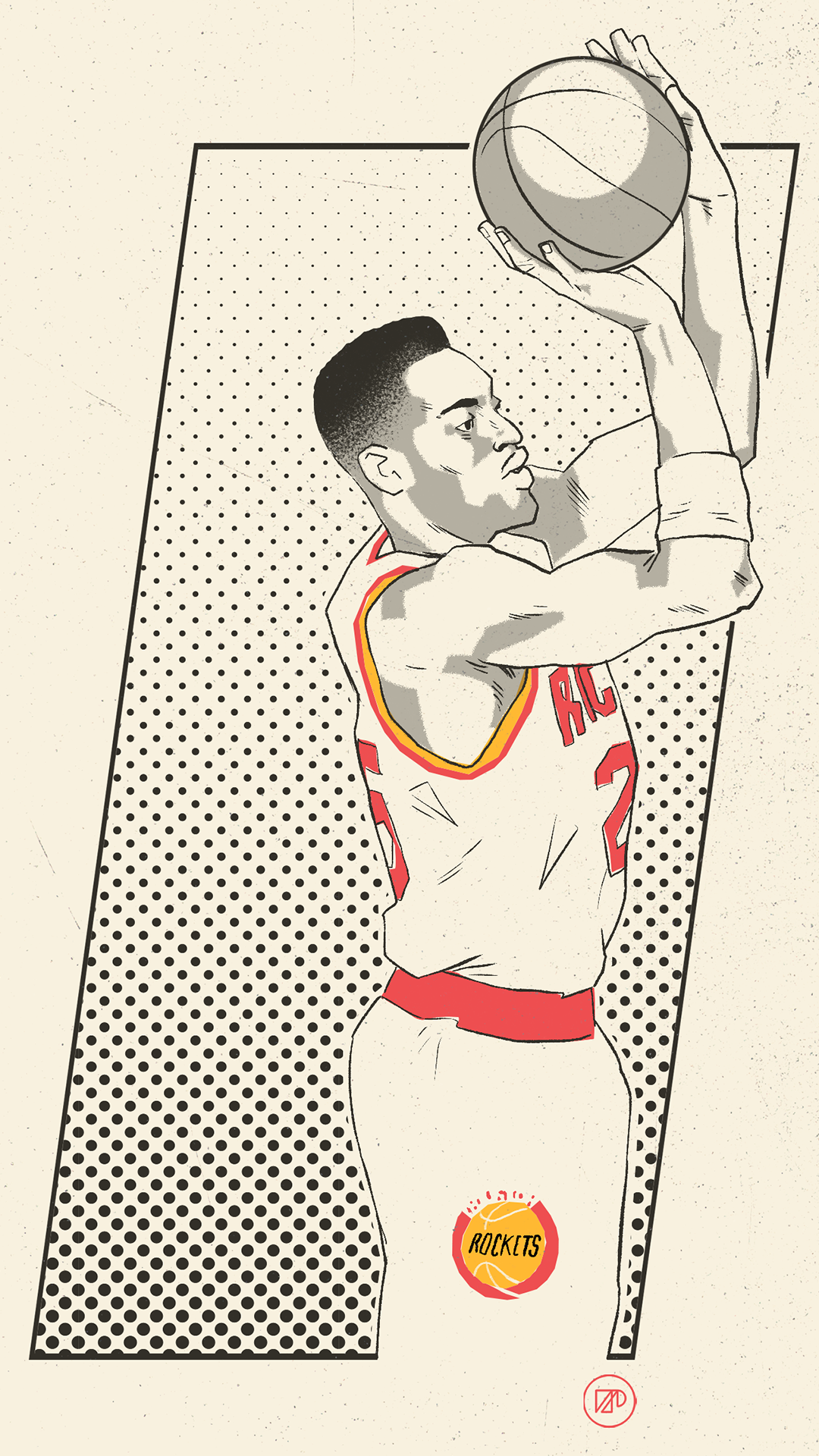
E’ l’affermazione che resterà più gradita a Horry, vista la partenza nel tabellone dei playoff dal modesto sesto posto (e la conseguente assenza di fattore campo in ogni serie giocata) e la presenza di coach Tomjanovich in panchina, apprezzato per la gestione player friendly. Forse fu proprio merito della guida accondiscendente di Rudy T se riuscì a piazzare un record in quelle finali: quello delle rubate in singola partita, con le 7 di gara 1.
E pensare che il Defensive Player of the Year in quella stagione fu il compagno di squadra Hakeem…
Per provare un terzo assalto al titolo, i Rockets rischiarono: aggiunsero un Barkley in declino ad Olajuwon e Draxler, per compensare col talento l’avanzare dell’età dei due punti di riferimento. Ai Suns furono girati Sam Cassell, Chucky Brown e Mark Bryant, oltre allo stesso Horry. Mentre a Houston le tre star non poterono che arrendersi al peso degli anni, Robert a Phoenix mandò a bersaglio un altro tiro: quello dell’asciugamano diretto a coach Danny Ainge, che gli valse impacchettamento e spedizione ai Lakers in cambio di Cedric Ceballos.
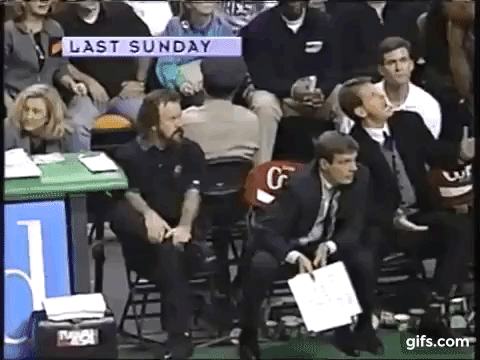
In gialloviola trovò la coppia Shaq&Kobe all’alba del loro periodo di gloria. Un periodo che non sembrava vicinissimo, a dir la verità: intorno ad O’Neal la nuvola dell’incapacità di vincere si addensava, così come i capelli sul capo di un inesperto Bryant, ai primi passi nella Lega.
I successi non arrivarono subito: nei playoff di quell’anno la squadra si fermò in semifinale di Conference. Piccola soddisfazione, il record stabilito da Horry in gara 2 delle semifinali della Western Conference: con il 7/7 dietro l’arco fece suo il primato per il maggior numero di triple segnate senza errori in un match di postseason.
Dopo altri due anni senza arrivare in fondo, complice l’ingaggio di coach Phil Jackson, i losangelini furono pronti. Per il ruolo di Horry in squadra era stato scritto un apposito copione, seguito via via negli anni: per il ruolo di ala forte partiva dalla panchina, per poi prendersi lo spot da titolare nei momenti importanti. Nella stagione 1999/2000 in quintetto base c’era A.C Green; ma dopo un desolante 1/12 da tre nelle prime 5 gare delle Finals, fu Horry a piazzare il ⅔ dietro l’arco che fece da propellente per la vittoria in gara 6 e il conseguente titolo.
La formula magica trovata dal coach Zen aveva appena iniziato a fare il suo effetto.

La stagione successiva la nuova ala forte titolare fu Horace Grant; per i losangelini, con 11 vittorie e 0 sconfitte nella postseason, furono nuovamente Finals. Ma, in un periodo in cui era più difficile primeggiare nella Western Conference che superare la finalista proveniente dall’Est, l’ultima serie iniziò con una sorpresa. Allen Iverson passò su Tyronn Lue facendogli perdere la reputazione, i 76ers passarono sui Lakers facendogli perdere il fattore campo. Pareggiato il computo totale in gara 2, nel terzo match il confronto si spostò a Philadelphia. L’indiavolato tifo del Wells Fargo Center fu però zittito dai gialloviola, grazie anche al cruciale contributo di Horry col suo importante 3/3 da dietro l’arco. Fra queste, spiccò la tripla dall’angolo che a 47 secondi dal termine scavò il definitivo solco fra le due compagini.
Quel successo fu l’apripista per il secondo titolo consecutivo dei gialloviola, ma la storia non era finita.
Si ripetè la sostituzione dell’ala forte titolare (diventata Samaki Walker) e anche l’accoppiamento nel primo turno di playoff. Allo stesso modo, nuovamente si manifestò il binomio Horry/Big Shot, facendo capolino però già nel primo turno. In gara 3 contro i Blazers, solito avvio lento di Robert, con 0/3 al tiro pesante; negli ultimi 3 secondi di gara si fece comunque trovare pronto, destinatario di un inconsueto scarico di Bryant, puntualmente convertito nella tripla che completò lo sweep.
Il test più probante per i gialloviola era però quello della finale di Conference: di fronte c’erano i Sacramento Kings col loro greatest show on the court. La potenza in post basso di Shaq, le risposte a base di tecnica e flopping di Divac, le folate offensive di Bryant, i tiri segnati o meno da Bibby e Stojaković, i gesti alla moglie in tribuna di Christie, la precisione chirurgica di Fisher: nella serie si vede un pò di tutto, e la tempestività di Horry non poteva mancare. Gara 4 allo Staples Center: i Kings erano attaccati nel punteggio, con la possibilità di tornare a Sacramento con la serie sul 3-1 e due occasioni per eliminare i campioni in carica. 8 secondi dall’ultima sirena, coi losangelini a -2. Kobe sfuggì a Christie, ma sull’aiuto di Divac non riuscì a coordinarsi per il pareggio. Shaq, senza nessuno che lo tagliasse fuori, fece il vuoto a rimbalzo ma non corresse a canestro. Vlade, giratosi nel frattempo, pensò solo ad allontanare il più possibile la palla e con essa le speranze gialloviola. Con la smanacciata, le affidò entrambe alle mani meno raccomandabili per le sorti dei Kings in quel momento sul parquet: quelle di Robert Horry, appostato dietro la linea da 3 punti. Il suono della sirena precedette di poco lo schiaffo della retina: fu vittoria losangelina in un epilogo thriller, anticipazione del finale dell’intera serie.
All’ultimo atto, i Nets non avevano abbastanza per poter opporre resistenza: il conteggio degli anelli di Horry segnava 5 trofei in 10 anni. La fame di quei Lakers non era comunque terminata, e i segnali nel corso della regular season seguente preannunciavano una quarta affermazione consecutiva. Ad esempio, arrivò il déjà vu di quella conclusione contro i Kings: 5 marzo 2003, contro gli Indiana Pacers.
Col match sul 95 pari, il pallone venne sputato fuori dall’area dall’anticipo di Jermaine O’Neal su Shaq; la sfera carambolò nuovamente nelle mani di Horry, l’effetto sul risultato fu il medesimo.
Arrivati i playoffs, ecco il crocevia con gli Spurs, in procinto di diventare l’unica vera alternativa ai gialloviola in quegli anni nella Western Conference. Con la serie sul 2-2, nella gara 5 all’AlamoDome gli speroni conducevano di 2, con 14.7 secondi ancora da giocare e possesso in mano ai Lakers. Bryant non trovò lo spunto per sparare la conclusione, e chiuso da Bowen scaricò nelle sicure mani di Horry. Il tono della voce del telecronista Marv Albert si alzò di pari passo alla parabola che Robert fece partire: entrambe furono però stoppate dal ferro, che chiuse di fatto l’epopea di quei Lakers, fatti fuori nella sesta partita dall’armata di Popovich poi campione NBA.
72 giorni dopo quell’errore, Horry lasciò i Lakers per firmare proprio con San Antonio, definendo il modello che altri in futuro adotteranno nei confronti della rivale che li aveva sconfitti. La sua sorte non fu però come quella di Durant, bensì come quella di Varejão: gli Spurs furono infatti battuti a loro volta dai Lakers.
Una nuova occasione arrivò nell’annata successiva, in cui Horry giunse ai playoffs dopo una miglior stagione regolare: in 75 gare mise piede in campo, in 15 firmò una doppia cifra.
Nella postseason l’accelerazione: le doppie cifre furono 11, però in sole 23 apparizioni. Fra queste, è compresa la performance più rappresentativa della sua intera carriera.
Gli avversari erano i Pistons campioni NBA in carica, come a voler chiudere un cerchio; il palcoscenico era vquello di una pivotal game delle Finals, in cui regnava l’equilibrio.

In un match in cui la squadra in vantaggio cambiò 12 volte e le parità furono 18, la presenza di Horry fino all’ultima azione del terzo quarto fu impalpabile.
Poi, sarà stata l’adrenalina data dalla tripla messa quasi sulla penultima sirena, sarà stato il ricordo del figlio che il giorno prima gli aveva chiesto perché non schiacciasse più, o chissà cos’altro: a Robert si accese l’usuale lampadina.
Diventò il miglior giocatore in campo: a quei primi 3 punti, ne aggiunse altri 18 fra ultimo quarto e supplementare, ricorrendo al suo intero arsenale offensivo.
A partire da una delle migliori inchiodate della sua carriera, alla faccia dei 34 anni, con dedica al piccolo Camron:

E immancabile, dopo lo strappo da 7 punti in 58 secondi, arrivò il tiro che di fatto chiuse il match: dallo scarico ricevuto in parziale emergenza da Ginobili, a meno di 6 secondi dalla fine del supplementare, rilasciò il pallone della quinta tripla della sua gara e del vantaggio Spurs, che chiuderanno infine la serie prendendosi l’anello.
Ormai agli sgoccioli della propria carriera, Horry regalò un’ultima perla nei playoffs del 2007. Gara 4 del primo turno, coi Denver Nuggets avversari. A meno di un minuto dal termine della gara, gli Spurs sopra di 1 cercavano il colpo del KO per le ambizioni dello strano duo Iverson-Anthony. All’affondo decisivo ci pensò il solito Robert: con soli 3 punti in cascina fino a quel momento, dall’angolo piazzò la tripla che chiuse la gara e, moralmente, la serie (terminata poi nel match successivo). Iniziò così l’ultima cavalcata vincente di Horry, in quella che si rivelò la penultima stagione in assoluto della sua carriera.
Per chi voglia provare a giocare a blackjack, ma a disposizione ha solo le carte napoletane, è stata elaborata una variante. In essa, le figure hanno molto meno peso, con fante, cavallo e re a contare solo 1/2 nel punteggio totale; le carte importanti sono altre, e fra queste la “matta” che può cambiare il suo valore all’occorrenza è una sola. Il suo seme è quello dell’oro, simbolo d’antonomasia del successo; i denari disegnati sopra sono sette, tanti quantii titoli presenti nella bacheca di Big Shot Rob.






