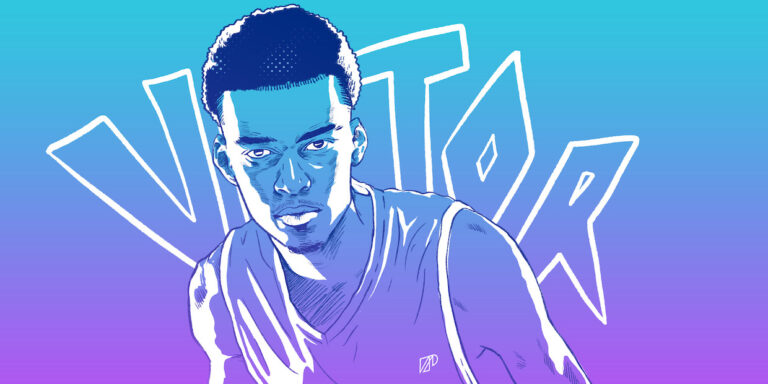articolo di Marco Pagliariccio
disegno in copertina di Anna Iannucci
La vita, che mi ha sorretto attraverso questi anni, è ancora nelle mie mani e nei miei occhi.
Se io abbia saputo superare le sue prove, non so.
Ma finché dura, essa si cercherà la sua strada.
Erich Maria Remarque, “Niente di nuovo sul fronte occidentale”
Belgorod, letteralmente “città bianca”, deve il suo nome alle cave di calcare che ne circondano i limiti cittadini. Il candore dei suoi mattoni è stato però spesso macchiato di sangue nel corso del Novecento. Terra di confine, terra di fronte quella dell’oblast sulle sponde del fiume Donec, oggetto di contesa con la vicina Ucraina e due volte sotto il tiro tedesco nel corso delle guerre mondiali.
L’orrore per la guerra impregna forte i muri di Belgorod. Deve averne sentito l’influenza sin da piccolo anche Alexey Shved, che per esorcizzare quel vago malessere che sembra spesso velarne lo sguardo ha preso a far suoi i racconti di Erich Maria Remarque, il romanziere tedesco che coi suoi racconti dal fronte divenne un nemico pubblico del nazismo. “Mi piace molto leggere, in particolare i suoi libri”, dice quello che oggi è l’emblema di un basket russo alla ricerca disperata di una nuova primavera.
Prima un anatroccolo che attendeva di diventare grande. Poi un cigno triste, incapace di adattarsi ad un mondo non alla sua misura. Shved è sembrato per tanti anni semplicemente fuori luogo: incompreso, incomprensibile. Come se mancasse sempre qualcosa. “È il concetto che cercavo di passargli quella volta e cercai di spiegarglielo – mi spiegò Ricky Rubio la scorsa estate – stava giocando male in quel periodo e non era sereno. Quello che volevo fargli capire era: siamo due ragazzini europei allo Staples Center con 20 mila persone a guardarci giocare con la canotta di una squadra NBA contro Kobe Bryant. Lui non si stava godendo quel momento. Tutte le stats, tutti i giochi, tutti i blablabla non contano niente se non ti gusti questi momenti”.
Il manifesto dell’Alexey Shved pre-Khimki:
Eppure la sua è stata una carriera da predestinato sin dalla tenerissima età: con padre allenatore e madre e sorelle giocatrici non poteva essere altrimenti. “Ho iniziato a giocare che avevo 6 anni. Quando non ero in palestra, ero in strada a giocare. Da allora ho iniziato ad allenarmi due volte al giorno e non ho praticamente più smesso”. Poco studio, al massimo un po’ di videogiochi. “Mi piace giocare alla PlayStation ogni tanto, quella dei videogiochi era una passione che avevo anche da piccolo. Ricordo ancora la prima paghetta: 50 dollari, li guadagnavo riciclando bottiglie, lo facevamo tutti negli anni Novanta. Con quei soldi compravo un po’ di cioccolata, una cassetta della Sega o un joystick”.
Chissà se avrebbe mai immaginato che, vent’anni dopo, dietro quello zero ce ne sarebbero stati parecchi altri sul suo contratto che lo lega al Khimki: oltre 3 milioni all’anno che ne fanno il giocatore più pagato d’Europa. Un peso mica da ridere per un giocatore etichettato troppe volte come un perdente di successo. Anche se parliamo di un giocatore medaglia di bronzo olimpica (2012, Russia) e vincitore dell’Eurolega (2008, Cska). “Ho sentito persone dire “ha vinto un’Eurolega ma senza giocare”. Ma io l’ho vinta quella Eurolega. Avevamo un grande team e una fantastica chimica di squadra, con molti dei ragazzi ancora sono in contatto. Vincere quel trofeo, quando avevo vent’anni, mi ha lasciato tanti bei ricordi. È vero, ero giovane e non giocavo molto. Ma questo è solo uno stimolo in più per provare a vincerla ora, col Khimki”.

D’altronde, quello era il Cska di JR Holden e Theo Papaloukas, di Trajan Langdon e Ramunas Siskauskas, con Ettore Messina che pilotava dal pino anche la crescita del giovanissimo Alexey, sbarcato a Mosca non ancora 18enne dopo qualche anno non proprio semplicissimo a San Pietroburgo. “Ho imparato come essere indipendente a San Pietroburgo. Quando vivevo a Belgorod, tornavo a casa per cena ogni sera, trovavo il letto caldo e tutto il resto. Ma lì cambiò tutto. Avevo solo il tempo per mangiare. Se facevo tardi ad allenamento, non mangiavo. Dovevo lavare i vestiti e i piatti. Non credo che molti ragazzi lo amassero a 14 anni. Ma quando arrivai al Cska, a 17 anni, ero in estasi. Potevo allenarmi con gente che andavo a vedere alle partite. Erano i miei idoli. Ero un po’ intimorito all’inizio, poi andò meglio”.
E in mezzo a tutti quei campioni ovviamente Shved ci mette un po’ a farsi strada. Nei primi tre anni e mezzo al Cska, dal 2006 al 2009 (con un breve intermezzo di 13 partite al Khimki che serve giusto a fiutare l’aria per il futuro), quel ragazzino che viene dal sud gioca appena 14 partite in Eurolega, segnando poco più di 2 punti a partita. È dura trovare posto tra tanti fenomeni, ma Alexey cresce, come giocatore e come uomo. E i primi soldi veri fanno comodo. “Comprai la mia prima macchina a 18 anni. Era una Honda CR-V. Ce l’ho ancora. O meglio, ce l’ha mio padre in garage”.
Le cose iniziano a cambiare nel dicembre 2009, quando il Cska lo spedisce in prestito alla Dynamo. “Sono triste perché lascio la mia squadra, i miei amici, quelli con cui amo giocare e vivere. Ma la cosa più importante è che avrò più spazio per giocare e sono pronto a farlo in ogni posizione il coach vorrà”. E Alexey si presenta portando come biglietto da visita un esordio da 16 punti e 8 rimbalzi nella sconfitta interna contro Treviso in Eurocup. La Dynamo farà poca strada in Europa e in Superliga si fermerà in semifinale piegandosi con un secco 0-3 proprio al Cska, ma in entrambe le competizioni Shved va sopra la doppia cifra di media, dimostrandosi pronto a contribuire alla causa della casa madre. Le due successive stagioni all’Armata Rossa non sono fortunatissime a livello di squadra, anche se a livello personale sono quello che lo consacrano nuovo astro nascente del basket europeo. Una partita su tutti accende i riflettori su quel capellone smilzo che fa canestro con una semplicità disarmante: la semifinale di Eurolega 2012 contro il Panathinaikos, sulla quale l’allora 24enne mette il suo timbro a fuoco:
Come però capita spesso tanto al Cska quando a lui, l’opera non si completa due giorni dopo nella celeberrima finale contro l’Olympiacos che, di fatto, segna anche la fine della sua prima carriera europea: Printezis cancella i sogni di gloria moscoviti a fil di sirena dopo una rimonta pazzesca e Shved praticamente non si vede, fermandosi appena a 3 punti.
Il futuro però è già arrivato, riservando il coronamento di un sogno: la NBA lo aspetta a braccia aperte perché, pur senza essere mai stato scelto al draft, i Timberwolves seguono il consiglio di Andrej Kirilenko e decidono di portare a Minneapolis sia l’uno che l’altro. “Amavo la NBA da bambino. Non avevamo internet, ma avevamo le VHS, potevo guardare una stessa partita 200 volte. Quando arrivai nella Lega, alcuni dei giocatori che guardavo si erano già ritirati, ma alcuni diventarono miei compagni di squadra”. Incrocio fallito anche il suo idolo, Allen Iverson. “Era un genio. Sì, non ha mai vinto un titolo ma poteva battere una squadra da solo. Credo sia stato il giocatore tecnicamente più dotato nella storia della NBA”.
Prima della NBA, però, c’è un altro sogno tramutare in realtà: dare alla Russia post-sovietica la prima medaglia olimpica. Shved e Kirilenko, che in maglia Cska sono diventati amicissimi, sono le punte di diamante di una squadra che, un anno prima, si era già presa il bronzo europeo in Lituania. A Londra tutti aspettano il rematch della super sfida Usa-Spagna, a fari spenti i russi piombano fino in semifinale trascinati di peso dal duo “americano” (“Se sono nei panni dei Timberwolves, ora ho un grosso, grasso sorriso sulla mia faccia”, dice David Blatt, all’epoca ct della Russia) e, come da copione, sono costretti ad inchinarsi agli iberici in missione. Si va per il bronzo, la medaglia degli umani. Ma c’è da giocarsela contro l’Argentina dorada. Una partita incredibile, che sulla quale i russi mettono le mani nel terzo quarto portandosi a +11 prima di subire la reazione dell’albiceleste. Ginobili firma il sorpasso con un canestro in traffico dei suoi a 44” dalla sirena, poi Shved decide di coronare una partita da 25 punti (13 nell’ultimo quarto) con la giocata che vale game, set, match and medal. “Mi piace riguardare quella partita. Ricordo ogni momento, ma mi piace lo stesso riverdermela. A volte un video, a volte per intero. Penso che nessuno credesse che potevamo battere l’Argentina. Nessuno, eccetto noi, i nostri parenti e i nostri fans. Solo la scorsa estate a Eurobasket siamo tornati a giocare del basket a quel livello, anche se non abbiamo vinto una medaglia”.
https://www.youtube.com/watch?v=5EmPvecmbA4
[Ok, difesa di Prigioni e Scola rivedibile ma mettetelo voi quel tiro lì]
Due indizi, una prova. Un’Eurolega da protagonista, una medaglia olimpica al collo. Più talento e cojones. L’America sta aspettando. “Era uno dei miei grandi sogni. Ci andai per la prima volta che avevo 7 anni, ad Atlanta per le Olimpiadi. Ancora ricordo bene le montagne russe e tutto il resto”.
Ma quel Minnesota le cui sconfinate steppe somigliano tanto a quelle russe non si rivelano un mondo per nulla facile da digerire per per il cigno venuto da Mosca. Eppure la sua prima stagione ai Timberwolves è più che discreta: 8,6 punti (anche se la percentuale dal campo dice 37,2%), 2,3 rimbalzi, 3,7 assist in 23,9 minuti, non male per un rookie europeo in una squadra semidisastrata.

È nell’estate 2013 che qualcosa si rompe. Forse la dipartita di AK47, che lascia i Timberwolves per i Nets (“Lui parlava ad Alexey tutto il tempo, ed in russo, ora non c’è nessun altro che possa farlo”, spiegava all’epoca coach Rick Adelman), sta di fatto che il rendimento di Shved precipita anziché migliorare: il minutaggio è più che dimezzato (10,5 minuti), ovviamente lo sono anche i punti (4,0) ma anche la percentuale dal campo peggiora ulteriormente (un orrido 32,1%). Sembra che i Monstars gli abbiano aspirato via il talento. “In America pensare a tutte le piccole cose della vita di tutti i giorni è più dura che giocare. Una volta che firmi un contratto in Russia, c’è chi ti aiuta a trovare un appartamento e la squadra può metterti a disposizione una macchina, persino un autista, e sistemare ogni piccola cosa fuori dal campo. In NBA non è così. Devi fare tutto da solo, persino farti la spesa”.
E’ triste Alexey, è triste in campo, è triste fuori. E la NBA vive di competizioni feroci, se non hai la forza di reagire ai momenti duri vieni travolto dalla fame degli altri. Minnesota è in pieno rebuilding e non ha tempo di aspettare che il cigno regredito ad anatroccolo torni sé stesso, così lo inserisce nell’affare Kevin Love, spedendolo ai 76ers per bilanciare la trade che porta la star della squadra alla corte del Re di Cleveland. A Philadelphia non va nemmeno malissimo (17 partite a 9,9 punti di media), ma nemmeno il tempo di disfare la valigia e viene spedito prima ai Rockets, quindi nei depressi Knicks, dove comunque gioca il suo miglior basket del periodo americano (16 partite a 14,8 punti, 4,6 rimbalzi e 3,6 assist a sera). Poi però ci si mette pure la sfiga: ginocchiata ad una costola da Patrick Patterson nel match contro Toronto che arriva dopo tre partite in fila sempre sopra quota 20 punti e stagione finita con un mese di anticipo.

Non è un amante dei viaggi, Alexey. Stare col trolley sempre pronto non è nell’indole di un ragazzo fattosi uomo leggendo libri, andando a teatro e facendo lunghe passeggiate. Per questo il ritorno in Europa, nell’estate 2015, diventa presto molto più di un’ipotesi. Si fa avanti il Khimki e lo fa con un’offerta cui è impossibile dire di no. “Sono tornato in Russia per molti motivi diversi. Le continue trade sono state un fattore. Un giorno sei in una città, ricevi una chiamata e devi muoverti da qualche altra parte e aggregarti ad un’altra squadra. Non mi è sempre piaciuta questa cosa. Gradualmente ho iniziato a pensare di tornare. La Russia era la mia prima opzione. Avevo offerte da squadre di Eurolega turche e spagnole, ma volevo giocare a casa. La chiamata del Khimki ha messo tutti i tasselli al proprio posto”.
Tornato il sole, torna a scintillare in tutto il suo splendore il talento di quel cigno diventato nero nel tragitto verso la tanto sognata America. Quelle ampie falcate con le quali divora il campo per involarsi verso il ferro dopo aver catturato il rimbalzo, le triple senza ritmo quando i centimetri per prendersele sono vicino allo zero, i passaggi illuminanti, ma soprattutto quel sorriso che Rubio non vedeva sul suo volto da quel dì allo Staples Center.
Ritrovata la serenità fuori dal campo, ora però la sfida è di quelle toste sul parquet: spezzare lo strapotere dall’amato Cska in patria e portare il Khimki ad essere una credibile contender per l’Eurolega. Roba mica da ridere. Il primo tentativo, nel 2015-2016, va a vuoto: in VTB il Cska spegne in semifinale gli ardori del Khimki travolgendola per 3-0, mentre in Eurolega la corsa di ferma ad un passo dai playoff, con i russi a steccare lo spareggio per entrare nelle fantastiche otto sul campo del Real Madrid all’ultima giornata di Top 16. Complice anche una serataccia di Shved (1/8 da 3 per appena 6 punti). “Gioca solo per sé stesso”. “Non è decisivo”. Le critiche si sprecano, anche se a inizio Top 16 si era preso la soddisfazione di matare proprio il Cska nel derby con una giocata che ricorda tanto quella di Londra ’12.
Il titolo di MVP della passata stagione di Eurocup, pur con il Khimki stoppato nei quarti dal Valencia, non fa che rinfocolare la voce di coloro che lo vedono solo come uno splendido solista. “Nessuno è popolare con tutti. Ci sono persone che ti odiano anche se neanche le conosci e se non hai fatto loro niente di male. E ci sono persone che ti amano. Per cui non mi preoccupo troppo quando la gente parla male di me”. Anche lo scorso EuroBasket, nel quale dal nulla la Russia è uscita fuori alla distanza fermandosi solo ad un passo dal podio con uno Shved clamorosamente dominante (inserito con pieno merito nel quintetto ideale della manifestazione) è parso l’ennesimo boccone agrodolce di una carriera che, alla soglia dei 30 anni, è ancora ferma allo stadio di meravigliosa incompiuta.
Il nuovo corso firmato Bartzokas sembra aver segnato uno nuovo passettino in avanti nella crescita del Khimki e di Shved, sempre più consapevole leader della squadra che ora chiama “famiglia”. “Andiamo step by step. Cerchiamo di vincere ogni partita e vediamo cosa succede. Quello che posso dire è che nel club c’è un’atmosfera davvero speciale e io amo esserne parte, essere parte di questa famiglia. Coach Bartzokas è una grande persona ed un grande allenatore, parliamo molto, non solo con me ma con tutti i giocatori. Abbiamo tanti ragazzi che vengono dalla NBA o dai grandi club europei e cinesi. Sono convinto che siamo una grande squadra, abbiamo solo bisogno di stare insieme e guardare partita dopo partita. Il primo obiettivo sono i playoff di Eurolega, poi vediamo come si mette”.
Al momento di scrivere, il bersaglio minimo sarebbe centrato: il Khimki è 7° con un record di 8-7 e Shved sta giocando decisamente il miglior basket della sua carriera, viaggiando spedito verso l’Alphonso Ford Trophy con oltre 21 punti a partita di media (Doncic, 2°, ne mette 3 in meno) e mostrandosi sempre più a suo agio nel ruolo di leader cucitogli addosso dall’allenatore greco. Chiedete a Milano, che ne ha subito l’ira funesta qualche settimana fa: 29 punti (career-high), 18 nel secondo tempo e Forum che può solo inchinarsi allo strapotere dell’uomo venuto da Belgorod.
Camminando mano nella mano in Piazza Rossa con l’amata Nastya, disegnando con lei i nuovi capi della sua nuova linea di abbigliamento o assistendo ai musical del teatro Bolshoi, quel velo di tristezza che gli annebbiava il volto sembra dissolto nel gelo dell’inverno moscovita. Le tante prestazioni sopra le righe, i tanti riconoscimenti, le tante battaglie ne hanno temprato lo spirito e liberata la maestria che scorga fluente dalle sue mani. Purtroppo, però, la guerra è ancora lontana dall’essere conclusa sul fronte occidentale. Niente di nuovo, caro Alexey.
N.B. l’intervista è stata integrata con alcune dichiarazioni rilasciate tempo fa in questo pezzo di VTB-LEAGUE